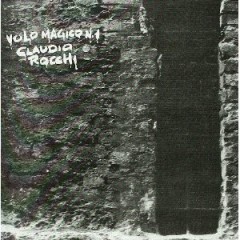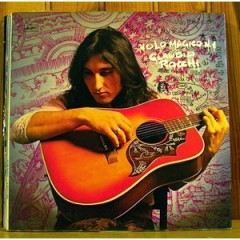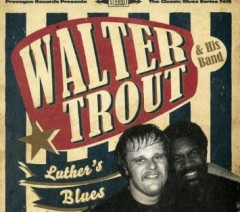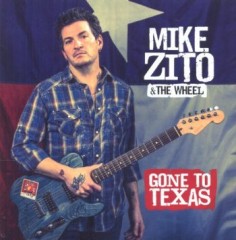Egidio Juke Ingala & The Jacknnives – Tired Of Beggin’ – Vintage Roots Rec.
Spesso gli “scribacchini” della carta stampata e non, tra cui includo anche il sottoscritto, si devono fare largo tra centinaia, anzi migliaia di album, che ogni anno continuano a inondare un mercato discografico sempre più asfittico. E ancora più spesso la scelta di cosa parlare e di cosa no, aldilà dei gusti personali, è ristretta anche dalla non facile reperibilità dei prodotti, sempre più auto gestiti dagli artisti stessi. Un CD di produzione indipendente italiana è più difficile da rintracciare di equivalenti prodotti inglesi ed americani (non sempre) e quindi, avendo tra le mani, questo nuovo “disco” di un gruppo italiano (tradito solo dal nome di battesimo del leader), mi accingo a rendervi edotti del tutto.
Intanto Egidio Juke Ingala è attivo discograficamente da un paio di decadi, ma in questa configurazione con i Jacknives si tratta di una prima. Armonicista e cantante, con trio al seguito, qui parliamo di Blues, anzi, come orgogliosamente proclamano sui loro manifesti “Old School Blues With a Swingin’ Feel”. Quindi cover e brani originali, sette per categoria, che sembrano uscire da vecchi vinili degli anni ’50, e soprattutto dal repertorio di etichette super specializzate come la Excello, la Specialty e la Chess Records, ma non i brani più noti, sarebbe troppo facile, quelli proprio oscuri che solo un grande appassionato può scovare. Naturalmente questo restringe e di molto la cerchia dei possibili fruitori ma non la qualità dell’album. Anche l’abbigliamento sfoggiato nelle foto di copertina, rigorosamente in bianco e nero, e la strumentazione, dove la presenza di un basso elettrico è una concessione alla “modernità” dilagante, sono sintomatiche dell’approccio rigoroso alla materia trattata.
Direi che per il leader della band, Egidio Ingala, tutto parte dallo studio di una trinità di armonicisti, Big Walter Horton, Little Walter e George Harmonica Smith (vi chiederete come faccio a saperlo? Semplice, l’ho letto nella piccola cartella stampa allegata al CD, come diceva Mourinho, non sono mica pirla) e poi da lì, con la passione e pedalando in giro per gli States e l’Europa, tra Festival vari, ti costituisci una tua reputazione, incidi dischi, cerchi di farli conoscere e quindi un “aiutino” nella diffusione del verbo è sempre gradito, immagino. L’Electric Chicago Blues e lo swing della West Coast, che non è quella acida e country degli anni a venire, almeno per loro, sono gli ingredienti principali di questo Tired Of Beggin’, sia nei brani originali come nelle cover. Il sound è quello tipico di altri neo-tradizionalisti americani, direi che per fare un paragone conosciuto a molti, sono dei Fabulous Thunderbirds meno moderni, ma è per semplificare al massimo e spero sia un complimento.
Proprio l’iniziale Winehead Baby viene da quelle coordinate, con quella sua atmosfera vagamente indolente da New Orleans inizio anni ’50, quando Dave Bartholomew con il suo amico Fats Domino inserivano elementi R&B e R&R nel blues, ma l’assenza del piano e la presenza preponderante di armonica e chitarra fanno sì che il brano abbia un suono decisamente più bluesato. I’m Tired of Beggin’ con il suo cantato leggermente distorto e i ritmi più mossi, viene dalla produzione di Ike Turner, che aveva “inventato” il R&& da poco con Rocket 88 e qui c’è spazio per la chitarra rockabilly di Marco Gisfredi, l’altro solista della band insieme a Ingala. Hey Little Lee, con un cantato leggermente “sporcato” da un leggero eco viene dalla produzione di James Moore, per gli amici (del blues) Slim Harpo. Cool It è uno strumentale swingato scritto da Gisfredi che si ritaglia uno spazio jazzy per la sua chitarra ma ne lascia ampiamente anche all’armonica.
In Last Words Ingala rende il favore, a tempo di shuffle mentre Come Back Baby ha la struttura da pezzo da big jump band ma viene adattato per quartetto. Fallen Teardrops è il classico slow blues d’ordinanza, un altro strumentale scritto da Ingala in tributo a Mastro George Smith, con il solito spazio anche per la chitarra dopo il lungo assolo dell’armonica cromatica. Don’t say a word è più grintosa e cattiva ed è seguita da un brano firmato dal bassista Massimo Pitardi e quindi con un ritmo più funky, qui direi che siamo “addirittura” negli anni ’60! Anche I’m Leaving You è più elettrica, un Howlin’ Wolf minore, qui mi si sembrano i Dr. Feelgood o i Nine Below Zero o se vi sembrano troppo “moderni”, i primissimi Yardbirds o Stones. Per non fare la lista della spesa delle canzoni l’album è validocomunque nella sua interezza e si conclude con Back Track., un omaggio a Walter Jacobs, altro amato componente della trinità dell’armonica. Verrebbe da dire, per Special(is)ty del Blues. Bravi!
La “ricerca” prosegue.
Bruno Conti