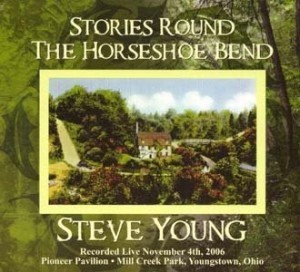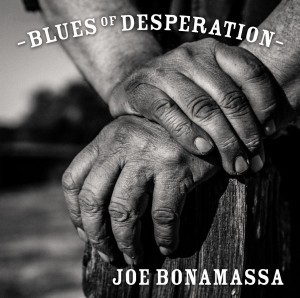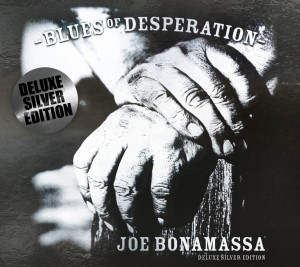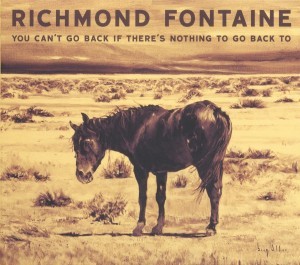Randy Rogers Band – Nothing Shines Like Neon – Tommy Jackson CD
La Randy Rogers Band, attiva da una dozzina d’anni, è oggi uno degli acts più popolari in Texas, ed anche fuori dai confini del Lone Star State, un successo ottenuto senza mai svendersi o modificare il proprio suono a favore delle classifiche e delle radio di settore. La band è ormai affiatata, suona a memoria, ed è comprensibile dato che non ha mai avuto cambi di personale: oltre a Rogers, abbiamo i soliti Geoffrey Hill alla chitarra solista, Jon Richardson al basso, Les Lawless alla batteria e Brady Black al violino; il loro suono, un rockin’ country deciso ma con una propensione alla melodia non comune, è maturato disco dopo disco e, dopo la parentesi solista di Rogers insieme a Wade Bowen lo scorso anno con il divertente Hold My Beer, Vol. 1, abbiamo tra le mani il loro settimo album di studio, intitolato Nothing Shines Like Neon.
Chi ha apprezzato le precedenti fatiche della RRB non mancherà di farlo anche con questo lavoro, che forse spinge meno l’acceleratore sul rock ed è un filo più country, anche perché il produttore è il grande Buddy Cannon, uno dei principali artigiani del suono in questo genere, già dietro la consolle in passato per Willie Nelson, Merle Haggard, George Jones, George Strait, Kenny Chesney e moltissimi altri. Nothing Shines Like Neon forse non è il disco migliore della RRB, ma di sicuro insidia le prime posizioni e comunque si colloca ben al di sopra della media delle uscite mensili in ambito country (soprattutto quelle che arrivano da Nashville), grazie anche ad una manciata di ospiti illustri (che scopriremo strada facendo) che aggiunge prestigio ad un lavoro già più che positivo. San Antone apre il CD, una western ballad molto ben costruita, con una melodia ad alto tasso emozionale, un languido violino ed una ritmica spedita, un inizio forse non roboante ma sincero ed autentico. Rain And The Radio, più diretta e cadenzata, ha elementi più sudisti che texani, ed un bel ritornello limpido, mentre Neon Blues è country-rock d’autore, un bel brano elettrico dal refrain godibile, un tipo di canzone che a Rogers riesce particolarmente bene, con un appeal anche radiofonico ma senza scadere in personalità.
La potente Things I Need To Quit è una ballata elettrica di spessore, nella quale Randy ed i suoi pards suonano distesi e rilassati, ma senza perdere un’oncia di feeling; Look Out Yonder vede Alison Krauss ed il suo collega Dan Tyminski alle armonie vocali, ed il brano è una gentile oasi elettroacustica, con un ottimo ritornello corale, uno dei più riusciti del lavoro, mentre con la tersa Tequila Eyes torniamo sul versante country-rock, anche se non manca una nota di malinconia nel motivo. Takin’ It As It Comes vede il nostro duettare con il grande Jerry Jeff Walker (un pezzo di storia del Lone Star State), un travolgente brano che potrebbe benissimo appartenere al repertorio dell’autore di Mr. Bojangles, puro Texas rock’n’roll; Old Moon New è un languido slow, toccante ed eseguito con grande trasporto, un intermezzo più che gradito, seguito a ruota da un’altra ballata ancora migliore, Meet Me Tonight, che ha un piede negli anni sessanta ed il solito refrain scorrevole. La maschia e grintosa Actin’ Crazy, di e con Jamey Johnson (quindi garanzia di qualità) ed il puro country di Pour One For The Poor One, quasi un honky-tonk rallentato, chiudono l’ennesimo disco positivo per una band sulla quale ormai possiamo contare ad occhi chiusi.
Marco Verdi