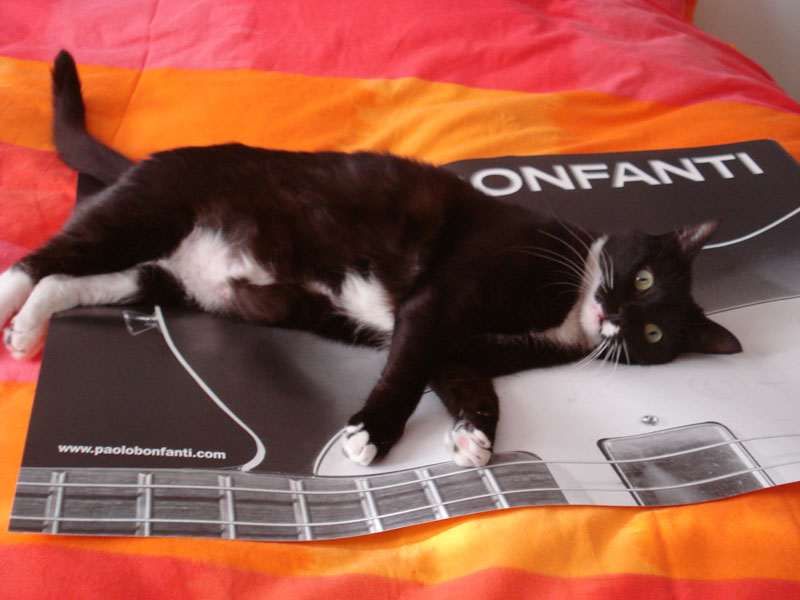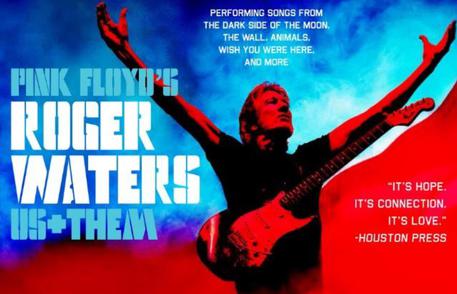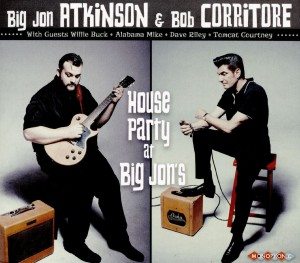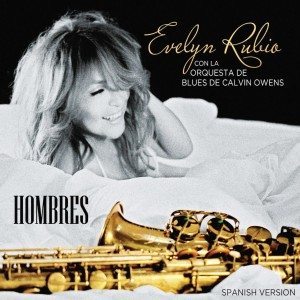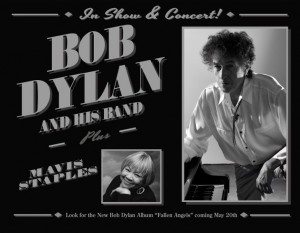Paolo Bonfanti – Elastic Blues – Rust Records CD + Libro
Da quando Paolo Bonfanti, detto il Bonfa, iniziava a muovere i primi passi nell’ambito delle 12 battute, in quel di Genova (anzi Sampierdarena), prima come fan, e poi come membro dei Big Fat Mama di Piero De Luca, è passato qualche annetto. Appena prima, durante e dopo, potrei sbagliare la cronologia, c’era stata la Hot Road Blues Band, in una era in cui non era ancora stato inventato il CD e la musica usciva su vinile, detto LP (al limite anche in cassetta e persino Stereo8) e in Italia c’erano due principali scuole di praticanti del blues, quella di Milano e quella di Roma: della prima faceva parte Fabio Treves, con la sua band, della seconda era capostipite Roberto Ciotti, ma c’era anche qualche deviazionista in Veneto, leggi Guido Toffoletti e Tolo Marton, agli inizi nelle “progressive” Orme, e a Genova, nei primi anni ‘70, c’erano stati i Garybaldi di Niccolò “Bambi” Fossati, noto epigono Hendrixiano, con un wah-wah al posto del cuore. Tutto questo, e moltissimo altro, lo potete leggere nel bellissimo libretto che accompagna questo Elastic Blues (che io ero convinto, pensate, fosse un disco dei Nucleus), dove tra aneddoti e brevi storie Paolo ci ricorda cosa è successo nei ultimi 40 anni della sua vita, anzi non solo nella musica, quindi 60 in totale.
Inaugurata con gli studi di pianoforte a metà anni ‘70, proseguita più convintamente con la conversione alla chitarra, grazie ad Armando Corsi e Beppe Gambetta, grande virtuoso dell’acustica, ancora in pista oggi, e poi con l’ingresso in quei Big Fat Mama, nati nel 1979, di cui Bonfanti diventerà il chitarrista solista e frontman dal 1985 al 1990. Ovviamente nella penisola italica c’erano anche altri musicisti che suonavano il blues, cito a caso, Rudy Rotta, Fabrizio Poggi, i Mandolin Brothers di Jimmy Ragazzon, Angelo “Leadbelly” Rossi, i Model T. Boogie, dai quali passerà Nick Becattini, Aida Cooper, moglie di Cooper Terry, i Blues Stuff della scuola napoletana, da cui provenivano anche Edoardo Bennato e Pino Daniele, che avevano anche molto blues nelle loro corde: ce ne sarebbero moltissimi altri, ma è meglio se mi fermo, se no diventa un trattato, neppure breve. La carriera da solista di Bonfanti inizia nel 1992, per cui facciamo un Fast Forward verso il futuro e arriviamo al 2015 in cui esce l’ottimo CD dal vivo Back Home Alive, l’ultimo in ambito rock-blues https://discoclub.myblog.it/2015/09/07/la-via-italiana-al-blues-1-paolo-bonfanti-back-home-alive/ , mentre nel 2019 viene pubblicato Pracina Stomp, insieme all’amico Martino Coppo, il secondo in coppia, disco elettroacustico nel quale sono prodotti dal bravissimo Larry Campbell, a lungo collaboratore di Levon Helm, che Dio lo abbia in gloria : in mezzo c’è stato molto altro, ma concentriamoci sui contenuti di Elastic Blues, che è una sorta di “riassunto” delle puntate precedenti, un sequel e un prequel contemporaneamente, con la presenza di molti amici come “ospiti”.
Un” collega” omonimo di Paolo, le altre foto seguenti nell’articolo sono di Guido Harari.
Come dice la presentazione dell’album, che riporto integralmente
10 mesi di lavoro in piena pandemia, 40 musicisti coinvolti (compreso l’autore), 60 anni, 70 minuti di musica, 80 pagine di libro, 15 brani inediti, 1 cover, una campagna di co-produzione dal basso che ha ampiamente doppiato la cifra inizialmente richiesta; la prefazione di Guido Harari e molto altro per questo “Elastic Blues” che non è solo musica ma anche un libro di memorie, riflessioni, introduzione ai pezzi e traduzione dei testi, impreziosito dalle immagini e dalla grafica di Ivano A. Antonazzo.
Vediamo i 16 brani del disco del mancino chitarrista genovese: si parte “stranamente” con il prog-rock misto a trip psichedelico di ALT!, che non è un ordine della pattuglia che ti controlla per vedere se sei in giro in violazione del lockdown, ma è tedesco che sta per “vecchio” in contrapposizione a Neu: quasi otto minuti di uno strumentale che miscela Grateful Dead e King Crimson (magari anche i Nucleus che citavo prima, con alla chitarra l’ottimo Chris Spedding), sezione ritmica ufficiale dell’album Alessandro Pelle, batteria e Nicola Bruno, basso, con l’aiuto di Yo-Yo Mundi assortiti, tra chitarre elettriche stranianti ed assolo di basso spinto di Andrea Cavalieri. D’altronde al 21st Century ci siamo arrivati, e quindi il progressive buono si ascolta sempre volentieri, specie se va a questi ritmi vorticosi. E anche The Noise Of Nothing, un duetto tra chitarra acustica e fisarmonica di un altro fedelissimo come Roberto Bongianino (che però suona come un organo, ricorda Paolo nelle ricche note del CD) forse col blues, non c’entra molto, ma mi ha ricordato certe sperimentazioni gentili di Richard Thompson con John Kirkpatrick, più spinte verso “l’altro”.
E un po’ di jazz non ce lo vogliamo mettere? Magari il Jazz-rock di Haze, l’unica cover del CD, un brano di Bobby & The Midnites, una strana formazione che univa Bob Weir dei Dead, Bobby Cochran, quindi doppia chitarra, con Billy Cobham alla batteria e Alphonso Johnson al basso, più Brent Mydland anche lui dei Dead alle tastiere, sulla carta fantastici, i dischi, a mio parere, molto meno riusciti, anche se questo brano, registrato con la band anni ‘90 di Paolo, approda verso un robusto funky jazz-rock che ha anche qualche parentela di elezione con il sound dei Little Feat, e poi, a furia di tirare l’elastico della musica, si approda alla canzone d’amore In Love With The Girl, solo voce, chitarra acustica, un insinuante violino e la bella voce di Bonfanti, che poi mischia nuovamente le carte in Unnecessary Activies, dove suonano in metà di mille (facciamo una quindicina di musicisti, giro AnanasnnA, più Lucio Fabbri al violino) per un funky-jazz-rock che mi ha ricordato certe cose di James “Blood” Ulmer, segue una giravolta di 360° e arriva la pedal steel di John Egenes per Heartache By Heartache, una outtake di Pracina Stomp, una delicata ballata che profuma di country. Poi si ritorna al rock quasi da power trio, con seconda solista aggiunta nella potente Don’t Complain con la chitarra di Gabriele Marenco, come direbbero gli americani “all over the place” per un assolo cattivo il giusto, con wah-wah fumante. E non manca neppure la canzone in dialetto genovese, una Fin De Zugno ispirata dai moti anti Tambroni del 1960 contro un governo che voleva inserire i fascisti nel governo (la Meloni ce lo ha risparmiato), solo voce, chitarra acustica e un quartetto d’archi gli Alter Echo String Quartet, per un brano molto alla De André .
Già, ma il Blues? Ci sta, ci sta! In We’re Still Around, brano dal titolo quantomai esplicativo, tornano i Big Fat Mama, con tanto di duello con doppia chitarra, nel caso Maurizio Renda, per un pezzo che profuma di rock sudista, di quello buono. A O Canto, sarebbe On The Corner in genovese, sarà mica un disco di un certo Miles Davis? Mi sa di sì, doppia batteria, fiati in evidenza, Aldo De Scalzi, altro genovese doc (fratello di Vittorio dei New Trolls) ad un piano elettrico che tanto ci ricorda Chick Corea scomparso di recente, con la chitarra di Paolo molto “lavorata”, e visto il titolo del disco ci metto anche il sound di quei Nucleus ricordati prima. Hypnosis, per due chitarre acustiche, azzardo, potrebbe essere dalle parti del primo John Martyn, quello che non aveva ancora scoperto l’Echoplex, per quanto qualche effettuccio in questo brano malinconico c’è; in I Can’t Find Myself, canzone di Paolo del 2004, che ci suona tutti gli strumenti, esclusa l’armonica, affidata a Fabio Treves, che non poteva mancare alla festa per i 60 anni, in questo shuffle classico, tra Chicago e Texas, ma anche qualche tocco di British Blues o della Butterfield Blues Band.. Ottimo anche l’omaggio al Gumbo, il New Orleans Sound gemellato con quello genovese e napoletano in Sciorbì/Sciuscià, fiati a go-go dei Lambrettas (ma non facevano ska? Ah no quelli inglesi) e la fisarmonica di Roberto Bongianino, per un brano che fa muovere i piedi.
La title track, per quelli che parlano bene, va verso territori dove il blues si fa futuribile, ma anche retrò (in senso positivo), tra fisarmonica e la seconda chitarra di Matteo Carbonicini che divaga con quella di Paolo in questo complesso pezzo strumentale. Per Where Do We Go https://www.youtube.com/watch?v=0WDJWqylWpc Bonfanti nelle note del libretto parla di Van Morricrosby (questa prima o poi me la rigioco), in quanto l’ispirazione era quella di ricreare atmosfere tra Van Morrison, David Crosby e Ennio Morricone, e mi pare ci sia riuscito, anche se sapete che Van The Man parte avvantaggiato, perché da giovane ha ingoiato un microfono e quindi quella voce non è replicabile, ma il risultato finale è eccellente. Finito? Quasi, come insegnava Mastro Jimi ci vorrebbe un bel Slight Return, applicato a Unnecessary Activies, virato, vista la forte presenza di fiati, alla musica di Hendrix ripresa da Gil Evans nel suo celebre omaggio. Tutto molto bello, magari tra 60 anni uscirà il secondo capitolo, per ora se può interessare lo potete comperare sul suo sito, oppure qui https://paolobonfanti.bandcamp.com/album/elastic-blues. Ne vale assolutamente la pena.
Bruno Conti
P.s Ora attendiamo We’ll Talk About It Later (questa la capiranno in pochi, è il titolo del secondo disco dei Nucleus).