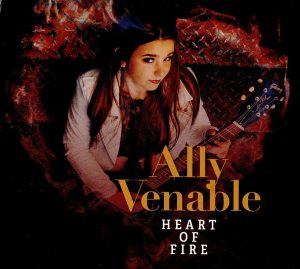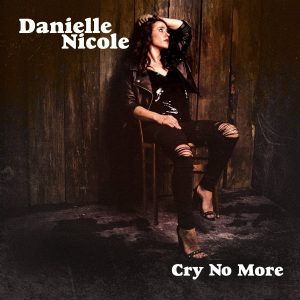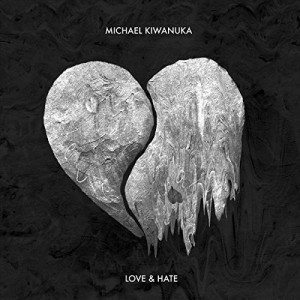Ally Venable – Heart Of Fire – Ruf Records
Evidentemente Mike Zito, che le aveva prodotto il precedente Texas Honey, uscito nel 2019 (come anche il Blues Caravan 2019) https://discoclub.myblog.it/2019/05/11/una-donna-chitarrista-da-aggiungere-alla-lista-garantisce-mike-zito-ally-venable-texas-honey/ , era impegnato con le numerose uscite della propria etichetta Gulf Coast Records, e quindi per questo nuovo Heart Of Fire, il quarto album della giovane chitarrista e cantante texana Ally Venable, ci si è affidati alle capaci mani di Jim Gaines, un altro dei maghi della console in ambito blues, lo scorso anno alla guida dello strepitoso Believe, l’album di Albert Cummings https://discoclub.myblog.it/2020/02/11/il-disco-della-consacrazione-per-uno-dei-nuovi-fenomeni-della-chitarra-albert-cummings-believe/ . Per il nuovo album della Venable Gaines ha convocato negli studi di Stantoville, Tennesse una piccola pattuglia di ottimi musicisti, tra i quali spicca il meno noto dei fratelli Dickinson, Cody alla batteria, e qualche ospite in grado di valorizzare alcune canzoni dell’album, che vediamo a breve. I brani sono undici in totale, ben nove firmati da Ally, un paio con l’aiuto di Vance Lopez, tra i quali a mio parere spicca una strepitosa Tribute To SRV, un pezzo strumentale nel quale la 21enne dà libero sfogo alla sua tecnica chitarristica, che non si discute, in un blues lento dove viene evidenziato anche il feeling e il gusto sopraffini che impiega in questa lunga improvvisazione, dedicata a quello che è sempre stato l’eroe musicale della Venable https://www.youtube.com/watch?v=PAzYPlF0Ux4 .
Come già dicevo, parlando del precedente Texas Honey, il punto debole della nostra amica risiede nel fatto di non avere, a mio parere, una voce fenomenale, non scarsa, come si suol dire adeguata, forse un po’ “leggerina”, ma non si può avere tutto nella vita, visto che Ally è anche molto avvenente (anche se da ragazzina era cicciotta, vedi https://www.youtube.com/watch?v=u0T5iu1Eijw . Ma aldilà dei pregi estetici la Venable prosegue nella sua lenta ma inesorabile crescita a livello qualitativo: il repertorio è sempre virato verso un blues-rock robusto anziché no, aggressivo e potente, come dimostra subito con la vorticosa title track, dove il pedale cry baby del wah-wah è subito premuto con vigore, mentre il risultato complessivo è vigoroso e altamente energetico con la band che la segue come un sol uomo ; nella successiva Played The Game, l’atmosfera si fa più swampy, ci si avvia verso le paludi della Louisiana con una insinuante e minacciosa slide, mentre Rick Steff dei Lucero è ospite all’organo, la voce è quella che è, “accontentiamoci” https://www.youtube.com/watch?v=GkL_c7q5YYc ! Ma a dimostrazione che la stoffa c’è, la cover dell’oscuro bluesman anni ‘20 Perry Bradford in Hateful Blues, brano che però cantava Bessie Smith, miscela rigore e fremiti rock, di nuovo con la slide in grande spolvero https://www.youtube.com/watch?v=NC5fLhzfUYU.
Per la successiva Road To Nowhere si fa aiutare da Devon Allman che duetta con lei e aggiunge la sua chitarra in un brano che ha anche un certo appeal southern, misto a un tocco radiofonico che forse le viene dal suo grande amore per Miranda Lambert, altro punto di riferimento, ma quando parte l’assolo di Devon non ce n’è per nessuno https://www.youtube.com/watch?v=p9JfsN4pcpI . Un altro che come axemen non scherza (ma vocalmente non è una cima) è Kenny Wayne Shepherd , che scatena tutta la sua potenza nel vibrante blues-rock di impronta sudista Bring On The Pain, uno dei due scritti con Lopez, dove i due si scambiano sciabolate con le chitarre nella jam strumentale https://www.youtube.com/watch?v=cjhvksgDvT4 e anche nella successiva Hard Change, la seconda scritta con Lopez, una certa vena zeppeliniana viene a galla, con riff a destra e a manca e con la sezione ritmica che picchia di brutto mentre Ally strapazza la sua Gibson con libidine https://www.youtube.com/watch?v=WgsGiUS1xU4 .
E anche in Do It In Heels, a parte il titolo “modaiolo”, prevale la modalità fabbro ferraio e qualche retrogusto vicino alle Heart, che notoriamente erano discepole degli Zeppelin; e pure in Sad Situation non si scherza, wah-wah come piovesse, riff e ritmo che vanno di pari passo, fino al selvaggio ed immancabile assolo che Jimmy Page avrebbe approvato https://www.youtube.com/watch?v=Mlm7UZ5Hd8s . Nell’altra cover, una sorprendente Use Me di Bill Withers, si punta invece sulla raffinatezza, basso funky, congas santaniane (se esiste l’aggettivo), anche se l’arrangiamento complessivo non mi convince del tutto, detto del superbo tributo a SRV, la conclusiva What Do You Want From Me è un’altra orgia di wah-wah, con assolo liberatorio nel finale, ma manca quel quid che altri pezzi hanno. Comunque la ragazza è brava: per chi ama il suo blues ad alta gradazione rock!
Bruno Conti