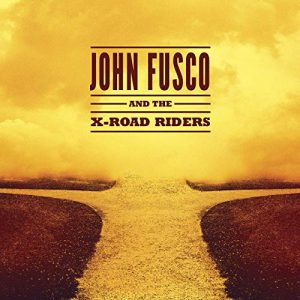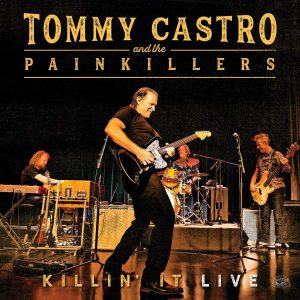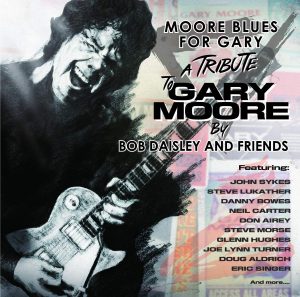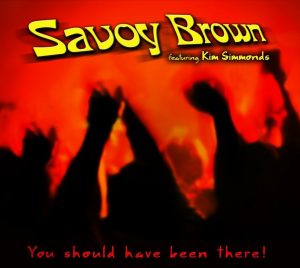Joe Bonamassa – Live At The Sydney Opera House – Mascot/Provogue
Immagino che tutti, come me, foste in trepida attesa di notizie di Joe Bonamassa: scherzo, ma non troppo, stiamo arrivando alla fine del 2019 ed il chitarrista newyorchese al momento non aveva ancora annunciato nessuna pubblicazione discografica per l’anno in corso, dopo che nel 2018, il linea con la sua cospicua discografia, erano usciti ben tre album, l’ultimo Redemption, pubblicato a ottobre https://discoclub.myblog.it/2018/09/17/ormai-e-una-garanzia-prolifico-ma-sempre-valido-ha-fatto-tredici-joe-bonamassa-redemption/ . Persino la sua casa discografica, nell’annunciare il nuovo disco di Joe (perché sta per uscire, ebbene sì, il prossimo 25 ottobre), ci ha scherzato sopra: anche se si tratta di una uscita “strana”, un disco dal vivo, e fin lì niente di inusuale, però registrato ben tre anni fa, nel settembre del 2016, quindi nel tour di Blues Of Desperation, pochi mesi prima del concerto londinese per British Blues Explosion Live. E la cosa più strana è che non si tratta del concerto completo alla Sydney Opera House del 30 settembre del 2016, non ne esistono versioni Deluxe (se non consideriamo il vinile che ha un brano in più) e neppure edizioni in DVD, anche se cercando in rete risulta sia stato filmato.
Peccato perché la location è suggestiva, si tratta di una sala da concerto eletta dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità, dove spesso si svolgono concerti epocali per la musica down under: ho investigato ulteriormente e ho visto che oltre a Livin’ Easy, che è la bonus del doppio vinile, Bonamassa nella parte finale del concerto, non documentata nel CD, ha eseguito una serie di cover rare e sfiziose, Little Girl di John Mayall, Angel Of Mercy di Albert King, If I’m in Luck I Might Get Picked Up, una cover di Betty Davis cantata da Mahalia Barnes, Boogie Woogie Woman di B.B. King, How Many More Times dei Led Zappelin e Hummingbrid di Leon Russell. Sarebbe stato un concerto sontuoso, così è “solo” un bel concerto, perché comunque dal vivo il nostro è sempre una vera forza della natura, ed è accompagnato dalla sue eccellente band, con Reese Wynans alle tastiere, Michael Rhodes la basso, Anton Fig alla batteria, le sezione fiati con Paulie Cerra e Lee Thornburg, e i vocalist di supporto Juanita Tippins, Gary Pinto e la citata Barnes.
Nove brani con una durata media tra i sette e gli otto minuti, oltre a Love Ain’t A Love Song che supera i dieci, quindi ampio spazio per l’improvvisazione e per le scorribande chitarristiche di un Bonamassa in grande serata, che comunque difficilmente, se non mai, dal vivo delude: sono ben sette brani (più la bonus track) gli estratti da Blues Of Desperation, più il lungo brano ricordato, che viene da Different Shade Of Blue, ed una bellissima cover di Florida Mainiline da 461 Ocean Boulevard di Eric Clapton, fiatistica e gagliarda, dal periodo rock’n’soul di Manolenta, con grande assolo di Wynans all’organo e uno fantastico lunghissimo e fluido di un Joe straripante, degno epigono claptoniano. Per il resto l’iniziale This Train cita nel prologo strumentale Locomotive Breath dei Jethro Tull, poi la band inizia a macinare musica alla grande e il nostro rilascia un altro assolo formidabile, Mountain Of Climbing, anche se non ha la doppia batteria della versione in studio, è comunque rocciosa e riffata, molto alla Led Zeppelin, anche Drive ha questo afflato zeppeliniano, inizio lento e guardingo, poi un crescendo tipo Houses Of The Holy, ma con i fiati e le tastiere quasi jazzate e liquide, prima del solito solo tiratissimo.
La citata Love Ain’t A Love Song è il tour de force del concerto, una esplosione di energia e forza dirompente, con le coriste impegnatissime come pure i fiati sincopati e il piano elettrico, fino ad un assolo che parte lento e poi prende energia nella parte finale, How Deep This River Runs, più lenta e scandita è un’altra piece de resistance con la chitarra che imperversa. Della cover di Clapton abbiamo detto, The Valley Runs Low con Joe al bottleneck è una bella soul ballad malinconica ed avvolgente, con Blues Of Desperation siamo di nuovo dalle parti degli Zeppelin, direi periodo Kashmir, anche se l’uso dei fiati lo diversifica da quel sound, benché l’assolo, ancora con uso slide, è molto Jimmy Page. A chiudere un altro ottimo disco dal vivo No Place For Lonely, una lirica hard blues ballad che rende omaggio allo stile di Gary Moore, con un assolo finale da urlo.
Bruno Conti