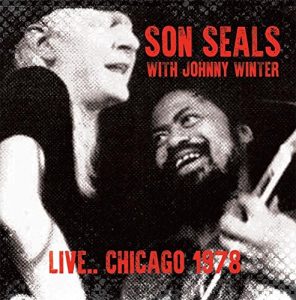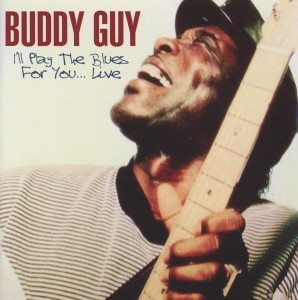Tinsley Ellis – Winning Hand – Alligator/Ird
Tinsley Ellis a memoria d’uomo (almeno la mia) credo non abbia mai sbagliato un disco, forse non ha neppure realizzato un capolavoro assoluto, ma la sua produzione è sempre rimasta solida e di qualità medio-alta: all’interno dei suoi dischi spesso troviamo dei brani veramente strepitosi dove il musicista di Atlanta, Georgia (ma cresciuto in Florida) estrae dalle sue chitarre (sia Gibson che Fender) limpidi esempi dell’arte dell’improvvisazione. In possesso di un fraseggio ricco e corposo, rodato da decine di anni on the road, è il classico prototipo del chitarrista rock-blues, uno che ha fatto del blues elettrico una missione, un “claptoniano” doc che a differenza di Eric non ha mai lasciato la retta via per tentare altre strade più commerciali, anche se il chitarrista inglese gli è indubbiamente superiore per talento e per quanto ha realizzato nella sua carriera. Ma pure Ellis, per chi ama il suono puro della chitarra elettrica nella musica rock, è una certezza assoluta: non a caso nel libretto del CD dove sono riportati i titoli delle canzoni non trovate il nome dell’autore (che a parte un brano comunque è sempre lui) ma i modelli di chitarra che ha usato all’interno del pezzo.
Se aggiungiamo che Tinsley ha pure una eccellente voce, come mi è già capitato di dire in passato (avendo recensito spesso i suoi dischi), una sorta di Chris Rea meno soggetto alle leziosità del musicista britannico; non guasta neppure che il nostro amico utilizzi una band fantastica, con Kevin McKendree alle tastiere, nonché co-produttore dell’album, Steve Mackey al basso e Lynn Williams alla batteria,lo stesso gruppo che usa abitualmente Delbert McClinton. Ellis è anche un fedelissimo della Alligator, ha registrato con loro in tre diversi periodi, ed ora rientra per questo Winning Hand, che forse è il suo miglior disco di sempre, un fior di album di blues elettrico, di quello tosto e grintoso, influenzato dai suoi amori giovanili, Yardbirds, Animals, Cream, Stones, a cui Ellis ha comunque aggiunto forti componenti alla Freddie o alla BB King, e una vocalità che rimanda a gente come Robert Cray. Gli stili utilizzati sono quindi diversi, come le chitarre usate: c’è il sound caldo e intriso di soul dell’iniziale Sound Of A Broken Man, con il continuo lavoro della chitarra di Ellis, ben sostenuta dall’organo di McKendree, che poi sfocia in una serie di assoli dove il timbro “grasso” della Les Paul viene arricchito nel finale da un intervento poderoso con il wah-wah, proprio molto à la Clapton. Saving Grace, indicata nel libretto come ultimo brano, ma in effetti è il secondo sul CD, è anche meglio, un lungo blues lento di quelli che rimandano ai primi Allman Brothers, oppure anche alla splendida Loan Me A Dime di Boz Scaggs dove appunto Duane Allman era la chitarra solista, un po’ più breve, ma l’intensità è quella.
Ancora Gibson per Nothing But Fine, un pezzo più rock anni ’70, con un bel piano elettrico e una andatura ondeggiante, sempre gratificata da continui inserti della chitarra solista limpida e bruciante, splendida nel suo dipanarsi anche in un altro lento da manuale come Gamblin’ Man, di nuovo vicino allo stile del Cray più rigoroso, in ogni caso veramente un bel sentire. I Got Mine è il primo brano dove Ellis passa alla Stratocaster, il suono è più “trillante” ma la qualità è sempre elevata, come pure nella vorticosa Kiss This World, molto British Blues, e ancora nella più sognante Autumn Run, altra ballata blues melodica che potrebbe ricordare il BB King di The Thrill Is Gone, meno incisiva ma nobilitata dal solito lavoro di grande finezza della solista. Che divenuta una Telecaster nella vibrante Satisfied, “inventa” un R&R alla Chuck Berry con il piano di McKendree nel ruolo che fu di Johnnie Johnson. Don’t Turn Off The Light è un altro lento d’atmosfera, tra Rea, Gary Moore o Robin Trower, con la Gibson di Ellis impegnata in un pregevole assolo che al sottoscritto ha ricordato moltissimo (quasi al limite del plagio, ma le note si sa sono sette) quello di Carlos Santana in Europa; l’unica cover è Dixie Lullaby, un vecchio brano di Leon Russell, tipico del pianista di Tulsa, ricco di influenze sudiste, e con il piano e l’organo di McKendree al solito pronti a spalleggiare egregiamente la solista di Tinsley Ellis, molto alla Freddie King per l’occasione, pezzo che conclude degnamente un album di notevole sostanza.
Bruno Conti