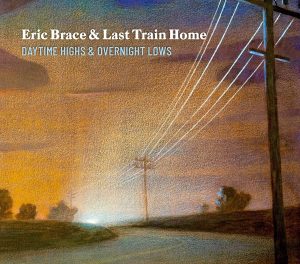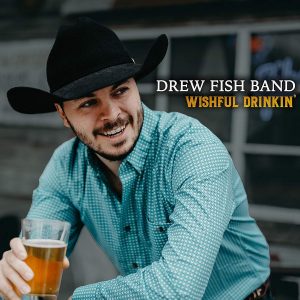The Burrito Brothers – The Notorious Burrito Brothers – The Store For Music CD
Credo che i Flying Burrito Brothers, storico gruppo country-rock californiano nato da una costola dei Byrds (ovvero per mano di Gram Parsons e Chris Hillman, transfughi all’indomani del fondamentale Sweetheart Of The Rodeo), siano una delle band con la “timeline” più caotica per quanto riguarda i membri delle sue varie formazioni, detenendo infatti il record di non aver mai avuto la stessa lineup per due album consecutivi. A parte i loro primi due dischi, gli imperdibili The Gilded Palace Of Sin e Burrito Deluxe, direi che i nostri hanno mantenuto un profilo alto per almeno altri due-tre lavori (anzi, il terzo album, l’omonimo The Flying Burrito Brothers ed ultimo con Hillman in formazione, non è molto inferiore ai due precedenti), e comunque si sono difesi dignitosamente almeno fino a quando Rick Roberts ha fatto parte della squadra (NDM: per chi ancora non li conoscesse consiglio la strepitosa antologia del 2000 Hot Burritos! The Flying Burrito Brothers Anthology 1969-1972).
Man mano che passavano gli anni i FBB hanno visto avvicendarsi al loro interno una lunga serie di musicisti che poco o niente avevano da spartire con il nucleo originale, e verso la fine degli anni novanta hanno anche perso il suffisso “Flying”, che è diventato di proprietà di Hillman; dagli anni duemila in poi l’eredità del gruppo è stata portata avanti da onesti mestieranti sotto il moniker di Burrito Deluxe per tre dischi, The Burritos per uno e, dal 2018, The Burrito Brothers con il non disprezzabile Still Going Strong. Ora i Burritos ci riprovano, e fin dal titolo e dalla copertina (che richiamano entrambi The Notorious Byrd Brothers, famoso album dei Byrds – quello con l’asino al posto di David Crosby – che rappresentava la transizione della storica band tra il primo periodo folk-rock e psichedelico e la fase country-rock) cercano di appropriarsi di un passato che non gli appartiene, dato che il “veterano” del gruppo, il tastierista e cantante Chris James, è con loro appena dal 2010, mentre lo steel guitar player Tony Paoletta è arrivato nel 2013, il chitarrista e bassista Bob Hatter nel 2017 ed il batterista Peter Young è nuovo anche se qualche anno fa aveva già fatto brevemente parte della band.
Ma, a parte tutti i discorsi sull’opportunità dei quattro di chiamarsi così (e se è Hillman è d’accordo, chi sono io per contestare?), devo affermare che The Notorious Burrito Brothers è un bel dischetto di autentico country-rock di matrice californiana, che richiama volutamente le atmosfere della band alla quale i nostri si ispirano direttamente, ma che rimanda qua e là anche al suono di Poco e Eagles (due gruppi che comunque devono moltissimo agli originali FBB). Niente di nuovo sotto il sole, e nemmeno posso dire che questo album sia un mezzo capolavoro che aspirerà a diventare uno dei dischi dell’anno, ma sono certo che se lo farete vostro non rimpiangerete i soldi spesi (e di questi tempi è già molto). Tutti i brani sono originali, tranne le eccezioni che menzionerò durante la disamina: il CD si apre molto bene con Bring It, una limpida ed ariosa country-rock song dal motivo gradevole, ritmo spedito e chitarre ruspanti, che ricordano non poco gli Eagles con Joe Walsh alla voce solista (per la somiglianza del timbro di James). Sometimes You Just Can’t Win è un testo inedito scritto da Gram Parsons con Fred Neil e musicato dai nostri, altra tersa e solare ballata elettrica con piano e chitarre sempre in evidenza, un bell’omaggio alla memoria di Gram (e Fred) per uno dei pezzi più riusciti del CD. Love Is A River è il brano centrale del disco, una sorta di mini-suite di quasi dieci minuti nella quale i Burritos accennano almeno quattro diversi temi musicali passando da languide ballads a canzoni più mosse, con echi di Poco e FBB originali ed ottimo lavoro di steel (Paoletta è una piacevole sorpresa) e pianoforte.
Splendida la ripresa del classico di Dan Penn e Chips Moman Dark End Of The Street (che era anche su The Gilded Palace Of Sin), con la voce di James che qui ricorda abbastanza quella di Roger McGuinn, la steel protagonista e la nota melodia che scorre fluida e toccante; Do Right Man (ideale seguito della Do Right Woman sempre di Penn presente anch’essa sull’esordio dei FBB) vede come co-autore Ron Guilbeau, figlio di Gib Guilbeau che in passato fu a lungo membro dei Burritos, ed è un’altra cristallina ballata “alla Gram Parsons” che dona ulteriore lustro ad un disco che cresce brano dopo brano. Acrostic è un lento crepuscolare e delicato ma non particolarmente originale, mentre Gravity è uno spedito e delizioso pezzo elettroacustico a metà tra country-rock e bluegrass, che purtroppo finisce dopo neppure due minuti. Il CD termina con la bella Hearts Desire (che deriva da un testo inedito di Skip Spence, ex Moby Grape), altra country song elettrica e cadenzata dal motivo squisito e con le chitarre che tornano a farsi sentire, e con la tenue Wheels Of Fire, orecchiabile e squisita ballata dal forte profumo di California.
Quindi, anche se gli “Asinelli” non volano più, hanno dimostrato con The Notorious Burrito Brothers di saper fare musica piacevole e più che dignitosa.
Marco Verdi