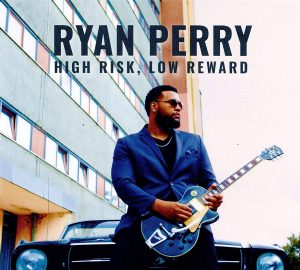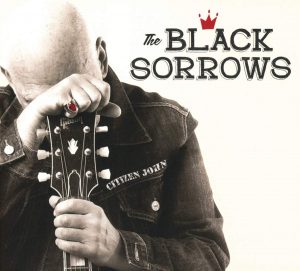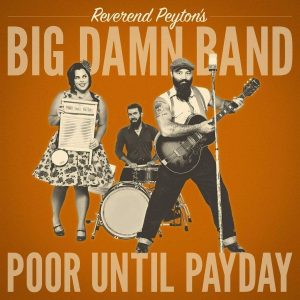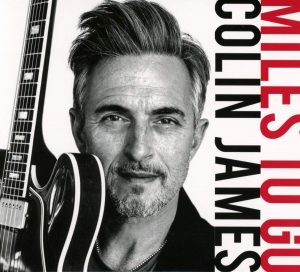Bobby Rush – Rawer Than Raw – Deep Rush Records/Thirty Tigers
Nativo della Louisiana, ma residente a Jackson, Mississippi sin dagli anni ‘80, Bobby Rush, 86 anni suonati, è uno strane personaggio del blues americano: a cavallo tra le 12 battute classiche, il soul e il funky, da qualche anno si è inventato un termine per definire la sua musica “Folkfunk”. Personaggio diciamo “minore”, ma non marginale, Rush era apparso anche nella miniserie The Blues, prodotta da Martin Scorsese, sempre in pista e pronto a raccontare aneddoti sulla sua lunga carriera, che lo vede come una sorta di Numero Uno di Alan Ford, uno che nel corso degli ha incontrato e suonato con tutti, “consigliandoli” su cosa fare, da Skip James, Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson II, Muddy Waters a Elmore James, i cui brani reinterpreta in questo Rawer Than Raw, praticamente tutti i grandi della musica nera, tanto che nelle note si dice dispiaciuto di non avere potuto cimentarsi con brani di Jimmy Reed, John Lee Hooker, Son House e BB King. Già nel 2006 aveva inciso un album Raw, composto solo di rivisitazioni di proprie canzoni e che si concludeva con il brano Bobby Rush For President. Quale è la particolarità di questi album?
Come suggerisce il titolo si tratta di album acustici, nel caso di quest’ultimo, anche in solitaria: solo voce, chitarra ed armonica. Ripreso in copertina tra attrezzi agricoli e galline, e all’interno in varie pose, dove sfoggia la sua tinta di capello sempre corvina, un must per i vecchi bluesmen, il buon Bobby ha ancora una voce potente e squillante, e le sue riletture dei classici, miste ad alcune canzoni a propria firma, sono la prova che il nostro amico conosce la materia e sa come trattarla con classe. Sin dall’apertura con Down In The Mississippi, scritta dallo stesso Rush, si respira un’aria “antica” ma non vetusta, voce e chitarra acustica a ripercorrere i vecchi tracciati del blues del Delta, l’armonica a colorare il suono. D’altronde si intuisce che si tratta, come dicono gli americani, di un “labor di love”, realizzato nel corso del tempo tra Jackson, Ms e Montreal: ascoltatevi il blues primigenio di Hard Times (che sarebbe Hard Times Killing Floor Blues di Skip James) al quale, oltre ad acustica e armonica aggiunge il foot stomp per ricreare il sound dell’originale del 1931 (e lì Rush non era presente). Let Me In Your House è una delle canzoni di Bobby, salace e ironico come deve essere il blues, “If I can’t sleep in your bed, let me sleep on your floor. If I walk in my sleep, you’re the only one who’ll ever know. If I can’t be your full-time lover, let me be your part-time man”, scandito dall’interpretazione quasi danzante del nostro.
Che poi si cimenta con Smokestack Lighting di Howlin’ Wolf, che invece ha conosciuto e incontrato nella sua gioventù, quando si aggirava per locali, con baffi finti per nascondere la sua vera età, versione intensa e vissuta, ora che gli anni sono quelli giusti, e anche Shake It For Me, scritta da Willie Dixon, viene dal repertorio del Lupo, con l’acustica suonata ancora con grande destrezza e la voce sicura in grado di emozionare. In Sometimes I Wonder, sempre farina del suo sacco, dimostra di essere anche un ottimo armonicista, poi cimentandosi anche con uno dei maestri dello strumento Sonny Boy Williamson II nella classica Don’t Me Start Me Talkin’, qui ripresa in una vibrante versione; molto intenso anche un altro originale di Rush come Let’s Make Love Again, che poi lascia spazio al lato più ironico della sua arte nella divertente Garbage Man, un potente lentone dove il testo però è molto scherzoso “of all the men my woman could have left me for, she left me for the garbage man. Every time I see a garbage can, I think of her and the garbage man all the time”, con la sua donna che lo tradisce con lo spazzino. Honey Bee, Sail On è un traditional , ma faceva parte del repertorio di Muddy Waters, che riceve il suo giusto tributo, in un brano che evidenzia ancora la voce splendida di Rush, che poi si cimenta con il super classico Dust My Broom, non nella versione di Robert Johnson (anche lui non lo ha conosciuto), ma in quella di Elmore James, conosciuto invece in un club nel 1947, quando ci si aggirava con i suoi baffi finti appena ricordati, grande versione, come d’altronde tutto l’album, uno dei migliori dischi di blues acustico dell’anno.
Bruno Conti