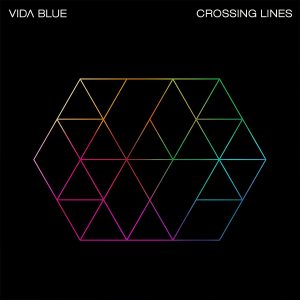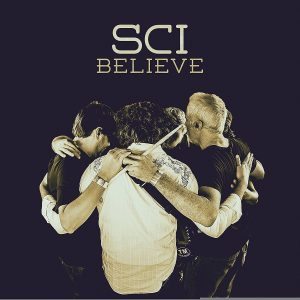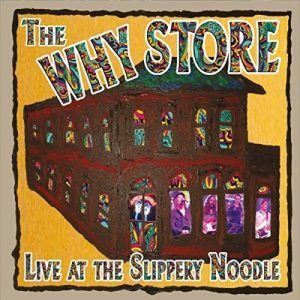*NDB L’album è stato pubblicato in questi giorni anche come doppio vinile e, ma solo sul sito della band https://drygoods.phish.com/product/PHCD247/sigma-oasis-cd-dry-goods-exclusive?cp=null anche come CD. Per cui vi riproponiamo la recensione, uscita il 13 aprile.
Phish – Sigma Oasis – JEMP/ATO Records Download
Lo scorso 2 aprile i Phish, band del Vermont che ormai possiamo definire storica esistendo dal 1983, ha deciso di fare una sorpresa ai suoi fans pubblicando senza alcun battage pubblicitario un nuovo album, intitolato Sigma Oasis. Probabilmente la cosa era già nei piani del quartetto (Trey Anastasio, Mike Gordon, Page McConnell e Jon Fishman), ma l’emergenza coronavirus li ha spinti a bruciare le tappe in modo da dare al loro pubblico della nuova musica per questo lungo periodo di quarantena: purtroppo al momento l’album è disponibile soltanto come download (a pagamento) sulle principali piattaforme, e non è ancora stata resa nota una data di pubblicazione di un eventuale supporto fisico. Sarebbe un vero peccato se non potessimo avere a breve anche il CD tra le mani (parlo ovviamente di chi come il sottoscritto predilige ancora la fruizione vecchio stile, “da divano”), perché già dal primo ascolto Sigma Oasis si rivela non solo superiore al precedente e già ottimo Big Boat https://discoclub.myblog.it/2016/10/18/allora-sanno-grandi-dischi-phish-big-boat/ , e neanche semplicemente l’episodio migliore dalla reunion del gruppo avvenuta nel 2009, ma addirittura al livello dei loro lavori più belli come Rift, Hoist o Billy Breathes.
Registrato in presa diretta nel loro studio The Barn, e anche Sputnik Sound (Nashville TN), Brighter Shade Studios (Atlanta GA) e Flux Studios (New York NY), con la co-produzione di Vance Powell (già collaboratore di Chris Stapleton, Sturgill Simpson, Jack White e Buddy Guy), Sigma Oasis è formato da nove brani che i fans americani della band conoscono già in quanto presenti nelle setilist dei concerti del gruppo da diversi anni (in un caso, Steam, addirittura dal 2011, mentre altri due pezzi, Mercury e Shade, erano stati anche insisi per Big Boat ma poi lasciati in un cassetto), ma che per la maggior parte degli ascoltatori sono inediti. Ebbene, sarà perché i nostri conoscono già queste canzoni a menadito, sarà per la bontà assoluta delle composizioni (tutte a firma di Anastasio con il suo consueto paroliere Tom Marshall, e se non sbaglio è la prima volta in un disco dei Phish), ma Sigma Oasis è un album straordinario, un lavoro in cui il mix di rock, funky, ballate, progressive e tendenza alla jam di Anastasio e soci è a livelli eccellenti, in più con una serie di canzoni di prima categoria (non me ne voglia Gordon, ma Trey è sempre stato il compositore migliore del quartetto): un vero disco rock, con brani spesso lunghi e fluenti in cui i nostri suonano come se fossero nel bel mezzo di un concerto, al massimo della loro ispirazione e creatività.
L’album si apre proprio con la title track, una rock ballad fluida dal suono pieno e potente, con reminiscenze dei Grateful Dead (specie nell’insistito riff di chitarra), un ritornello disteso e godibile ed un’ottima coda strumentale: il disco (scusate se ogni tanto lo chiamo così) si mette fin da subito sui binari giusti. Leaves inizia come uno slow pianistico, poi entra una chitarra acustica e la voce di McConnell che duetta con quella di Anastasio e la melodia si sviluppa sontuosa ed in continuo crescendo, con un bellissimo gioco di voci che si rincorrono ed anche l’aggiunta di un background orchestrale, il tutto condito dalla splendida chitarra di Trey e dalle nitide note del pianoforte di Page: sette minuti fantastici. Everything’s Right di minuti ne dura più di dodici, ed è un gustoso midtempo rock dal ritmo cadenzato con un refrain corale ed un tappeto sonoro leggermente funky: Phish sound al 100%, un brano epico che dal vivo può toccare anche minutaggi maggiori, dato che dal sesto minuto diventa una straordinaria jam con McConnell che si alterna superbamente a piano ed organo e Trey che suona in modalità wah-wah.
Ancora più funky è Mercury, canzone godibile dal ritornello ripetitivo che però entra in testa subito ed ancora elementi “deaddiani” (periodo Shakedown Street), per altri sette minuti e mezzo di musica ad alti livelli; Shade è un toccante lento pianistico sul genere di classici passati del gruppo come Wading In The Velvet Sea, ancora con un emozionante intervento orchestrale ed Anastasio che canta molto bene una melodia non facile, rilasciando nel finale un assolo decisamente lirico, mentre Evening Song, che con i suoi tre minuti e venti è la più breve del lotto, è una rock song rilassata e dal motivo diretto ed accattivante, di nuovo con piano e chitarra in evidenza ed un ritornello corale molto bello. Con i quasi otto minuti di Steam ci rituffiamo in una miscela robusta ma assai fruibile di rock e funky, un suono che ormai è il marchio di fabbrica dei quattro, con Page e Trey strepitosi ai rispettivi strumenti: si sente che i brani di questo album sono già nel loro repertorio da tempo, in quanto si percepisce la sensazione di una coesione e compattezza del suono perfino maggiori del solito.
A Life Beyond The Dream conferma che i Phish sono un gruppo capace di sfornare anche ballate coi fiocchi, e forse questa è la migliore di tutte: sei minuti e mezzo splendidi, con un motivo intenso e profondo ed un accompagnamento molto anni settanta, con organo ed un coro femminile a dare un tocco southern soul ed un finale maestoso tra rock e gospel. Il CD (ehm…volevo dire lo streaming) si chiude alla grande con gli undici minuti della potente Thread, un pezzo creativo e pieno di idee, cambi di ritmo e melodia a go-go ed ennesima prestazione strumentale di valore assoluto, un brano che denota l’influenza che Frank Zappa ha avuto sui nostri. Sigma Oasis è quindi un lavoro eccellente, tra i migliori dei Phish se non addirittura il migliore: spero vivamente che prima o poi esca anche in CD, così avrò meno remore ad inserirlo nella mia Top Ten annuale.
Marco Verdi