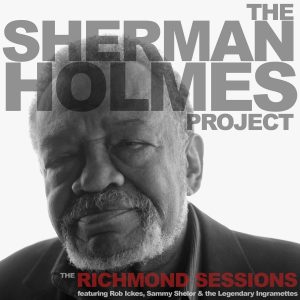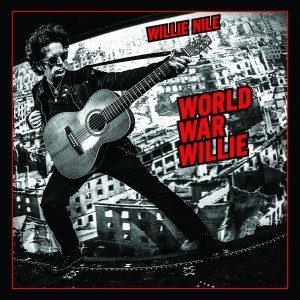Amy Helm – This Too Shall Light – Yep Rock
Anche nel recensire il precedente album di Amy Helm https://discoclub.myblog.it/2015/08/02/degna-figlia-tanto-padre-amy-helm-didnt-it-rain/ non avevo potuto fare a meno di citare, sin dal titolo, lo stretto grado di parentela di Amy con quella che giustamente è considerata una delle figure più importanti della scena musicale americana, ovvero il babbo Levon Helm, di cui peraltro la nostra amica è stata negli ultimi anni di vita del musicista dell’Arkansas, una delle più strette collaboratrici a livello musicale, oltre a coltivare nello stesso periodo una carriera in proprio come leader di quella piccola grande band che sono stati (e forse saranno ancora, visto che non hanno mai ufficializzato un eventuale scioglimento), ovvero gli Olabelle https://discoclub.myblog.it/2011/09/01/forse-non-imprescindibile-ma-sicuramente-molto-bello-ollabel/, oltre ad essere apparsa nel corso degli anni come ospite in dischi dei musicisti più disparati che si possono considerare suoi spiriti affini. Per questa nuova avventura This Too Shall Light, il suo secondo album da solista, la Helm ha scelto di farsi produrre da un artista che di solito è garanzia di qualità, per cui ha preso baracca e burattini e si è trasferita dall’amata base casalinga in quel di Woodstock a Los Angeles, agli United Recording Studios di Hollywood, quelli dove opera abitualmente Joe Henry, perché è lui che ha curato la cabina di regia di questo nuovo disco, coadiuvato dalla solita pattuglia di eccellenti musicisti che abitualmente si alternano nei dischi di Henry: Jay Bellerose alla batteria, Jennifer Condos al basso, Adam Minkoff alla chitarra acustica, l’ottimo tastierista Tyler Chester (alcuni ascoltati anche nel recente album di Joan Baez https://discoclub.myblog.it/2018/03/12/uno-splendido-commiato-per-una-grandissima-artista-joan-baez-whistle-down-the-wind/ , prodotto proprio da Henry), con l’aggiunta alle chitarre di Doyle Bramhall II, altro produttore ed arrangiatore di valore, di cui a giorni è in uscita un nuovo album Shades, che lo conferma ancora una volta ottimo come gregario di lusso per altri musicisti, ma non del tutto convincente in proprio, come leggerete a breve nella mia recensione.
Tornando al disco della Helm, un altro degli ingredienti fondamentali è la presenza di molte voci di supporto, oltre a Bramhall e Minkoff, anche JT Nero e Allison Russell, che sono essenziali nel creare quella ambientazione gospel-soul che tipicizza il folk-country-rock, vogliamo chiamarla Americana music, che da sempre caratterizza la musica di Amy. Importante è anche stata la scelta dei brani: Joe Henry, per chiarire quale tipo di musica avrebbe voluto creare ha fatto sentire alla Helm Motel Shot di Delaney & Bonnie, che non è una brutta base di partenza da cui sviluppare le sonorità di un disco. Che poi l’album sia venuto meno “esuberante” e più intimo e raccolto è dovuto anche alla personalità ed alla voce forse meno esplosiva della Helm stessa. Comunque un ottimo disco, che si apre sulle note della title track This Too Shall Light, un brano scritto da M.C. Taylor e Josh Kaufman degli Hiss Golden Messenger, che benché “nordisti” come Amy, hanno, come lei, un profondo amore per la musica del Sud degli States, per il gospel e e il soul, meticciati con il rock e il blues, e il cui testo cita Voices Inside (Everything Is Everything) di Donny Hathaway, uno degli autori considerati minori della musica nera, ma grande talento: la canzone è una delle più mosse del disco, una ballata mid-tempo guidata dalla chitarrina insinuante di Bramhall, dalle tastiere risonanti di Chester e dalle voci di supporto che avvolgono la calda e partecipe tonalità di Amy che intona la melodia con spirito delicato ma forte al contempo di questa splendida canzone che conferma la classe innata della figlia di Levon, lei che si ispira da sempre a personaggi come gli Staples Singers per la propria musica intrisa di vibrante spiritualità.Odetta che è il brano che lo stesso Joe Henry ha portato alle sessions, è stato ovviamente riadattato per la voce e lo stile più emozionale della Helm, cantante dalla voce sempre carica di pathos, un brano elettroacustico, molto variegato, ma anche vicino alle traiettorie sonore più raffinate degli arrangiamenti della Band, con piano, soprattutto, e chitarra acustica, in bella evidenza, che sposano il country-gospel-rock con l’appeal di una cantautrice classica, sempre con le voci di supporto immancabili in questo dipinto sonoro.
I Milk Carton Kids, altri recenti “clienti” di Joe Henry, offrono alla causa la loro Michigan, dal secondo disco Prologue, un brano che grazie all’organo fluente di Chester, che rimanda a quello del grande Garth Hudson, è un altro acquerello delizioso e delicato che unisce le distese dei Grandi Laghi del nord con la musica del più profondo Sud, un altro gospel soul di grande intensità vocale e strumentale, con l’organo che mi ha ricordato anche il suono quasi “classico” del non dimenticato Matthew Fisher dei Procol Harum, una meraviglia cantata in modo quasi trasfigurato dalla nostra amica. Anche Allen Toussaint, un’altra delle leggende del deep soul intriso di gospel della musica di New Orleans, viene omaggiato con una intensa rilettura di una delle sue canzoni più vicine allo spirito sociale della dichiarazione per i diritti sociali come Freedom For The Stallion, altra piccola meraviglia di equilibri sonori dove la voce trae ispirazione da quella di grandi cantanti nere come Gladys Knight e Ann Peebles, ma anche di Mavis Staples, ed il breve break chitarristico di Bramhall è un’altra piccola perla, all’interno dello scrigno. Mandolin Wind era una delle più belle canzoni nel disco più bello di Rod Stewart Every Picture Tells A Story, e uno, vista la presenza di una mandolinista provetta come Amy Helm, degna erede del babbo anche nell’uso di quest strumento, si sarebbe aspettato un uso massiccio dello stesso, invece astutamente nell’arrangiamento viene sostituito dalla slide insinuante di Bramhall, eccellente nel suo contributo alla grana sonora malinconica e romantica del pezzo, dove anche tutto il resto della band, piano in primis, fornisce un apporto corale ad una interpretazione vocale da incorniciare. Ancora un organo sontuoso apre la parafrasi sonora di un brano come Long Daddy Green, una canzone di impianto jazzy di una cantante minore come Blossom Dearie, che Amy ascoltava con grande piacere nella sua formazione musicale giovanile e che rinasce a nuova vita come un blues solenne frequentato dai fantasmi delle grandi voci del passato.
Papà Levon viene ricordato con un brano scritto da Robbie Robertson The Stones I Throw, una composizione che viene dal periodo pre-Band, 1965, quando si chiamavano ancora Levon And The Hawks, un brano gioioso ed esuberante, nuovamente tra gospel, rock e soul, in quello stile che poi avrebbero perfezionato negli anni a venire, ma che era già perfettamente formato all’epoca e viene felicemente catturato in questa elegante riproposizione. Per Heaven’s Holding Me, l’unico brano originale scritto a quattro mani dalla Helm con Joe Henry, Paul Owen e Ted Pecchio, Amy estrae per una unica volta dalla custodia il suo mandolino, per una canzone d’amore gentile e dai sentimenti delicati dove spicca ancora la grande sensibilità ed il talento di interprete sopraffina di una voce per l’occasione anche fragile e quasi vicina al punto di rottura, ma che però non si spezza, sempre sorretta comunque dalla estrema raffinatezza degli arrangiamenti che circondano il suo percorso sonoro. T-Bone Burnett è sicuramente uno dei grandi rivali di Joe Henry tra i produttori più bravi e ricercati in circolazione, ma per l’occasione appare come autore di River Of Love, un brano poco noto tratto dal suo album omonimo del 1986, altra canzone di ottima fattura, con il piano nuovamente in bella evidenza, ancora una volta a sottolineare quello spirito gospel e soul malinconico, veicolato quasi in modo vulnerabile dalla voce raccolta e intima, sempre comunque ben sostenuta dalle sottolineature precise dei cantanti di supporto. E proprio un gospel tradizionale come Gloryland, cantato a cappella dalla Helm con il supporto corale di tutti gli altri vocalists, chiude un album che la conferma come una delle interpreti più interessanti e solide della musica d’autore. In definitiva direi veramente un bel disco, per chi ama la buona musica.
Bruno Conti