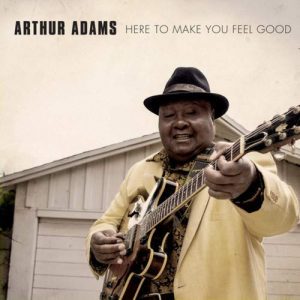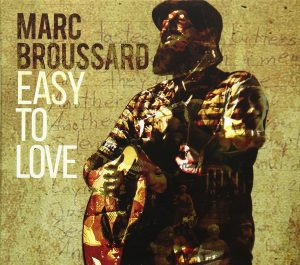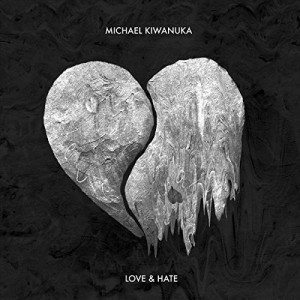William Harrison Withers Jr. se ne è andato lunedì 30 marzo 2020, anche se le notizia è stata comunicata dalla famiglia solo ieri, per problemi cardiaci. Bill Withers, come era conosciuto da tutti, è stata una delle voci più interessanti e uniche della black music: una carriera nella musica iniziata tardi, quando aveva già passato i 30 anni, e durata solo una quindicina di anni, con la pubblicazione di otto album di studio e uno dal vivo. Molti lo conoscono soprattutto per i suoi due brani più noti, la splendida Ain’t No Sunshine, una canzone con un incipit straordinario e uno svolgimento altrettanto emozionale, e Lean On Me, “conta su di me”, che in questi tempi di coronavirus è stato uno dei pezzi più utilizzati per lanciare campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi. Il musicista di Stab Fork, Virginia, dove era nato il 4 luglio del 1938, ma da sempre califoniano di elezione, spesso veniva ritratto sorridente nelle foto e sulle copertine dei suoi album, con quella espressione disincantata e anche scettica che lo aveva accompagnato nell’approccio alla musica e nella vita.
L’ultimo di sei figli, affetto nell’infanzia e nella gioventù dalla balbuzie, Withers era entrato nella Marina Americana all’età di 17 anni, dove poi aveva prestato servizio per nove anni, in seguito aveva fatto diversi lavori, anche nel settore dell’industria aereonautica, comunque coltivando sempre la sua passione per la musica, registrando demo che portava alle case discografiche ed esibendosi in piccoli locali.Tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970, quando il suo nastro contenente Ain’t No Sunshine iniziava a circolare negli ambienti discografici, Bill comunque mantenne il suo lavoro, tanto che nella copertina del suo primo album è ritratto ancora con la sua borsa per il pranzo, “schiscetta” diremmo a Milano, visto che non si fidava molto dell’ambiente in cui era entrato, che definiva, a ragione come vedremo, una industria volubile. Comunque nel maggio del 1971 esce il suo esordio Just As I Am, che molti considerano il suo capolavoro, un disco dove la soul music, il suo genere di pertinenza, era mediato da un utlizzo di stilemi folk, pop, anche con inserti gospel e a livello di testi, oltre alle classiche canzoni d’amore, anche brani che toccavano tematiche sociali e politiche.
L’album uscì per la Sussex, una piccola etichetta di proprietà di Clarence Avant che comunque gli mise a disposizione un dream team di musicisti: Booker T. Jones, oltre a essere il produttore, suonava naturalmente le tastiere, Stephen Stills era la chitarra solista, mentre al basso si alternavano Donald Dunn e Chris Ethridge, alla batteria Jim Keltner e Al Jackson Jr. sempre degli Mg’s, nonché la percussionista Bobbye Hall. Il risultato è un disco dove soul music e pop raffinato vanno fianco a fianco appunto con il soul (non a caso le uncihe due cover erano Let It Be dei Beatles e Everybody’s Talkin’ di Fred Neil/Harry Nilsson, la colonna sonora dell’Uomo Da Marciapede). La voce di Withers non è forse molto potente, ma in ogni caso espressiva e ricercata, con qualche analogia con quella di Stevie Wonder e Marvin Gaye, due musicisti che stavano cambiando la musica nera all’epoca, ci sono anche intermezzi orchestrali come nella potente Harlem che apre l’album, l’utlizzo di chitarre acustiche, per esempio nella splendida Ain’t No Sunshine, che impiega la reiterazione tipica del gospel, come pure l’altro singolo estratto dall’album, l’intensa Grandma’ s Hands, mentre le due cover sono entrambe molto belle, Let It Be che si presta molto al trattamento gospel e Everybody’s Talkin’ che diventa un country got soul. Ma tutto l’album è eccellente, da riscoprire assolutamente.
Anche Still Bill, uscito nel 1972, è un grandissimo disco, l’unico a entrare nella Top Ten delle classifiche USA, un altro dei classici dischi da 5 stellette: ci sono due canzoni che si elevano sulle altre, la ballata universale Lean On Me, senza tempo e utilizzata nei tempi duri, quando c’è bisogno di sostegno e solidarietà, questa volta con un approccio ancora più “nero” del precedente album, grazie all’utilizzo di musicisti come il grande batterista James Gadson, una delle colonne della black music e del funky dell’epoca, del bassista Melvin Dunlap, anche lui, come Gadson, della Watts 103rd Street Rhythm Band, al pari del chitarrista Benorce Blackmon, spesso al wah-wah e a completare la formazione Raymond Jackson alle tastiere e arrangiatore di fiati e archi. Dal precedente disco rimane Bobbye Hall: l’altra canzone di grande fascino è Use Me, un funky proprio tra Stevie Wonder e Marvin Gaye, dalla grande scansione ritmica e con un piano elettrico a caratterizzarne il sound. In ogni caso, come per il disco precedente, non ci sono punti deboli nell’album e tutte le canzoni sono affascinanti e di grande appeal: senza voler fare un trattato sulla discografia di Bill Withers, comunque mi preme segnalare anche il magnifico Live At Carnegie Hall, registrato nella grande sala da concerto newyorchese con gli stessi musicisti del disco in studio nell’ottobre del 1972 e poi pubblicato nel 1973. Un doppio vinile, sempre edito per la Sussex, dove le versioni dei brani spesso vengono allungate con ampi spazi improvvisativi dove i musicisti sono liberi di dare grande supporto alle bellissime canzoni di Withers, in uno dei dischi dal vivo più belli degli anni ’70.
Negli anni successivi Bill pubblicherà ancora sei album, uno per la Sussex e gli altri per la Columbia, nessuno essenziale come il trittico appena ricordato, comunque (quasi) sempre di qualità eccellente e con la presenza di alcune canzoni tra le più popolari del suo songbook: canzoni come Railroad Man, con José Feliciano alle chitarre e alle congas, o The Same Love That Made Me Laugh sono dei piccoli trattati sulla funk music, Lovely Day su Menagerie, con qualche piccola influenza disco, ma comunque ancora di grande fascino e Just The Two Of Us, l’ultimo grande successo, registrato insieme a Grover Washington Jr. e uscito come singolo nel 1980. Mentre nel 1985 viene pubblicato l’ultimo album per la Columbia, in effetti con un suono orripilante anni ’80, poco successo e un bel calcio nel culo dalla casa discografica che termina lil contratto con lui, e senza problemi Withers si ritira dal mondo della musica, memore di quanto aveva detto agli inizi. Qualche apparizione qui è là per ritirare premi postumi e riconoscimenti, ma nessun rimpianto: nel 2014 esce Bill Withers: The Complete Sussex & Columbia Albums Collection, un box di 9 CD con la sua opera omnia che sarebbe stato l’ideale da avere, per farsi una idea sulla sua musica, ma purtroppo è fuori produzione, quindi se li trovate ancora in giro cercate i primi tre album, oppure in mancanza di altro, qualche bella raccolta. “Unsung Hero” in lingua inglese rende meglio il concetto del nostro “eroe sconosciuto”!
Grazie di tutto e Riposa In Pace!
Bruno Conti