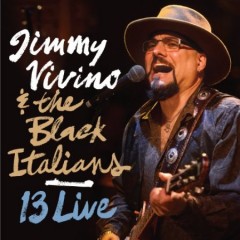*NDB. Come al solito quando Marco si lascia prendere la mano (ma per qualcosa che vale la pena) il contenuto del Post si allunga a dismisura, quindi dividiamo in due parti la recensione del cofanetto.
Ian Hunter – Stranded In Reality – Proper Box Set 28CD + 2DVD
Da sempre Ian Hunter è uno dei miei musicisti preferiti, in quanto per me rappresenta la quintessenza del cantante rock, con in più quel tocco dylaniano nel songwriting che non guasta (anzi): durante la sua lunga carriera, sia come frontman dei Mott The Hoople che da solista, ha mantenuto una qualità decisamente elevata, confermata circa due mesi fa dall’ottimo nuovo disco, Fingers Crossed. Per celebrare la parte solista del cammino discografico di Hunter, la Proper ha pubblicato (solo sul suo sito ed in una quantità limitata a 2.500 copie) questo Stranded In Reality, mastodontico box di ben 28 CD più due DVD, un’opera magnifica che ha il solo difetto di costare parecchio (250 sterline), ma che dimostra che quando si vuole è possibile gratificare i fans con prodotti di altissimo livello come questo. Infatti il box, oltre a comprendere tutti gli album solisti di Ian, sia quelli in studio (tranne l’ultimo, che è però appena uscito) sia i live ufficiali (e tutti in versione rimasterizzata ex novo, in confezione simil-LP e mantenendo tutte le bonus tracks delle varie edizioni deluxe uscite nel corso degli anni, ed ognuno con il suo bel booklet con testi e note), aggiunge ben nove CD quasi completamente inediti, tra brani in studio, outtakes, rarità assortite e canzoni dal vivo, e due DVD con performance varie ed anche in questo caso il più delle volte rare. In più, uno splendido libro con copertina dura e note di Ian stesso canzone per canzone, una rivista fittizia, intitolata Shades, che comprende recensioni ed articoli vari sul nostro pubblicati negli anni dalle più prestigiose testate inglesi, ed una foto autografata. Un cofanetto da leccarsi i baffi dunque, che vado a riepilogare per sommi capi, approfittandone anche per riassumere la carriera di un artista che secondo me andrebbe inserito nel novero dei grandi.
Ian Hunter (1975): il disco d’esordio di Ian è subito un classico. Con Mick Ronson come chitarra solista, partnership che proseguirà anche negli anni a seguire, Hunter ci regala un album che rappresenta alla perfezione la sua arte, a partire da Once Bitten, Twice Shy, un coinvolgente rock’n’roll ispirato da Chuck Berry, e che prosegue con la vigorosa Who Do You Love, la sontuosa Boy, una fantastica ballata di quasi nove minuti, l’acustica e toccante 3.000 Miles From Here, la solida The Truth, The Whole Truth, Nuthin’ But The Truth, con uno strepitoso assolo di Ronson, la vibrante e roccata I Get So Excited e, tra i bonus, le outtakes Colwater High e One Fine Day (entrambe con parti vocali incise nel 2005), che non avrebbero sfigurato sul disco originale.
All American Alien Boy (1976): registrato a New York con una superband (che vede Chris Stainton al piano, Jaco Pastorius al basso ed Aynsley Dunbar alla batteria, oltre a tre quarti dei Queen, cioè Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor ai cori nella ballad You Nearly Did Me In), questo è un altro grande disco, con più pezzi lenti rispetto all’esordio (ma Ian è un fuoriclasse anche nelle ballate), che si apre con la splendida Letter From Britannia To The Union Jack, una vera e propria missiva scritta con il cuore in mano da Ian al suo paese in profonda crisi, la scintillante title track, con gran lavoro di Pastorius, o la pianistica e bellissima Irene Wilde, una delle ballate più riuscite del nostro. Ma non sono da meno neanche Rape, dal sapore gospel, e la volutamente dylaniana God.
Overnight Angels (1977): un buon disco, molto più rock del precedente ma inferiore nel songwriting, un album poco considerato ma solido, con qualche buona canzone ed altre più normali. Golden Opportunity è un inizio potente e deciso come un pugno in faccia, ben bilanciato dalla pianistica Shallow Crystals, una rock ballad coi fiocchi. Ma la poco spontanea title track, un tentativo costruito a tavolino di scrivere una hit, non funziona, così come la pomposa Broadway; il resto si divide tra cose più riuscite ed altre meno (tra le prime la gradevole Miss Silver Dime e The Ballad Of Little Star, il miglior slow del disco), o veri e propri riempitivi come l’insulsa Wild’n’Free.
You’re Never Alone With A Schizofrenic (1979): al quarto disco Ian firma il suo capolavoro: con mezza E Street Band in session (Roy Bittan, Garry Tallent e Max Weinberg, più Ronson di nuovo alla solista, l’ex Velvet Underground John Cale al piano in Bastard ed Eric Bloom dei Blue Oyster Cult ai cori) Schizofrenic è un grandissimo disco, quasi un greatest hits se si contano i futuri classici presenti. Grandi canzoni rock come Just Another Night, Cleveland Rocks, When The Daylight Comes (splendida) e Bastard, e superbe ballate come Ships, dal suono levigato, Standing In My Light e la straordinaria The Outsider, forse il più bel lento mai scritto dal nostro. Ma il disco brilla anche nei momenti meno noti, come il festoso errebi Wild East ed il boogie pianistico Life After Death; tra le bonus tracks, una Just Another Night più lenta ma altrettanto bella (con un grande Bittan) ed una scatenata versione del classico di Jerry Lee Lewis Whole Lotta Shakin’ Goin’ On.
Welcome To The Club (1979): la decade dei grandi dischi dal vivo si chiude con uno dei più belli, registrato al Roxy di Los Angeles, e che vede Hunter in forma strepitosa, ben coadiuvato da Ronson e da un gruppo che va come un treno. Dopo un inizio con la potente rilettura dello strumentale degli Shadows FBI, il doppio CD presenta versioni spiritate di classici di Ian solista ma anche dei Mott The Hoople (Angeline, poco conosciuta ma bellissima, All The Way From Memphis, I Wish I Was Your Mother, Walkin’ With A Mountain, il superclassico All The Young Dudes, One Of The Boys e The Golden Age Of Rock’n’Roll): un disco potente ma lucido ed ispirato anche nelle ballate (una Irene Wilde da favola), e con in fondo tre brani nuovi incisi in studio, dei quali il migliore è senza dubbio lo slow Silver Needles.
Short Back’n’Sides (1981): nonostante la presenza di due Clash, Topper Headon e soprattutto Mick Jones (che produce insieme a Ronson), questo esordio di Ian nella nuova decade è un disco un po’ involuto e senza particolari guizzi, con sonorità gonfie tipiche del periodo: si salvano Central Park’n’West, un pop-rock orecchiabile e coinvolgente nonostante l’uso massiccio di sintetizzatori, e la stupenda Old Records Never Die, ballata incisa la sera in cui viene assassinato John Lennon. Il resto, con la possibile eccezione della colorita I Need Your Love, un errebi alla Southside Johnny, è trascurabile (e Noises è proprio brutta): Hunter stesso, nelle note del book accluso al box, non è per nulla tenero verso questo album.
All Of The Good Ones Are Taken (1983): questo sarà l’ultimo disco di Ian negli anni ottanta (una decade nefasta per molti rockers), un album che non contiene classici futuri ma una media di canzoni migliore del precedente, anche se il sound è notevolmente peggiorato (Captain Void’n’The Video Jets fa davvero schifo): tra gli highlights abbiamo la bella title track, una rock song che risente solo in parte del suono dell’epoca (e presenta un paio di buoni interventi al sax di Clarence Clemons), il rock’n’roll un po’ bombastico di Every Step Of The Way, la bowiana Fun, l’orecchiabile That Girl Is Rock’n’Roll (ma troppi synth) e la soulful Seeing Double.
Yui Orta (1990): dopo sette lunghi anni di silenzio, Ian torna con l’unico disco accreditato a metà anche a Mick Ronson (che però si limita, si fa per dire, a suonare la solista ed a collaborare al songwriting), ed è un buon disco, un album rock con una produzione rutilante e con diverse buone canzoni, anche se non serve a rilanciare la figura del nostro. Hunter ritrova comunque grinta e smalto e le belle canzoni non mancano, come la potente rock ballad American Music, al livello dei suoi pezzi degli anni settanta, la seguente The Loner, diretta come un macigno, l’energica e vibrante Women’s Intuition, o ancora la trascinante Big Time, un rock’n’roll scatenato come ai bei tempi. E Livin’ In A Heart dimostra che il nostro è ancora in grado di scrivere ballate coi fiocchi.
Ian Hunter’s Dirty Laundry (1995): nel 1993 scompare tragicamente Mick Ronson, e Hunter va fino in Norvegia ad incidere il nuovo disco con musicisti locali. Le nuove generazioni conoscono poco il nostro, ed il fatto che Dirty Laundry esca per una piccola etichetta locale non aiuta di certo; è un peccato, perché il disco è il più riuscito dai tempi di Schizofrenic, un album di rock al 100%, grezzo, diretto e chitarristico, con brani come la ritmata Dancing On The Moon, la corale e splendida Good Girls, uno dei più bei rock’n’roll del nostro, la travolgente Never Trust A Blonde, rollingstoniana fino al midollo, la deliziosa Psycho Girl, tra rock e pop e con una fulgida melodia. Ma poi abbiamo anche la meravigliosa Scars, una sontuosa ballata elettroacustica e dylaniana, che avrebbe meritato ben altra sorte. E quelle che non ho citato non sono certo inferiori (Invisible Strings è splendida): un disco da riscoprire assolutamente.
BBC Live In Concert (1995): accreditato alla Hunter-Ronson Band, questo CD registrato a Londra nel 1989 è stato pubblicato anche per omaggiare lo scomparso Mick. Un ottimo live, ben suonato e con un Hunter in forma, che accanto a classici assodati (Once Bitten, Twice Shy, Just Another Night, Standing In My Light, Bastard, Irene Wilde), presenta ben sei brani in anteprima da Yui Orta, che uscirà di lì ad un anno (eccellenti How Much More Can I Take? e Big Time), ed anche un inedito, Wings, invero piuttosto trascurabile.
The Artful Dodger (1996): disco registrato in Norvegia come Dirty Laundry, ma con maggior dispendio di mezzi (all’epoca uscì per la Polydor), The Artful Dodger è meno rock e con più ballate del suo predecessore, ma ha il merito di rimettere in circolo il nome di Hunter. Un lavoro più che buono, che ha come brano centrale Michael Picasso, una toccante ballata dedicata all’amico Ronson, ma che presenta diversi pezzi sopra la media, come Too Much, uno slow d’atmosfera davvero riuscito, la superlativa Now Is The Time, il limpido folk-rock Something To Believe In, la cristallina (ed autobiografica) 23A, Swan Hill, o la title track, unico vero rock’n’roll del CD. Mentre il funk-rap di Skeletons era meglio se non ci fosse stato.
Fine Prima Parte.
Marco Verdi