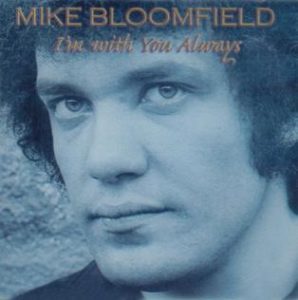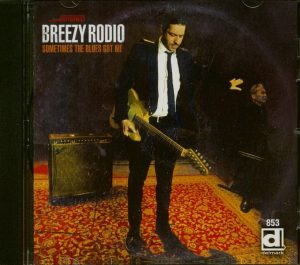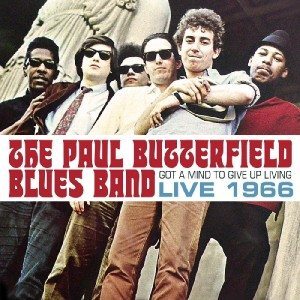Walter Trout – Ordinary Madness – Mascot Provogue CD Limited Edition – 2 LP Vinile Colorato
Ormai anche Walter Trout si avvia a toccare, il prossimo anno a marzo, il traguardo dei 70 anni: e da come si era messa la sua vita quando nel giugno del 2013 gli fu diagnosticata una grave forma di cirrosi epatica, le sue possibilità di sopravvivenza sembravano veramente poche, senza un trapianto del fegato. Cosa per fortuna puntualmente avvenuta nel maggio dell’anno successivo, tanto che già ad ottobre del 2015 usciva il suo album Battle Scars, che documentava la sua battaglia vinta con la malattia. Nel pieno della malattia aveva pubblicato un sorprendente (per qualità) disco come The Blues Came Fallin’, e negli anni successivi ha confermato una vena compositiva mai perduta, prima con Alive In Amsterdan, poi con l’ottimo album di duetti, con ospiti a go-go, We’re All In This Together, e ancora lo scorso anno l’eccellente Survivor Blues, un album con una serie di cover di brani non notissimi, alcuni addirittura oscuri https://discoclub.myblog.it/2019/01/26/non-solo-sopravvive-ma-prospera-ogni-disco-e-piu-bello-del-precedente-walter-trout-survivor-blues/ .
Per completare il filotto il musicista del New Jersey (che ha ribadito in una recente video intervista con il suo amico Joe Bonamassa, un aneddoto divertente e poco conosciuto dei suoi primi anni sui palchi di Ocean City, quando le rispettive band suonavano una di fianco all’altra su palchi adiacenti, e la chitarra solista degli Still Mill era un certo Bruce Springsteen, di cui Walter non rimase molto impressionato all’epoca dalla abilità come chitarrista, consigliandolo di migliorarla, cosa che poi parrebbe essere successa (!?!?), e ha pure scritto anche qualche “bella canzoncina”) pubblica ora un nuovo album Ordinary Madness, che non fa riferimento alla “pazzia” fuori dal comune causata dalla pandemia, ma alle debolezze e alle fragilità insite in ciascuno di noi. In effetti l’album è stato completato poco prima dello stop per il virus, negli Horse Latitudes, gli studios di proprietà dell’amico Robby Krieger dei Doors, in quel di LA, California, non lontano da Huntington Beach, dove Trout vive da anni con la famiglia. Solito produttore, una garanzia, Eric Corne, dal 2006 al suo fianco, Johnny Griparic al basso, Michael Leasure alla batteria, un altro fedelissimo, e Teddy Andreadis alle tastiere.
Ovviamente ci dobbiamo aspettare un ennesimo album di blues elettrico corposo, influenzato dalle 12 battute, ma innervato da una base rock assai presente e dove la chitarra solista di Walter Trout è la dominatrice assoluta del suono: insomma anche se Walter non ha dimenticato gli anni trascorsi con il suo mentore John Mayall il suo approccio è quello tipico del “guitar hero”, quindi ottime melodie quando servono, belle ballate terse, ma poi quando interviene la Fender di Trout non ce n’è per nessuno o per pochi. Anche se lo scorso anno si è fratturato il mignolo della mano sinistra (quella degli accordi per intenderci) ben tre volte, la title track, un lento sinuoso, languido e ipnotico conferma la grande tecnica e il feeling dei suoi assoli, un brano che potrebbe rimandare a quegli slow blues à la Robin Trower dove la chitarra quasi galleggia, liquida ed affascinante, mentre lascia dipanare lentamente la sua improvvisazione, stabilendo anche quale sarà il concetto sonoro dell’album, ribadito in Wanna Dance dove i ritmi si fanno più incalzanti, le sonorità più lavorate, con le tastiere a sostenere la solista, tra Van Halen e Neil Young (?!? lo ha dichiarato lui) che continua comunque a rilasciare assoli sempre vibranti e di grande consistenza, per poi placarsi nella bellissima ballata My Foolish Pride, quasi di impianto country e cantata benissimo del nostro, in una atmosfera che trasuda serenità, mentre piano e organo, quelli che furono di Ray Manzarek, lavorano di fino e tirano la volata per il lirico assolo di chitarra.
Poi nella pastorale Heartland utilizza la vecchia Telecaster di James Burton, “casualmente” anche quella negli studi di Krieger e fa capolino pure una fisa. All Out Of Tears scritta insieme a Teeny Tucker, e dedicata al defunto figlio di quest’ultima, è uno slow blues duro e puro, ad alto contenuto emotivo, con Trout che distilla dalle corde della sua chitarra un assolo lancinante, che avrebbe reso orgoglioso il suo amato Mike Bloomfield, da sempre citato come suo modello di ispirazione. Final Curtain Call è più dura e tirata, con dei tocchi orientaleggianti che rimandano agli Zeppelin, compreso assolo alla Page, ma con l’armonica suonata dallo stesso Walter che alza la quota blues, Heaven In Your Eyes è una ballata che illustra il suo lato più melodico, con The Sun Is Going Down che rivaleggia con i mid-tempo più ispirati di Clapton, grazie anche al lavoro delle tastiere e finale in crescendo galoppante con la solista in grande spolvero.
Chitarra impiegata in modalità gilmouriana, nel senso di David, con grande assolo, per la sognante Up Above My Sky che ricorda i Pink Floyd mid-seventies, la stonesiana e danzante Make It Right ilustra il lato più ludico e divertente della musica di Trout, un rock-blues di quelli robusti con solista prima accarezzata e poi strapazzata, e ancora più corposa e robusta è la conclusiva Boomer, scritta con la moglie Marie, dove i due parlano delle future generazioni in un brano dove le chitarre ruggiscono, anche la Gibson SG di Krieger di nuovo casualmente nello studio e impiegata insieme alle tastiere di Manzarek, in un brano che è il più duro e tirato, ma forse anche il meno soddisfacente, in un disco che globalmente comunque conferma l’ottimo livello della produzione di Trout. Forse l’unico appunto che si può fare è il fatto che il CD esce solo in quella confezione “Deluxe”, con plettri, sottobicchieri, stickers e cartoline, niente bonus tracks, il tutto francamente inutile e fa solo aumentare il prezzo, se volete potete consolarvi con la versione in doppio vinile colorato.
Bruno Conti