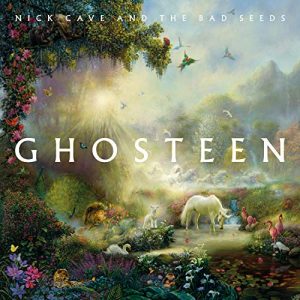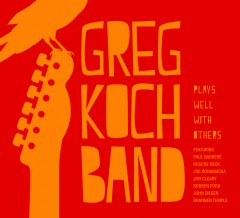Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen – Ghosteen/Awal 2CD – 2LP
Quando nel 2016 avevo recensito Skeleton Tree, l’allora nuovo album di Nick Cave ed i suoi Bad Seeds, era chiaro che avevo tra le mani il lavoro più drammatico e personale del cantautore australiano, un disco che era stato ispirato dalla tragica morte del figlio Arthur di 15 anni a causa di una caduta dalla scogliera di Ovingdean Gap vicino a Brighton https://discoclub.myblog.it/2016/09/30/rispetto-il-dolore-questuomo-nick-cave-and-the-bad-seeds-skeleton-tree/ . Un album che comprensibilmente rifletteva lo stato d’animo di un genitore distrutto dal dolore, formato da canzoni ancora più cupe del solito (Cave come saprete non è mai stato un tipo euforico e solare, e la morte ha sempre fatto parte delle tematiche trattate nei suoi brani) e contraddistinte da sonorità fredde e quasi di stampo ambient. Ma con questo nuovissimo doppio Ghosteen (uscito un po’ a sorpresa sulle piattaforme online circa un mese prima della versione “fisica”) Nick scava ancora più a fondo nel suo dolore, mettendosi a nudo come raramente un musicista ha fatto in passato:
Cave è indubbiamente portato per questo tipo di mood, ma un conto è ritagliarsi un ruolo di un certo tipo nell’ambito della canzone d’autore internazionale (recitando di fatto una parte), un altro è vivere in prima persona una tragedia terribile dalla quale è impossibile riprendersi fino in fondo. Ghosteen è quasi una seduta psicanalitica in cui Nick è il paziente e noi ascoltatori il dottore (anche se purtroppo non abbiamo nessun tipo di terapia da assegnargli), con una musica che spinge ancora di più sul pedale dell’elettronica, e la voce del nostro che si muove in mezzo a paesaggi sonori gelidi e molto poco accattivanti. Il risultato finale è un’opera di grande fascino pur essendo di non facile ascolto, con la voce del leader mai così fragile come in queste tracce: i Bad Seeds, poi, non sono mai stati così nelle retrovie, con Warren Ellis unico membro davvero impegnato tra synth, loops vari, flauto e violino, mentre gli altri (George Vjestica, chitarra, Jim Sclavunos, percussioni e vibrafono, Martyn Casey, basso e Thomas Wydler, batteria) sono presenti più che altro per onor di firma.
L’oscurità delle canzoni è in netta contrapposizione con la splendida copertina bucolica, una delle più belle tra quelle viste negli ultimi anni, e che potrebbe anche giustificare l’acquisto del doppio LP in luogo del CD, doppio anch’esso (un po’ inspiegabilmente, dato che la durata complessiva delle undici canzoni è di 68 minuti). L’elettronica domina fin dall’iniziale Spinning Song, introdotta da un raggelante tappeto di synth al quale si unisce quasi subito la voce rotta dal dolore di Cave, che più che cantare recita: il brano è volutamente una non-canzone, ma non posso comunque negare che il pathos è notevole: sul finale Nick inizia improvvisamente ad intonare una struggente preghiera con tanto di coro simil-ecclesiastico, da pelle d’oca. Bright Horses vede il nostro accompagnarsi al piano anche se il sintetizzatore non manca neppure qui, per una canzone toccante e splendida, ancora con la voce fragile che sembra sul punto di spezzarsi in più di un momento, e ad un certo punto entra anche una vera orchestra; ancora il piano introduce la cupa Waiting For You, con Cave che canta ancora con il cuore in mano intonando un ritornello splendido in cui invoca il ritorno del figlio, un momento di straordinaria commozione in grado di far capitolare anche l’animo più duro, mentre Night Raid è di nuovo un pezzo tutto costruito attorno alla voce grave di Nick e a pochi effetti sonori di fondo, un brano meno diretto del precedente ma intenso come pochi.
Sun Forest è gelida e tesa come una lama, con la voce che entra dopo più di due minuti di introduzione “sintetizzata” (ma il piano non manca), ancora con un’intonazione da preghiera, Galleon Ship vede nuovamente Cave cantare con alle spalle un tappeto elettronico ed un’atmosfera inquietante per uno dei pezzi più ostici del disco. Il primo CD si chiude con l’angosciosa Ghosteen Speaks, nella quale Nick quasi ci trasmette fisicamente la sua immane sofferenza (grazie anche ad un coro spettrale alle spalle), e con Leviathan, che per merito dell’uso di una tabla sembra quasi un canto tribale indiano, anche se l’atmosfera è sempre tetra. Il secondo dischetto è formato da sole tre canzoni, a partire dalla lunga title track (12 minuti), che ha un’introduzione strumentale potente e straniante al tempo stesso e con la voce di Cave che entra solo al quarto minuto aprendosi nel refrain in un raro momento di ampio respiro, quasi maestoso. La breve Fireflies è in realtà un brano recitato con un accompagnamento degno di un film horror, e precede la conclusiva Hollywood, che di minuti ne dura addirittura 14 ma senza cambiare il mood del disco, anzi forse accentuandone la componente drammatica.
Un lavoro dunque complicato, ostico e per nulla immediato questo Ghosteen, ma di una sincerità e profondità da far venire i brividi.
Marco Verdi
P.S: visto che siamo in clima funereo, volevo brevemente ricordare (con colpevole ritardo) la figura di Paul Barrere, deceduto lo scorso 26 Ottobre a causa di un cancro al fegato diagnosticatogli nel 2015. Chitarrista dalla tecnica sopraffina, Barrere ha legato il suo nome a doppio filo a quello dei leggendari Little Feat, gruppo del quale entrò a far parte nel 1972 affiancando l’unico chitarrista nonché leader della band Lowell George fino alla morte di quest’ultimo nel 1979 e conseguente scioglimento della band, e prendendone il posto nella line-up riformata nel 1988 per il comeback album Let It Roll fino ai giorni nostri, affiancato a sua volta da Fred Tackett (con il quale registrò anche un paio di album acustici in duo ).
Barrere portò in dote nel gruppo le sue conoscenze in materia di musica rock, blues, cajun e funky ed era l’elemento giusto al momento giusto in quanto in grado di arricchire ulteriormente il suono del gruppo californiano. La sua bravura nella tecnica slide ne fece il naturale sostituto di George, che era un maestro del genere, anche se non riuscì mai ad avvicinarne le capacità come songwriter: i brani più noti scritti da Paul sono Skin It Back, Feats Don’t Fail Me Now, Time Loves A Hero e Down On The Farm.
Più che dignitosa comunque la sua carriera nell’ultima fase del gruppo, con alcuni lavori di ottima fattura (Representing The Mambo, Ain’t Had Enough Fun, Join The Band) che forse erano anche meglio di un paio di dischi dei Feat negli anni settanta come Time Loves A Hero e The Last Record Album. Di sicuro si è già ritrovato lassù a jammare come ai bei tempi proprio con i vecchi amici Lowell ed il batterista Richie Hayward.