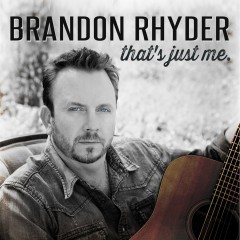Stoney LaRue – Onward – One Chord Song CD
Texano di nascita ma cresciuto nella vicina Oklahoma, Stoney LaRue è sempre stato associato al cosiddetto movimento Red Dirt, grazie anche alla sua amicizia con colleghi come Cody Canada, Jason Boland e Bob Childers. E poi il titolo del disco che nel 2005 lo fece conoscere ad una platea più grande, The Red Dirt Album, lasciava ben poco spazio all’interpretazione. LaRue è ormai attivo da più di quindici anni, ed ogni suo lavoro riesce ad ottenere buone critiche ed ultimamente anche un discreto successo di pubblico: countryman dal pelo duro, Stoney non ha mai modificato il suo suono per aver più passaggi in radio, ma è riuscito a ritagliarsi una buona fetta di popolarità rimanendo sé stesso. Musica country vera, di chiara appartenenza texana, con brani dal suono robusto ed elettrico anche nelle ballate ed un sapore rock sudista che emerge spesso: tutti elementi che troviamo anche in questo nuovo Onward, album che segue di quattro anni US Time e che ha tutte le carte in regola per soddisfare i palati più esigenti.
Oltre ad avere portato in studio il solito numero di ottime canzoni, in Onward LaRue ha fatto le cose in grande, facendosi produrre dall’esperto Gary Nicholson, uno dei nomi più di rilievo a Nashville anche come songwriter, e chiamando Ray Kennedy al mixer: in più, in session troviamo gente del calibro di Kenny Greenberg (marito di Ashley Cleveland, nonché produttore del bellissimo Blood di Allison Moorer) alle chitarre, Dan Dugmore alla steel, Mickey Raphael all’armonica, Mike Rojas al piano ed organo e, in un brano, Colin Linden alla chitarra. Il disco inizia benissimo con You Oughta Know Me By Now, una country song tersa e limpida che si dipana in maniera scorrevole e viene gratificata da una melodia immediata ed da una bella steel guitar; Hill Country Boogaloo ci mostra invece il lato rock di Stoney, un pezzo elettrico e cadenzato dal deciso sapore southern accentuato dal coro femminile nel refrain. La vivace Falling And Flying è puro country-rock caratterizzato da un motivo che prende fin dalle prime note, ed una fisarmonica sullo sfondo fornisce l’elemento tex-mex, mentre la gradevole Not One Moment, è un midtempo dallo sviluppo melodico fluido e con un’atmosfera d’altri tempi.
Segue Meet In The Middle, un grintoso country’n’roll in cui in nostro duetta con Tanya Tucker. Message In A Bottle non è il noto successo dei Police ma uno scintillante honky-tonk di stampo classico nello stile di George Jones, uno dei pezzi più riusciti del CD; Evil Angel è un gustosissimo e coinvolgente southern gospel nobilitato dalle voci delle McCrary Sisters e del leader degli Asleep At The Wheel Ray Benson https://www.youtube.com/watch?v=UEJX-6kpImA , mentre Drowning In Moonlight è un languido slow che stempera un po’ la tensione elettrica ed offre un momento di quiete. Worry Be Gone è ancora puro country dallo sviluppo contagioso, gran lavoro di piano e dobro ed una tromba a dare un sapore dixieland, la pianistica I Can’t Help You Say Goodbye è ancora una ballata di buon valore e Let’s Chase Each Other Around The Room è un trascinante honky-tonk dal gran ritmo, texano al 100%. Chiusura con la struggente Thought You’d Want To Know, forse il migliore tra i brani lenti del CD, e con la deliziosa High Time, country song elettroacustica in cui il nostro duetta con Brandon Jenkins, altro noto Red Dirt Man.
Stoney LaRue è uno che non tradisce mai, ma questo già lo sapevamo.
Marco Verdi