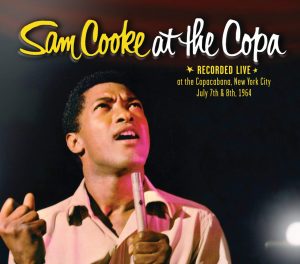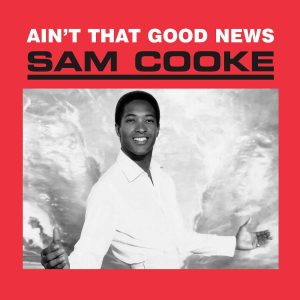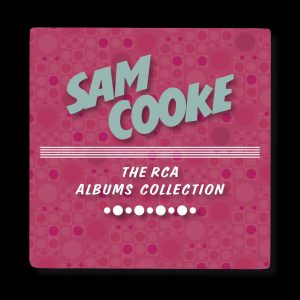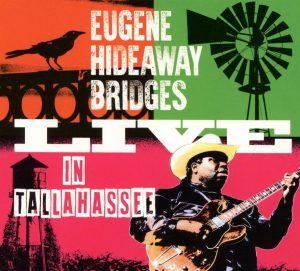AJ Croce – By Request – Compass Records
Nell’ampia categoria che include i “figli di” AJ Croce è sicuramente uno dei più validi ed interessanti (senza fare la lista della spesa, lo metterei più o meno a livello di Jeff Buckley, Jakob Dylan, Adam Cohen, i primi che mi vengono in mente): una vita ricca di tragedie, orfano a meno di due anni per la morte del padre Jim Croce, a quattro anni cieco completamente, anche se poi ha riacquistato parte della visione dell’occhio sinistro, a quindici anni l’incendio della casa in cui aveva sempre vissuto con la madre Ingrid, con la quale ha avuto un rapporto complesso e turbolento, nel 2018 la moglie Marlo, con lui da 24 anni, è morta di una rara malattia cardiaca, lasciandolo con due figli. Nonostante la pesante eredità del padre Jim ha saputo creare un suo approccio alla musica, non seguendo pedissequamente lo stile del babbo, ma ispirandosi al blues, al soul (punti di riferimento Ray Charles e Stevie Wonder), ma con elementi rock, a tratti country, e anche di pop raffinato, grazie all’uso costante del piano di cui AJ è una sorta di virtuoso, ma suona anche tastiere assortite e chitarre: ha realizzato una serie di 10 album, incluso questo By Request, più un disco di rarità dai primi anni di carrierahttps://discoclub.myblog.it/2017/08/20/di-padri-in-figli-aj-croce-just-like-medicine/.
Dopo la morte della moglie Croce ha voluto rientrare, come suggerisce il titolo, con un disco di cover, realizzate con garbo, classe e ottimi risultati, un album veramente godibilissimo: aiutato da una piccola pattuglia di ottimi musicisti, tra i quali spiccano Gary Mallaber alla batteria, Jim Hoke a sax vari, armonica e pedal steel, David Barard al basso, Bill Harvey e Garrett Stoner alle chitarre, Scotty Huff alla tromba e Josh Scaff al trombone, più un terzetto di backing vocalist, in pratica la sua touring band e con la presenza di Robben Ford in un brano, AJ sceglie una serie di canzoni molte adatte al suo stile, in base alla formula “a gentile richiesta” che si applica nei concerti più intimi. E così ecco scorrere Nothing From Nothing, un vecchio brano di Billy Preston, con i fiati molto in evidenza, in questo classico e mosso R&B dove Croce si disbriga con classe al piano https://www.youtube.com/watch?v=dp2sd7IhGsg , la molto più nota Only Love Can Break Your Heart di Neil Young, una delle ballate più belle del canadese, resa molto fedelmente da AJ e soci che però aggiungono un retrogusto da blue eyed soul o country got soul, con la voce sottile di Croce che ricorda quelle dei Bee Gees degli inizi https://www.youtube.com/watch?v=SKy_PcSEyR0 ; scatenata la versione di Have You Seen My Baby di Randy Newman, un’altra delle maggiori influenze del nostro https://www.youtube.com/watch?v=K-Ec5Od0WsI , Nothing Can Change This Love è un oscuro ma delizioso brano di Sam Cooke, con elementi doo-wop, e il piano che viaggia sempre spedito https://www.youtube.com/watch?v=FmeCGbt7glE , Better Day è un country-blues-swing di Brownie McGhee, con Robben Ford alla slide che contrappunta in modo elegante il lavoro della band https://www.youtube.com/watch?v=nQuHTW7viVc . O-O-H Child è il vecchio brano soul dei Five Stairsteps che ultimamente pare tornato di moda, visto che appare anche nel recente disco Paul Stanley con i Soul Station https://discoclub.myblog.it/2021/03/20/ebbene-si-e-proprio-lui-si-e-dato-al-funky-soul-con-profitto-paul-stanleys-soul-station-now-and-then/ , versione adorabile e delicata. https://www.youtube.com/watch?v=56btlAqRZLY
A seguire una robusta rilettura di Stay With Me il classico R&R di Rod Stewart con i Faces, con AJ al piano elettrico e una ficcante slide, Harvey per l’occasione. a ricreare lo spirito ribaldo del brano originale, e non manca neppure il New Orleans soul di Brickyard Blues una canzone di Allen Toussaint, qui resa in una versione a metà strada tra Dr. John e i Little Feat, grazie all’uso del bottleneck del chitarrista Garrett Stoner che interagisce con il piano di Croce, ricreando il dualismo Lowell George/Bill Payne https://www.youtube.com/watch?v=mH-dKTFOfbU . Incantevole anche la versione di San Diego Serenade di Tom Waits, con un arrangiamento che ricorda lo stile dei brani “sudisti” della Band, con tanto di pedal steel sullo sfondo https://www.youtube.com/watch?v=CinzazO7Ti8 , e che dire di una versione barrelhouse blues di Sail On Sailor dei Beach Boys? Geniale e sorprendente! Tra i brani poco noti anche Can’t Nobody Love You di Solomon Burke: non potendo competere con la voce del “Bishop of Soul” AJ opta per un approccio gentile e minimale, con l’organo a guidare e con le coriste che danno il tocco in più, e per completare un disco di sostanza arriva infine Ain’t No Justice un esaltante funky-soul strumentale di Shorty Long targato Motown 1969.
Bruno Conti