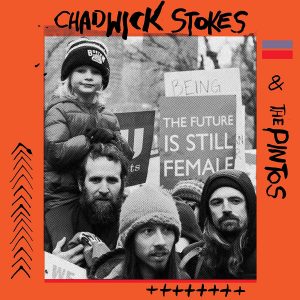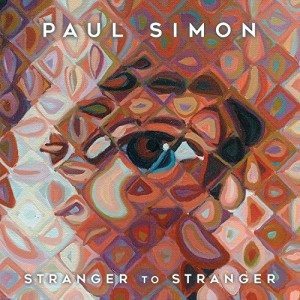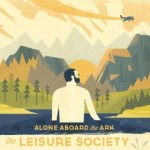Chadwick Stokes & The Pintos – Chadwick Stokes & The Pintos – Ruff Shod/Thirty Tigers CD
Chad Stokes Urmston, meglio conosciuto come Chadwick Stokes, dalle nostre parti non è molto famoso ma negli Stati Uniti è una piccola celebrità, specie nell’area di Boston della quale è originario. Musicista iperattivo, è titolare di una discografia molto corposa nonostante sia ancora relativamente giovane (è del 1976) tra album, singoli, live ed EP, sia come solista che a capo di ben due gruppi, gli State Radio e i Dispatch. Ma Chadwick è, come dicono in America, “larger than life”, dato che a fianco della carriera musicale ha affiancato una vera e propria attività umanitaria che lo vede impegnato in vari settori; il nostro non si limita però a sparare qualche slogan e a sfilare alle manifestazioni a supporto di questa o quella causa come diversi suoi colleghi (anche illustri), ma ha investito in prima persona tempo e denaro costituendo ben due società non profit: la Elias Fund, che si occupa di fornire sviluppo ed istruzione ai bambini dello Zimbabwe (paese nel quale Chad ha anche vissuto per un anno), e la Calling All Crows, che cerca di aiutare le donne disoccupate di tutto il mondo a trovare lavoro.
Un personaggio tutto d’un pezzo, che gira il mondo ed è occupato in mille progetti diversi ma trova anche il tempo di curare la sua proposta musicale, anzi Chad è uno che vive per la musica, ma non ha atteggiamenti da star e preferisce vivere a contatto con la gente normale: poi però scopriamo che forse non è neppure così sconosciuto, dato che qualche anno fa è riuscito a fare ben tre sold-out consecutivi al Madison Square Garden. Ovviamente anche i testi delle sue canzoni sono profondamente impegnati, mentre dal lato musicale Chad ha assorbito tutte le influenze che ha incontrato nel suo girovagare: di base folk, la sua musica ha infatti diversi elementi che vanno dal country al rock, dai ritmi tribali africani al punk, passando anche per reggae e hip-hop, il tutto con una notevole sensibilità pop per le melodie. Tutto questo melting pot sonoro è riscontrabile nel suo nuovo lavoro Chadwick Stokes & The Pintos (dove i Pintos sono il fratello Willy Urmston al banjo, Jon Reilly alla batteria e Tommy Ng al basso), un disco che già al primo ascolto mi ha letteralmente fulminato per la sua bellezza, i suoi suoni gioiosi e colorati e le sue melodie perfette ed immediatamente fruibili. Non sto esagerando: Chadwick in questo disco dimostra di essere, oltre ad un uomo davanti al quale bisogna solo togliersi il cappello, anche un musicista coi controfiocchi, e del quale a questo punto penso occorra recuperare anche qualche lavoro degli anni passati.
Undici canzoni una più bella dell’altra che iniziano con Joan Of Arc (Cohen non c’entra), un brano stimolante e solare, una sorta di folk-pop diretto e dal refrain decisamente orecchiabile: poche note e ne sono già catturato (ed alla fine vorrei rimetterlo da capo). Un banjo strimpellato con vivacità introduce Chaska, altro pezzo contraddistinto da un gusto melodico non comune e dal ritmo forsennato, tra western e country-punk: irresistibile, a dir poco. Blanket On The Moon è una squisita ballata che fonde vari stili ma in cui prevale uno spiccato sapore pop di stampo beatlesiano, ancora (ma non è più una sorpresa) con la melodia in primo piano, Hit The Bell With Your Elbow è un midtempo dalla bella introduzione per chitarra elettrica ed uno sviluppo fluido, di nuovo contraddistinta da un refrain splendido con tracce di Tom Petty https://www.youtube.com/watch?v=KrfghpXv-lk , mentre Love And War è una semplice ma toccante folk song per voce, chitarra e coro.
La saltellante Lost And Found riporta allegria e vivacità nel disco (una sorta di fusione tra i Lumineers e gli Of Monsters And Men, ma in meglio), What’s It Going To Take è puro reggae, un genere che non mi fa impazzire ma il gusto melodico di Chadwick fa la differenza, brano che si contrappone al folk elettrificato e moderno di Let Me Down Easy, un brano che mi ricorda il primissimo Todd Snider. La lenta ed intensa Sand From San Francisco, altro pezzo senza sbavature (ed ancora con un ritornello corale da applausi) precede le conclusive Mooshiquoinox e Second Favorite Living Drummer, rispettivamente una breve folk tune acustica alla Simon & Garfunkel ed una rock song scorrevole e forse un po’ ruffiana nel refrain ma sempre decisamente piacevole. Dirò una banalità, ma se al mondo ci fossero più persone come Chadwick Stokes il mondo stesso sarebbe un posto migliore. E non solo musicalmente.
Marco Verdi