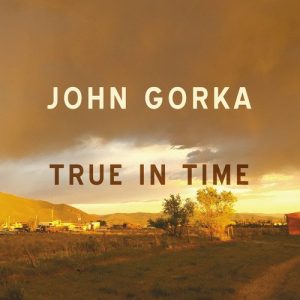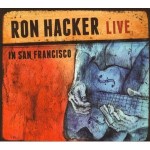Derek Davis – Resonator Blues – Southern Blood Records
Devo dire che sono sempre stato sospettoso dei metallari pentiti, o anche non pentiti, che improvvisamente si scoprono bluesmen a tutto tondo: c’è stata qualche eccezione, penso a Gary Moore (che però aveva già ruotato intorno al genere ad inizio carriera), oppure nel country di recente Aaron Lewis https://discoclub.myblog.it/2019/07/13/un-ex-metallaro-che-ha-trovato-la-sua-reale-dimensione-aaron-lewis-state-im-in/ , anche Gary Hoey che non è un “metallaro” puro https://discoclub.myblog.it/2019/04/11/un-virtuoso-elettrico-ed-eclettico-questa-volta-senza-esagerazioni-gary-hoey-neon-highway-blues/ , e sinceramente al momento non me ne vengono in mente altri, che comunque ci sono, pensate a tutti i vari gruppi e solisti che per definizione inseriamo nel filone blues-rock o rock-blues, a seconda della durezza del suono. Derek Davis è stato, ed è tuttora (visto che mi risulta siano ancora in attività), leader dei Babylon A.D. , un gruppo hard rock/metal in pista da fine anni ’80, di cui Davis era la voce solista ma non il chitarrista. Per Resonator Blues il musicista si scopre quindi anche chitarrista, e in questo terzo album da solista, dopo due dischi che esploravano il rock e il soul/R&B, si rivela provetto praticante delle 12 battute più classiche, tuffandosi nel Mississippi Delta blues con grande profusione di bottleneck e slide, oltre che di momenti acustici.
Non siamo di fronte ad un capolavoro, ma si percepisce la sincerità di questa operazione, in cui Davis ha scritto dieci brani originali e scelto due cover di peso per estrinsecare il suo omaggio al blues:il nostro amico ha una voce roca e vissuta (visti i trascorsi musicali), a tratti “esagerata”, ma nell’insieme accettabile. Nell’iniziale Resonator Blues c’è un approccio vocale quasi (ho detto quasi) alla Rory Gallagher, voce ruspante e partecipe, un bel drive della ritmica, molto Chicago blues anni ’50 o se preferite tipo il Thorogood più tradizionale, un bel lavoro della slide e un delizioso assolo del piano di David Spencer, mentre alla batteria siede il fido Jamey Pacheco dei Babylon A.D., chitarre e basso le suona lo stesso Derek, risultato finale molto gradevole; Sweet Cream Cadillac sembra quasi un pezzo di R&R primi anni ’60, con Davis impegnato alla Silvertone acustica, sempre modalità slide e un approccio che rimanda al Brian Setzer meno attizzato, ma anche al Rory Gallagher appena citato. Mississippi Mud potrebbe essere un omaggio a Muddy Waters, ma anche al suono pimpante dei Creedence dei primi dischi, sempre fatte le dovute proporzioni, con ripetute sventagliate di bottleneck, mentre fa la sua apparizione anche l’armonica di Charlie Knight; Penitentiary Bound è una vera sorpresa, una folk ballad deliziosa, solo voce, chitarra acustica e delle percussioni appena accennate, il consueto tocco di slide, e una bella melodia che si anima nel finale.
In Jesus Set Me Free troviamo Rich Niven all’armonica, per una incalzante cavalcata con qualche retrogusto di musica degli Appalachi, rivista nell’ottica più frenetica di Davis, che non fa mancare neppure la sua primitiva 3 string Cigar Box Guitar; Red Hot Lover è un gagliardo blues di stampo texano di quelli tosti e tirati, con chitarra ed armonica in evidenza. Death Letter è la prima cover, si tratta del celebre brano di Son House, ancora Delta Blues rigoroso ed intenso, vicino allo spirito dei grandi bluesmen del Mississippi, con Whiskey And Water e Unconditional Love, più elettriche e tirate entrambe, con l’armonica di Knight a fare da contraltare alla chitarra incattivita di Davis e il sound che quasi si avvicina a quello della vecchia sua band, più roots-rock ma sempre energico anziché no, con la slide costantemente mulinante, come viene ribadito in una potente cover di It Hurts Me Too di Elmore James, con il bottleneck distorto di Derek Davis che ricrea le atmosfere ferine di Stones e Led Zeppelin. Anche in Back My Arms lo spirito del blues più genuino viene rispettato, sembra quasi di ascoltare i vecchi Fleetwood Mac nei brani a guida Jeremy Spencer. E anche la conclusiva Prison Train non molla la presa su questo Festival della slide, sempre con il valido supporto dell’armonica di Knight.
Forse Davis non saprà ripetersi in futuro, ma per questa volta centra l’obiettivo di un bel disco di blues, solido e per certi versi rigoroso.
Bruno Conti