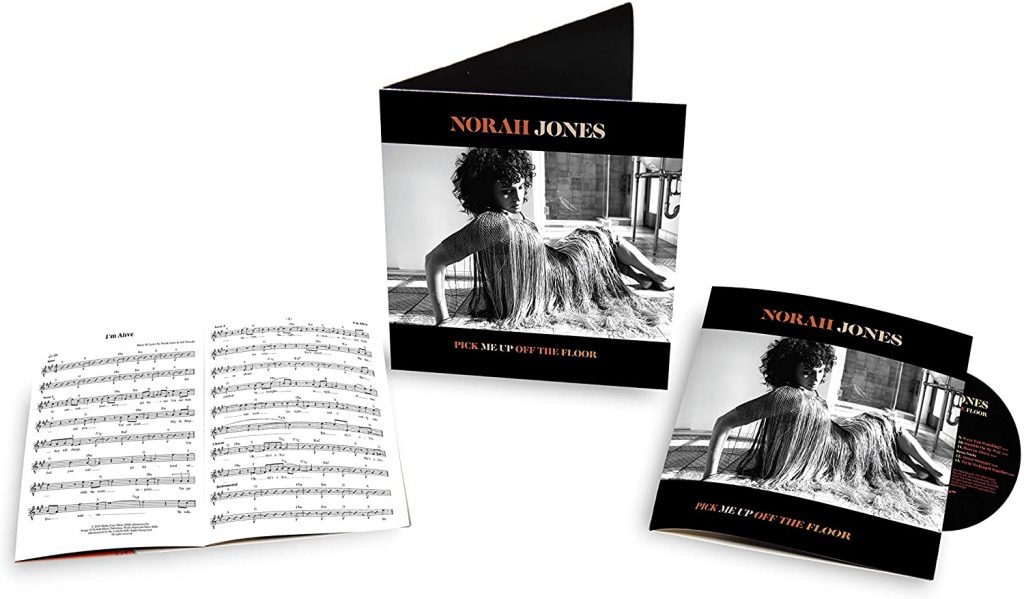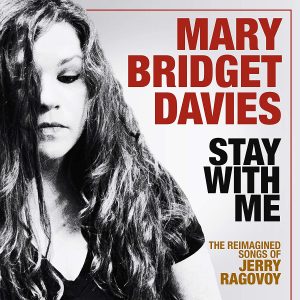David Bowie – I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) – Parlophone/Warner Record Store Day 2CD – 2LP
Aldilà del dolore per l’improvvisa scomparsa del loro idolo nel gennaio del 2016, negli ultimi anni i fans di David Bowie hanno avuto di che leccarsi i baffi tra live inediti, i quattro cofanetti retrospettivi con gli album della sua discografia ed anche qualche aggiunta (una serie che però è ferma a Loving The Alien del 2018, che prendeva in esame gli anni ottanta della popstar inglese) ed il bellissimo box quintuplo dello scorso anno Conversation Piece, con le sessions ed i demo casalinghi inerenti all’album del 1969 Space Oddity. Quest’anno si è invece deciso di celebrare (si fa per dire) The Man Who Sold The World, disco del 1970 di Bowie che il sei novembre verrà rimesso sul mercato, remixato ma senza mezza bonus track, con il titolo di Metrobolist (che sembra fosse il nome originale dell’album) e la copertina cambiata con una tra l’altro delle più brutte viste ultimamente: in poche parole, un’iniziativa ridicola.
Gli estimatori del Duca Bianco si possono comunque consolare con un nuovo live inedito uscito a fine agosto in occasione della prima parte del Record Store Day (che quest’anno a causa del Covid è stato diviso in tre), sia in doppio LP che in doppio CD: I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) come suggerisce il titolo si occupa di uno show tratto dalla tournée del 1974 per promuovere l’album Diamond Dogs, e precisamente del concerto del 20 ottobre al Michigan Palace di Detroit (al quale manca la parte finale per problemi tecnici, sostituita però da quella registrata al Municipal Auditorium di Nashville il 30 novembre). Non è la prima volta che questo tour, che si svolse esclusivamente tra Canada e Stati Uniti, viene documentato ufficialmente, e la sua particolarità fu quella di essere diviso in tre parti con tre band diverse: il famoso album dal vivo dell’epoca David Live si occupava di un concerto a Philadelphia nel primo periodo (giugno-luglio), la seconda parte (settembre) è stata presa in esame tre anni fa in Cracked Actor, mentre il CD di cui mi occupo oggi è inerente alla terza fase.
Un’altra caratteristica fu che tra il primo e secondo segmento (quindi in agosto) Bowie incise le canzoni che avrebbero formato l’anno seguente l’album Young Americans, un disco con un suono influenzato dal soul ed errebi di Philadelphia, e la restante parte del tour da settembre in poi sarà ispirata da questo tipo di sound: da qui il nomignolo “The Soul Tour” (o anche “The Philly Tour”). I’m Only Dancing vede Bowie in ottima forma (con una voce leggermente arrochita dai molti concerti) accompagnato da un gruppo di prima qualità, cosa normale per il nostro che si è sempre affidato a musicisti formidabili: Earl Slick alla chitarra solista, Carlos Alomar alla ritmica, Mike Garson alle tastiere, la futura star del sax David Sanborn, il noto bassista Willie Weeks, Dennis Davis alla batteria, Pablo Rosario alle percussioni e ben sei backing vocalists, tra i quali spicca l’allora sconosciuto Luther Vandross, anch’egli destinato ad una carriera di grande successo.
Il doppio CD, poco meno di 90 minuti in tutto, è piacevole dalla prima all’ultima canzone grazie ad una miscela accattivante tra rock, soul, errebi e funky, un concerto scoppiettante che inizia con la classica Rebel Rebel e continua con l’altrettanto popolare John, I’m Only Dancing (Again), mettendo in fila in maniera brillante brani la cui fama è arrivata fino ad oggi come Changes, The Jean Genie (dall’arrangiamento quasi blues), Suffragette City, Rock’n’Roll Suicide e Diamond Dogs ed altri meno noti come la funkeggiante 1984, la potente rock ballad Moonage Daydream (con grande assolo finale di Slick), la soulful Rock’n’Roll With Me, che a dispetto del titolo è uno slow, e, vista la location, non poteva mancare la roccata Panic In Detroit.David offre anche in anteprima quattro pezzi da Young Americans: la title track, puro blue-eyed soul, l’elegante ballata Can You Hear Me, l’inedito It’s Gonna Be Me (che uscirà sulle future ristampe), e l’annerita Somebody Up There Likes Me, con Sanborn protagonista. Dulcis in fundo, Bowie si diverte a proporre cover abbastanza eterogenee infilandole qua e là, alcune appena accennate ed altre in medley creati appositamente: ascoltiamo quindi una suadente Sorrow dei McCoys, la celeberrima Knock On Wood di Eddie Floyd, la meno nota Foot Stompin’ (The Flares) ed uno standard jazz degli anni venti intitolato I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate; infine, c’è anche un doppio omaggio a Beatles e Rolling Stones, rispettivamente con Love Me Do e It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It).
Un buon live quindi, forse non indispensabile per l’acquirente occasionale (anche perché non costa pochissimo), ma che gli appassionati di David Bowie si saranno probabilmente già accaparrati.
Marco Verdi