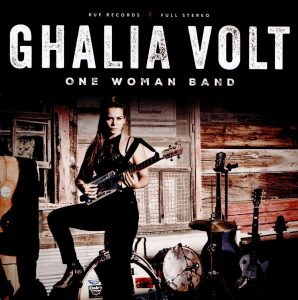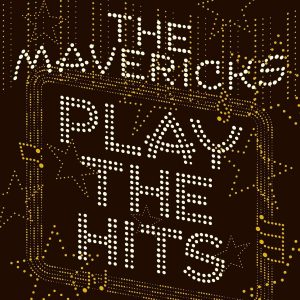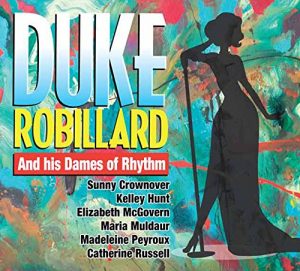Dale Watson – Presents: The Memphians – BFD CD
Dale Watson, prolifico countryman nativo dell’Alabama ma texano d’adozione, è fermo discograficamente a Call Me Lucky del 2019, ma non è che nel frattempo se ne sia stato con le mani in mano. Al contrario, ha apportato alla sua vita un paio di cambiamenti piuttosto importanti: si è trasferito da Austin a Memphis (dove ha aperto anche un ristorante, Hernando’s Hideaway, ed uno studio di registrazione) e si è sposato con la singer-songwriter Celine Lee. Ma il passaggio a Memphis ha portato in Dale anche un mutamento dal punto di vista musicale, in quanto il suo nuovo lavoro The Memphians è in tutto e per tutto un tributo alla sua nuova città ed alle origini del rock’n’roll, un album in cui il nostro mostra influenze alternative a quelle dei suoi “honky-tonk heroes”: Elvis Presley, Carl Perkins, i dischi della Sun Records e, essendo Dale anche un valido chitarrista, gente come Scotty Moore, Hank Marvin, Duane Eddy e lo stesso Perkins. The Memphians è quindi un disco molto meno country del solito, ma che presenta un range sonoro che va dal rock’n’roll allo swing, dal rockabilly alla ballata anni 50 e che, soprattutto, non ci fa sentire la bella voce baritonale di Watson in quanto è un lavoro al 100% strumentale.
A dire il vero quando ho letto questa notizia ho storto un po’ il naso, nello stesso modo in cui l’avevo storto nel 1999 (facendo le debite proporzioni tra i due artisti) quando Willie Nelson aveva pubblicato lo strumentale Night And Day: ad ascolto ultimato però devo ammettere che The Memphians risulta essere un dischetto godibile e ben fatto, che regala all’ascoltatore mezz’oretta indubbiamente piacevole, anche se io al Dale Watson cantante non rinuncerei mai. C’è anche un po’ di Italia, in quanto il secondo chitarrista (e co-autore con Watson di quattro pezzi, mentre gli altri sono del solo Dale) è il catanese trapiantato a Memphis Mario Monterosso, affiancato dalla sezione ritmica di Carl Caspersen al basso e Danny Banks alla batteria, e soprattutto dal bravissimo pianista T. Jarrod Bonta, collaboratore di lungo corso del leader, e dall’ottimo sassofonista Jim Spake. L’iniziale Agent Elvis è un chiaro omaggio a Duane Eddy, un pezzo cadenzato con chitarrone twang in evidenza ed il sax che si prende il suo spazio mentre in sottofondo la band accompagna con discrezione guidata dal pianoforte spazzolato da Bonta https://www.youtube.com/watch?v=5YMhC-Clr0k . Dalynn Grace, languida ballata d’altri tempi che fa venire in mente gli episodi più melodici di Elvis (ma la voce, come ho già detto, non c’è), con una chitarra vagamente hawaiana ed un ritmo da bossa nova https://www.youtube.com/watch?v=xX4jZ04UL38 , si contrappone alla spedita Alone Ranger, brano di stampo quasi western che riprende il sound degli Shadows, con sax ed organo che si ritagliano entrambi una parte da solisti https://www.youtube.com/watch?v=Xy81bQmz16s .
Standin’ In Line è una gradevolissima canzone ritmata e ricca di swing, tra country e rockabilly con una spruzzata di jazz, Serene Lee riporta il CD su languide atmosfere da ballo della mattonella (mi aspetto di sentire arrivare Chris Isaak da un momento all’altro), Deep Eddy è un altro suggestivo pezzo che profuma di Shadows lontano un miglio, con un approccio raffinato ed una delle migliori performance chitarristiche del disco. Hernando’s Swang è ispirata al locale aperto da Dale a Memphis, ed è un coinvolgente brano a tutto swing con i soliti eccellenti spunti di piano e sax https://www.youtube.com/watch?v=JR3X_JYyXSM , Mi Scusi (avete letto bene) è puro rock’n’roll dal ritmo decisamente sostenuto https://www.youtube.com/watch?v=pKWrs3G_DpE , mentre 2020 riavvicina il nostro al country con una veloce canzone influenzata da Chet Atkins, e la conclusiva Remembering Gary vede Dale lasciarci con uno slow suadente e dall’aria nostalgica. Dopo anni di ottimo honky-tonk texano ci sta che Dale Watson possa cambiare genere, ma la scelta di non usare la voce ha reso The Memphians niente più di un piacevole divertissement.
Marco Verdi