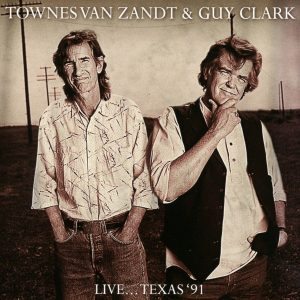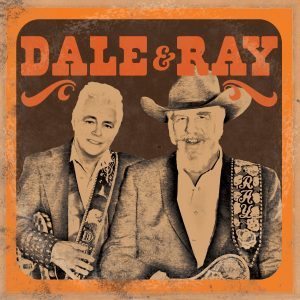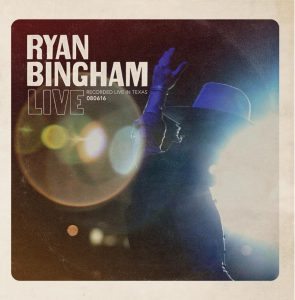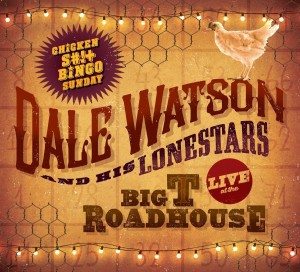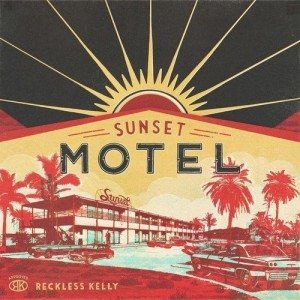Townes Van Zandt & Guy Clark – Live…Texas 1991 – Klondike CD
Se leggo le parole “Texas” e “songwriter” nella stessa frase, due sono i nomi che mi vengono immediatamente in mente: Townes Van Zandt e Guy Clark. Due maestri assoluti del cantautorato del Lone Star State, ma la cui grandezza ha sempre trasceso i confini del loro stato di appartenenza per rappresentare due delle influenze principali per molti musicisti a stelle e strisce. I due erano anche grandi amici, e, last but not least, due notevoli performers: è quindi con grande piacere che mi sono avvicinato (nonostante la mia proverbiale diffidenza verso i live non ufficiali tratti da broadcast radiofonici, ma qualche eccezione bisogna pur farla) a questo Live…Texas 1991, un bellissimo CD composto da dodici tracce (sarebbero tredici, ma una è un’introduzione parlata) tratto da un concerto tenutosi al famoso Cactus Café di Austin, il 16 Febbraio del 1991.
Sul palco ci sono solo Townes e Guy con le loro chitarre e le loro storie da raccontare, ma non serve di più, in quanto la serata scorre via che è un piacere, anche perché i due hanno un repertorio che pochi possono vantare; in più, quasi ogni canzone è intervallata da interventi scherzosi, che smentiscono la fama di personaggi ombrosi che si erano fatti. Come ulteriore ciliegina c’è la qualità dell’incisione, davvero eccellente. Già dall’apertura, con l’intensa No Lonesome Tune, unico brano cantato a due voci e con l’accompagnamento cristallino delle chitarre, si capisce che la serata è di quelle giuste. Con il secondo pezzo i due hanno già il pubblico in pugno: L.A. Freeway è infatti uno dei capolavori assoluti di Clark, ed è sempre una goduria risentirla (qui Townes si limita ad accompagnare, i riflettori sono tutti per Guy, che a metà canzone si mette addirittura a raccontare una storia autobiografica semiseria); Guy rende il favore lasciando spazio all’amico per la polverosa Mr. Mudd & Mr. Gold, una ballata texana al 100%, un western tune dalla melodia molto discorsiva, quasi parlata.
Townes bissa con Fraternity Blues, un vero talkin’ tra Guthrie e Dylan, che diverte il pubblico smentendo, ribadisco, in parte la fama di musone del nostro, mentre Guy piazza subito dopo un altro colpo da maestro con le splendide Old Friends e Texas 1947, inframezzate dalla spoglia e drammatica Marie di Van Zandt. La disimpegnata e divertente Homegrown Tomatoes e Let Him Roll, un altro talkin’ molto intenso stavolta appannaggio di Clark, preludono al gran finale in cui, a parte una vibrante Snowin’ On Raton, ascoltiamo le inimitabili Pancho & Lefty e Desperados Waiting For A Train, due delle più belle canzoni della loro epoca (e non solo texane), proposte in due versioni scintillanti e di grande intensità, che rendono questo CD difficile da ignorare.
Marco Verdi