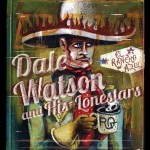Jesse Dee – On My Mind/In My Heart – Alligator
Questa recensione potrebbe appartenere a due rubriche (se esistessero): “E intanto la Alligator non sbaglia un colpo” e “Neri Dentro”. Per l’etichetta di Chicago si tratta dell’ennesimo disco centrato, in una sequenza di pubblicazioni che negli ultimi anni non hanno mai mancato l’obiettivo di divertire ed emozionare. Il divertire è uno degli scopi massimi di questo CD di Jesse Dee (il suo secondo, anche se in alcune discografie gliene attribuiscono un terzo, ma è di un omonimo canadese), soulman bianco di Boston, la patria della J.Geils Band e Peter Wolf, volendo rimanere nel genere “musica nera rivisitata”. Come il suo grande amico e sodale, con cui spesso divide il palcoscenico dal vivo, e che sta dall’altra parte dell’Oceano, ovvero James Hunter, Jesse Dee è un grande appassionato e cultore del soul, ma quello vero, Al Green, Otis Redding, Etta James, soprattutto Sam Cooke, ma anche il primo Marvin Gaye, i Temptations e lo stile più leggero e pop della prima Motown e mille altri che non citiamo ma si possono immaginare.
Già il precedente Bittersweet Batch pubblicato dalla Munich Records aveva lasciato intravedere il suo talento, che ora viene confermato da On My Mind/In My Heart, non parliamo di capolavori ma di dischi piacevolissimi da gustare, centellinare, mentre ascolti questo giovane che in un mondo musicale falso e plastificato è in grado di (ri)proporre una musica fresca e frizzante come quella dei suoi predecessori, senza la stessa classe, ovviamente indirizzata ai cultori del genere, ma che può essere apprezzata da tutti senza riserve, ti consoli delle brutture di molto cosidetto “nu soul” attuale. I brani sono tutti “originali” (almeno nel nome e nel contenuto, magari le melodie un po’ meno), firmati dallo stesso Jesse Dee, che si avvale di un gruppo di musicisti, probabilmente non molto conosciuti al di fuori della’area dello stato del Massachussetts (dove è stato registrato l’album), ma assolutamente validi e pertinenti allo stile che perseguono.
Undici brani che si muovono nei meandri del soul e del R&B con leggerezza estrema: dall’apertura ricca di fiati della title-track che tra organo e chitarrine ritmiche ficcanti permette al bravo Jesse di mettere in evidenza la sua voce vellutata e senza tempo, una partenza blue-eyed soul, magari non è un testifier alla Redding o alla Pickett, ma si capisce subito che è uno bravo, come conferma il ritmo alla Marvin Gaye primo periodo della funky No matter where I Am propulsa da un basso molto marcato o le belle melodie della dolce Fussin’ and Fightin’ dove aleggia lo spettro di Sam Cooke, ma anche il miglior Robert Cray in salsa soul potrebbe essere un riferimento. I Won’t forget about you ha quella andatura alla Temptations di The Way You Do The Things I Do, divertente e spensierata, sempre con i fiati in libertà. Ottima anche Tell Me (Before It’s Too late) già nel suo repertorio live da qualche anno, con retrogusto gospel e qualche prova di falsetto sempre gradita.
E che dire del coinvolgente duetto con Rachael Price (una bravissima giovane cantante dell’area di Boston, ma nativa del Tennessee, solista nei Lake Street Dive, gruppo che vi consiglio), ha la spensieratezza dei duetti dell’epoca d’oro del soul e tutti e due i cantanti hanno quel quid inspiegabile nella voce che distingue i cavalli di razza dai ronzini. Anche in The Only Remedy sfoggia un falsetto in alternativa alla sua voce naturale arricchita da quel tocco di raucedine che fa soul dal primo ascolto, mentre la dolce ballata What’s A Boy Like Me To Do? ci riporta al Cooke più mellifluo e anche melismatico e vi assicuro che è un bel sentire, potrebbe ricordare anche i brani più melò della scomparsa Amy Winehouse. Sweet Tooth con la sua energia sixties potrebbe far parte del repertorio più scatenato del suo omologo James Hunter. Boundary Line è un sontuoso gospel soul alla Al Green, passione e grinta convogliati in una voce in grado di emozionare. E per finire una Stay Strong di nuovo sbarazzina come i singoli più spensierati di quel Sam Cooke che è un po’ il punto di riferimento irrinunciabile della musica di Jesse Dee, bianco fuori ma nero dentro. E la ricerca continua.
Bruno Conti