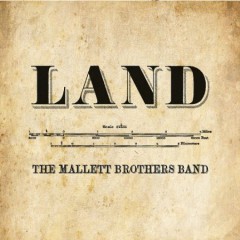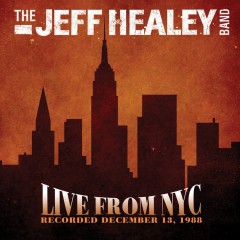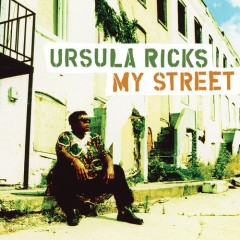Katey Sagal – Covered – Entertainment One
Un bel giorno, tra il lusco e il brusco, mi trovo tra le mani questo CD, Covered, molto bello, ma il nome della cantante, Katey Sagal, mi dice poco o nulla, anche se, come avrebbe detto Totò, quella faccia non mi è nuova (solo la faccia, nella battuta di Totò si alludeva ad altro)! Ai nostri tempi è diventato facile, digiti il nome su Google (o Yahoo o quello che preferite) e ti si apre un mondo: alla faccia si affianca una persona. Attrice, doppiatrice cantante, aveva fatto già due dischi, Well nel 1994 e Room nel 2004, quindi secondo la regola, più o meno, dei dieci anni, era tempo di farne uno nuovo. Ma torniamo, per un attimo, all’attrice: soprattutto serie televisive, una decina di stagioni di Sposata…con figli, anche di più, dal 1999, come una delle voci originali della serie a cartoni animati Futurama,e poi 8 Semplici Regole, The Shield, Lost, Boston Legal, dal 2008 Sons Of Anarchy, oltre a molte partecipazioni a film e telefilm.
Negli anni ’70 e ‘80, e questo ci interessa di più, ha fatto la corista, tra gli altri, per Bob Dylan e Bette Midler e di conseguenza deve avere stretto dei rapporti con il mondo della musica americana che si rivelano fondamentali per questo album. Intanto liberiamoci dai pregiudizi sugli attori che non sanno cantare, ce ne sono molti bravi, l’ultima che mi viene in mente è Minnie Driver, andando a ritroso, Billy Bob Thornton, Bruce Willis, eccetera, eccetera. Ma Katey Segal canta veramente bene, un bel contralto, una voce calda ed espressiva, per certi versi, appena un filo inferiore, mi ha ricordato la giovane Rumer, che tanto mi aveva impressionato negli ultimi anni, anche con il disco delle cover, Boys Don’t Cry, dello scorso anno. Come dice il titolo di questo album, Covered, siamo su quei territori, 9 canzoni, note, anzi notissime e un originale firmato da Bob Thiele Jr, che è anche produttore del disco e polistrumentista, e da Tonio K, vedo delle manine che si alzano, bravi, ricordate? Ma a differenza di altri casi, dove per perversi motivi, vengono scelte canzoni perlopiù oscure dai repertori degli artisti da interpretare, questa volta la Siegal, ha scelto tra il meglio che c’era in circolazione.
Free Fallin, di Thomas Earl Petty e Jeff Lynne (anche questo vezzo di scrivere i nomi completi degli autori è segno di rispetto), For A Dancer di Jackson Browne, Follow The Driver è l’unico brano originale, Goodbye di Stephen F. Earle, I Love You But I Don’t Know What To Say di Ryan Adams, Gonna Take A Miracle di Randazzo,Weinstock, Stallman, ma resa immortale da Laura Nyro, Orphan Girl di Gillian Welch, For Free di Joni Mitchell, Secret Heart di Ron Sexsmith, Roses And Cigarettes di Ray LaMontagne! Ma neanche nelle mix tapes dei vostri sogni c’è un repertorio così. E le fa un gran bene: con l’aiuto di gente come Matt Chamberlain alla batteria, Greg Leisz alle chitarre, Davey Faragher al basso, Freddy Koella al violino, Bobby Mintzer al clarinetto, Lyle Workman alla chitarra, tanto per citare alcuni dei musicisti impiegati nell’album. Ah, un certo Jackson Browne, come seconda voce, in una sontuosa versione di Goodbye di Steve Earle, con un’aria tipicamente messicana provvista dal laud e dalla banduria di Javier Mas e dal violino di Alkexandru Bublitchi (ha un qualcosa di Romance in Durango di Dylan).
Ma lei canta con voce vellutata tutti i brani, forse quello leggermente meno riuscito è l’iniziale Free Fallin’ troppo legato allo stile inconfondibile di Tom Petty, ma non è comunque una brutta versione. Bellissima Gonna Take A Miracle, soul raffinatissimo, soffusa For A Dancer, solo chitarra, pedal steel e organo, deliziosa la versione di Secret Heart di Ron Sexsmith, che ricordo in una interpretazione fantastica dell’autore in una puntata della trasmissione Spectacle di Costello. E poi il brano nuovo scritto appositamente per l’album che è una sorta di soul ballad alla People get ready, rivisata in chiave rock orchestrale. E il valzerone country rock del brano di Ryan Adams, con la pedal steel insinuante di Leisz, è poco bello? Anche il country-folk paesano del brano di Gillian Welch e la ripresa del capolavoro di Joni Mitchell, con lo splendido clarinetto di Mintzer in evidenza, confermano una sintonia completa con il lavoro di queste grandissime cantautrici. Roses And Cigarettes di Ray LaMontagne sancisce definitivamente che là fuori ci sono tante bellissime canzoni, basta saperle cercare, e cantare! Veramente una bella sorpresa, brava!
Bruno Conti