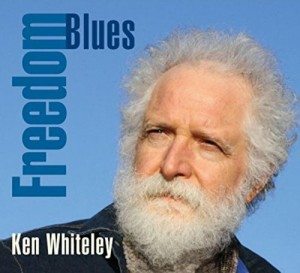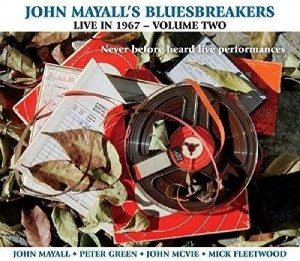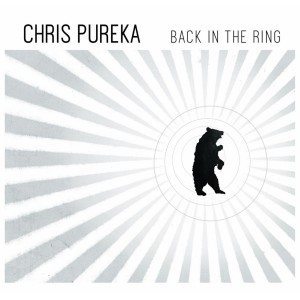Bad Company – Live 1977 & 1979 – Rhino/Warner 2CD
Sembra incredibile, ma i Bad Company, uno dei gruppi più popolari degli anni settanta (in un certo senso una delle rock band per antonomasia) all’epoca non aveva mai pubblicato un disco dal vivo, cosa ancor più strana dato che il “doppio live album” era un po’ il punto di arrivo per tutti i musicisti di quei tempi. Sarà che il loro manager era lo stesso dei Led Zeppelin (che un live lo avevano fatto uscire, ma The Song Remains The Same non rifletteva minimamente i leggendari show del Dirigibile), e cioè il famoso Peter Grant, il quale non amava gli album dal vivo, ma resta il fatto che il supergruppo formato da Paul Rodgers, Simon Kirke (entrambi ex Free), Mick Ralphs (ex chitarrista dei Mott The Hoople) ed il bassista Boz Burrell (già bassista dei King Crimson), che era un combo formidabile on stage, vide la propria carriera limitata ai lavori di studio, almeno per quanto riguarda il periodo d’oro con Rodgers alla voce ( quindi a parte un trascurabile Live In Albuquerque 1976 uscito nel 2006 per la famigerata Cleopatra). Oggi finalmente la Rhino ripara al torto, e lo fa in maniera sontuosa, con uno splendido doppio CD intitolato semplicemente Live 1977 & 1979, che documenta il meglio di due differenti concerti, appunto del 1977 a Houston e del 1979 all’Empire Pool di Londra, con una qualità di incisione perfetta, un libretto esauriente e ben due ore e mezza di pura e scintillante rock music. Paul Rodgers è sempre stato uno dei migliori cantanti inglesi, in possesso di una voce calda dalle sfumature blues e soul, potente e dolce a seconda delle esigenze (non per niente in anni recenti Brian May e Roger Taylor lo hanno chiamato per sostenere le parti vocali di Freddie Mercury nella reunion live dei Queen), la sezione ritmica di Burrell e Kirke è uno stantuffo cresciuto a pane e rock, e Ralphs un chitarrista spesso dimenticato ma dal fraseggio superbo. Una rock’n’roll band con il suono spesso più americano che britannico, e che finalmente possiamo apprezzare al suo apice in questi due CD, nei quali soltanto due brani si ripetono (Shooting Star e Feel Like Makin’ Love, oltre al Drum Solo di Kirke, una pratica tipica dell’epoca ma un po’ noiosa da ascoltare) e dove, purtroppo, mancano totalmente i pezzi dei Free, cosa che mi ha un po’ sorpreso dato che metà del gruppo proviene da lì.
Il primo CD è una bomba, e parte con una tonante versione di Burnin’ Sky (titolo anche del nuovo disco di quell’anno), dominata dai riff secchi di Ralphs e dalla voce potente di Paul, che confluisce senza interruzioni nell’altrettanto vigorosa Too Bad, un avvio micidiale per un doppio album che promette faville. E le promesse non vengono smentite, a cominciare da Ready For Love, classica ballata anni settanta, otto minuti di rock a cinque stelle, proseguendo con la mossa Heartbeat, tra rock ed errebi (perfetta per la voce del leader) e con la fluida Morning Sun. Non sto a nominarle tutte, ma di certo non posso tralasciare l’aggressiva Man Needs Woman, con Rodgers e Ralphs formidabili, la godibile Leaving You o la splendida Shooting Star, uno dei loro pezzi più noti. Senza dimenticare la scintillante rock ballad Simple Man, con la voce di Paul più soulful che mai, l’irresistibile rock’n’roll Movin’ On, il quasi hard rock di Live For The Music e la bellissima Feel Like Makin’ Love, uno dei maggiori hit del gruppo.
Il secondo CD, tratto dal tour di Desolation Angels, è leggermente inferiore (ma proprio di poco), più che altro per un paio di pezzi minori e l’utilizzo per fortuna limitato del synth: si parte comunque benissimo con la stupenda Bad Company, una delle loro signature songs, guidata dal piano di Rodgers (suonato peraltro molto bene), melodia epica, solito prolungato assolo di Ralphs e notevole jam session finale, seguita da Gone, Gone, Gone, unico brano scritto da Burrell ed infatti non un granché, ma si corre subito ai ripari con una sontuosa Shooting Star, anche meglio di quella del 1977. Gli altri brani degni di nota (ma non è che quelli che non nomino li dovete saltare) sono il saltellante rock blues Rhythm Machine, con Ralphs incontenibile, la quasi sudista Oh, Atlanta, che non è quella dei Little Feat ma ne ricalca quasi lo stile, la vibrante e maestosa Run With The Pack, la rutilante Evil Wind, con la sezione ritmica che picchia come poche. Passando per un trittico di puro e trascinante rock’n’roll formato da Honey Child, Rock Steady e Rock’n’Roll Fantasy e per finire con la solita cristallina Feel Like Makin’ Love e con la strepitosa Can’t Get Enough, il loro più grande successo come singolo. In mezzo, l’unica cover del doppio, un’ottima e molto “hendrixiana” versione di Hey Joe.
I due live album usciti di recente che documentavano la reunion dei membri originali (meno Burrell, che è passato a miglior vita nel 2006) erano buoni, ma quello da avere assolutamente è questo Live 1977 & 1979.
Marco Verdi