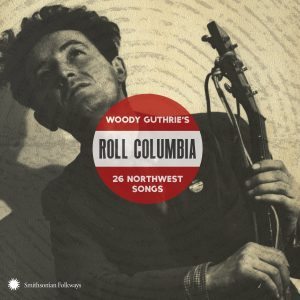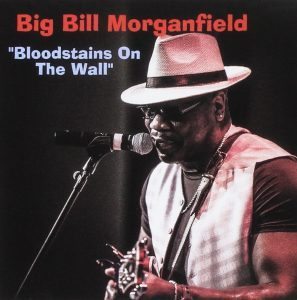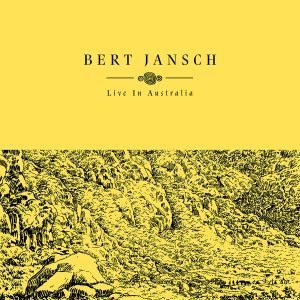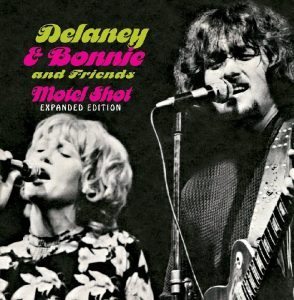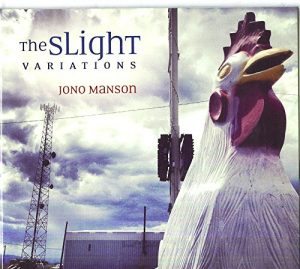VV.AA. – Roll Columbia: Woody Guthrie’s 26 Northwest Songs – Smithsonian Folkways 2CD
Nel 1941 l’America si stava risollevando a fatica da un decennio tremendo, conseguente alla crisi finanziaria del 1929 ed al periodo conosciuto come Grande Depressione (ed era imminente, anche se chiaramente non lo si sapeva ancora, l’ingresso in guerra in seguito all’attacco del Giappone a Pearl Harbor, che avverrà nel Dicembre di quello stesso anno): era un periodo di duro lavoro e di ricostruzione, ed una parte fondamentale del processo era ridare un po’ di ottimismo alla popolazione. Una delle iniziative mirate appunto a pubblicizzare i grandi sforzi che venivano fatti, fu l’incarico che la Bonneville Power Administration diede al famoso folksinger Woody Guthrie, incarico che consisteva nello scrivere una serie di canzoni atte a commentare un documentario sulla costruzione di dighe e centrali idroelettriche lungo il fiume Columbia, il più importante corso d’acqua della zona nord-ovest del Pacifico (che nasceva in Canada, nella British Columbia, e si gettava nell’oceano dopo aver attraversato gli stati di Washington ed Oregon). E Woody, già affermato songwriter, affrontò il lavoro con grandissima dedizione e professionalità, scrivendo la cifra record di ben 26 canzoni in 30 giorni (e, almeno per un mese, rappresentò il paradosso di un cantautore noto per essere contro il sistema che però allo stesso tempo lavorava per l’amministrazione federale, un vero uomo di lotta e di governo…), canzoni alcune delle quali sono entrate di diritto tra i suoi classici, come Pastures Of Plenty, Roll On, Columbia, Roll On e The Grand Coulee Dam (dal nome della più famosa tra le dighe costruite).
Oggi, a 75 anni da quell’evento, la leggendaria Smithsonian Folkways (mi tremano quasi le mani solo a pensare che nel 2017 sto recensendo un disco pubblicato da loro) ha preparato questo meraviglioso doppio CD intitolato Roll Columbia: Woody Guthrie’s 26 Northwest Song, un progetto che, anche se copertina e titolo potrebbero far pensare ad una raccolta di Guthrie, è in realtà un tributo a quelle 26 canzoni, da parte di tutta una serie di musicisti che hanno attinenza con la zona geografica in questione, sia che ci siano nati sia che ci risiedano. E l’album è davvero splendido, uno showcase lungo 104 minuti per un totale di 28 tracce (un paio di brani hanno l’onore di due differenti versioni, Pastures Of Plenty e Jackhammer Blues), nel quale una lunga serie di artisti al 95% di estrazione folk paga un sincero e sentito tributo Woody ed al magnifico risultato di quel temporaneo incarico da parte del governo: canzoni di lavoro e di fatica, ma anche di speranza per un futuro migliore, un’opera che, oltre che musicale, ha anche un profondo significato culturale e didattico (e sarebbe interessante conoscere le reazioni dei giovani di oggi al fatto che in quegli anni si scrivessero canzoni che parlavano di dighe e centrali elettriche). Brani che rispondono a titoli quali Oregon Line, Eleckatricity And All, Portland Town To Klamath Falls, Guys On The Grand Coulee Dam, Hard Travelin’ (altro pezzo molto noto), Columbia Waters, Mile And A Half From The End Of The Line, titoli che oggi sarebbero inimmaginabili per le canzoni contemporanee.
L’operazione, oltre ad essere benemerita dal punto di vista culturale, lo è anche da quello più strettamente musicale, in quanto si è scelto di coinvolgere artisti molto poco noti o praticamente sconosciuti, ma che hanno affrontato la prova con grandissimo rispetto e riproponendo le sonorità pure dell’epoca, solo con l’utilizzo delle chitarre acustiche e qualche volta di un banjo o un violino (e solo in un paio di brani la chitarra elettrica, ma senza mai l’uso della sezione ritmica): gli unici nomi un po’ più conosciuti sono quelli del grande David Grisman (e della moglie Tracy), della cantautrice folk Martha Scanlan, dell’ex chitarrista dei R.E.M., Peter Buck (e del suo compare nel Baseball Project, Scott McCaughey), di John Moen, componente dei Decemberists e del banjoista e chitarrista Tony Furtado. Gli altri partecipanti sono meno o per niente noti, ma non per questo meno bravi: Kristin Andreassen, Cahalen Morrison, i Timberbound, Jon Neufeld, Joe Seamons (anche produttore con Neufeld del lavoro, ed autore delle dettagliate liner notes nel bellissimo libretto di 44 pagine accluso al doppio CD), tanto per fare qualche nome. Un valido esempio per capire l’onestà di intenti del progetto è la presenza di Michael Hurley, che apre il lavoro con la prima delle due Pastures Of Plenty, un folksinger coetaneo di Bob Dylan e Joan Baez ed appartenente al folk revival del Greenwich Village nei primi anni sessanta, ma che già all’epoca stava nelle retrovie (ed infatti non so quanti di voi lo abbiano mai sentito nomimare, pur essendo titolare di una vasta discografia).
Non è il caso di fare una disamina canzone per canzone, ma non per pigrizia (anzi, avrete notato che se c’è da dilungarsi non mi tiro di certo indietro), bensì perché questo è un songbook che va goduto per intero, e non c’è un solo momento di stanca o un’interpretazione che sia meno che ottima, sia che si tratti di una ballata drammatica, che di un pezzo più vivace e disimpegnato, o ancora di un talkin’ blues. Woody aveva inciso per il documentario solo 17 delle 26 canzoni scritte, alcune le aveva registrate in seguito, altre le aveva lasciate solo con il testo (ad esempio, Lumber Is King è stata musicata nientemeno che da Pete Seeger, e solo nel 1987): qui invece non c’è frammentarietà, solo purezza, amore e cultura, oltre ad una spiccata capacità di intrattenere anche da parte dei musicisti meno blasonati tra quelli coinvolti (vale a dire quasi tutti).
Se Manzoni prima di scrivere I Promessi Sposi era andato a “sciacquarsi i panni in Arno”, questo Roll Columbia si può paragonare ad un bagno di purificazione nelle acque del fiume Columbia (e dove se no?): so che siamo solo a Febbraio e definirlo disco folk dell’anno può sembrare prematuro, ma sono certo che a Dicembre non avrà perso molte posizioni.
Marco Verdi