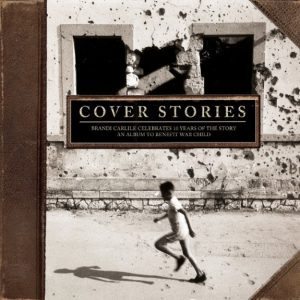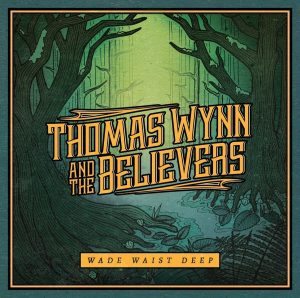Various Artists – Cover Stories – Sony Legacy
Ne abbiamo già parlato un paio di volte; prima in occasione della presentazione e poi all’uscita del 5 maggio, ma visto che si tratta di una operazione a sfondo benefico http://discoclub.myblog.it/2017/05/05/esce-il-5-maggio-ma-visto-che-il-fine-e-nobile-cover-stories-ovvero-rivisitando-the-story-di-brandi-carlile-per-una-giusta-causa/ torniamoci per un’ultima volta. Al link leggete tutta la storia, questa volta parliamo solo dei contenuti, ossia delle singole canzoni, di quello che giustamente viene ancora oggi considerato il migliore album di Brandi Carlile, cantautrice di cui spesso e volentieri avete letto su questo Blog http://discoclub.myblog.it/2015/03/18/folk-rock-il-nuovo-millennio-delle-migliori-brandi-carlile-the-firewatchers-daughter/ :
1. Late Morning Lullaby – Shovels & Rope
Il duo americano agli inizi mi piaceva molto, poi mi pare che si siano persi per strada, con una svolta commerciale verso il “modernismo” a tutti i costi, che mi sembra li accomuni a gente come Mumford And Sons, Arcade Fire, Low Anthem, Needtobreathe (con cui hanno collaborato, nel pessimo Hard Love) e vari altri. Per l’occasione i due fanno le cose per benino, forse ispirati da questa dolce ninna nanna che apriva anche l’album originale, con l’intreccio delizioso delle due voci, Michael Trent e Cary Ann Hearst una chitarra acustica e poco più, bella partenza.
2. The Story – Dolly Parton
La title track dell’album è anche una delle più belle canzoni del disco, Dolly Parton, una delle “eroine” musicali della Carlile, rimane molto fedele allo spirito del brano, un folk-rock accorato, cantato con grande pathos e passione.
3. Turpentine – Kris Kristofferson
Splendida anche la rivisitazione del grande Kris, la voce è sempre più “vissuta” e scarna, ma la classe non manca, e pure questa, un’altra delle canzoni migliori di The Story, rifulge di nuova gloria in una versione splendida, caratterizzata da una pedal steel avvolgente, dalla chitarra di Chris Stapleton e dalle armonie vocali della figlia di Kristofferson, Kelly.
4. My Song – Old Crow Medicine Show
Per gli Old Crow Medicine Show mi pare che valga la regola aurea dei tempi di “E Intanto Dustin Hoffman Non Sbaglia Un Film”, loro non sbagliano non dico un album ma neppure una canzone: My Song diventa una splendida bluegrass song dei Monti Appalachi, con armonie vocali impeccabili, picking di chitarre, banjo e mandolino e svolazzi di violino, bellissima. Tra l’altro, se cercate in rete, visto che sono stati in tour assieme, si scambiano di continuo versioni dei loro brani.
5. Wasted – Jim James
Ultimamente il leader dei My Morning Jacket, da solo o con il suo gruppo, non sempre centra l’obiettivo, e anche questa versione psichedelica alla Tomorrow Never Knows di Wasted, non mi pare il massimo.
6. Have You Ever – The Avett Brothers
Questa canzone era già bella di suo, ma la versione dei fratelli Avett, rallentata rispetto all’originale, intima e delicata, quasi alla Simon & Garfunkel, è un altro dei pezzi migliori contenuti in questo tributo. Dando il via ad un trittico di cover nella parte centrale dell’album che sfiora la perfezione.
7. Josephine – Anderson East
Per esempio, nel caso di Anderson East, che sia una delle più belle voci in circolazione delle ultime generazioni non lo scopriamo certo oggi: la sua sua voce rauca e vissuta, a dispetto dei suoi 29 anni ancora da compiere (ma Otis Redding ne aveva 26, quando morì nel 1967), è perfetta per questa versione gospel-soul di Josephine, arricchita anche dalle armonie vocali della fidanzata Miranda Lambert.
8. Losing Heart – The Secret Sisters
A proposito di armonie vocali, due che non scherzano nel campo sono le Secret Sisters, di cui ai primi di giugno, il 9 per la precisione, è in uscita il terzo album You Don’t Own Me Anymore, prodotto, toh che caso, da Brandi Carlile. Se ne parla molto bene, recensione già prenotata da Marco, quando verrà pubblicato. Per il momento gustiamoci questa Losing Heart, pure questa rallentata rispetto all’originale, ma sempre una piccola perla, con la stessa Brandi al banjo e Tim Hanseroth al piano e mellotron, una ballata molto anni ’70, affascinante.
9. Cannonball – Indigo Girls
Le Indigo Girls erano presenti anche nell’album originale, quindi sembrava quasi doverosa la loro presenza per un altro dei pezzi “forti” del CD, con il classico sound del duo americano, a cui molto si è ispirata la Carlile ad inizio di carriera, anche se l’uso dei fiati e del violino è inconsueto, quasi pop barocco, comunque interessante, e gli intrecci vocali sono sempre magnifici.
10. Until I Die – TORRES
Torres condivide con Brandi le passioni per Kate Bush, Johnny Cash e Kurt Cobain, una sorta di spirito affine sul lato alternative-indie, e questa versione lo-fi sembra ispirata proprio dalla cantante inglese, e poi la voce è decisamente bella.
11. Downpour – Margo Price
Questa era una delle canzoni che più mi piacevano dell’album originale, e la versione dell’emergente Margo Price, cantata con voce dolce e vulnerabile, quasi “infantile”, ben si accoppia con il sound alternative-country della Carlile, con intrecci di chitarre e pedal steel che disegnano la deliziosa melodia della canzone.
12. Shadow On The Wall – Ruby Amanfu
Ecco uno dei due brani che erano già stati pubblicati in precedenza e non incisi appositamente per questo progetto. Ruby Amanfu è una cantante nata in Ghana, ma che vive ed opera musicalmente negli Stati Uniti, tra Nashville e Los Angeles. In possesso di una voce potente ed espressiva è in circolazione già dal 1998, ma Standing Still, il disco del 2015, è stato il primo con una produzione “importante”, e una delle cose migliori dell’album era proprio la sua versione della canzone di Brandi.
13. Again Today – Pearl Jam
Non potevano mancare naturalmente i suoi amici Pearl Jam (Mike McCready è apparso nei suoi dischi e Eddie Vedder è sempre disponibile per degli eventi di carattere benefico come questo): la versione di Again Today, che in origine era una malinconica ballata, per l’occasione diventa una potente canzone rock nello stile tipico della band di Seattle (quindi anche quasi concittadini) con la stessa Brandi Carlile alle armonie vocali per uno dei brani più importanti della raccolta
.14. Hiding My Heart – Adele
Questo pezzo era la “traccia nascosta” nella versione originale di The Story e poi era presente come bonus track nella versione limitata dell’album 21 di Adele, il disco che ha venduto svariati “fantastilioni” di copie in giro per il mondo.
Quindi, ribadisco, non solo un album per una giusta causa, ma anche, a parte un paio di eccezioni, un gran bel disco!
Bruno Conti