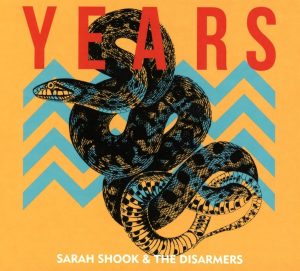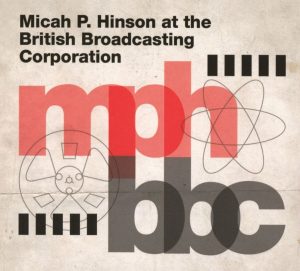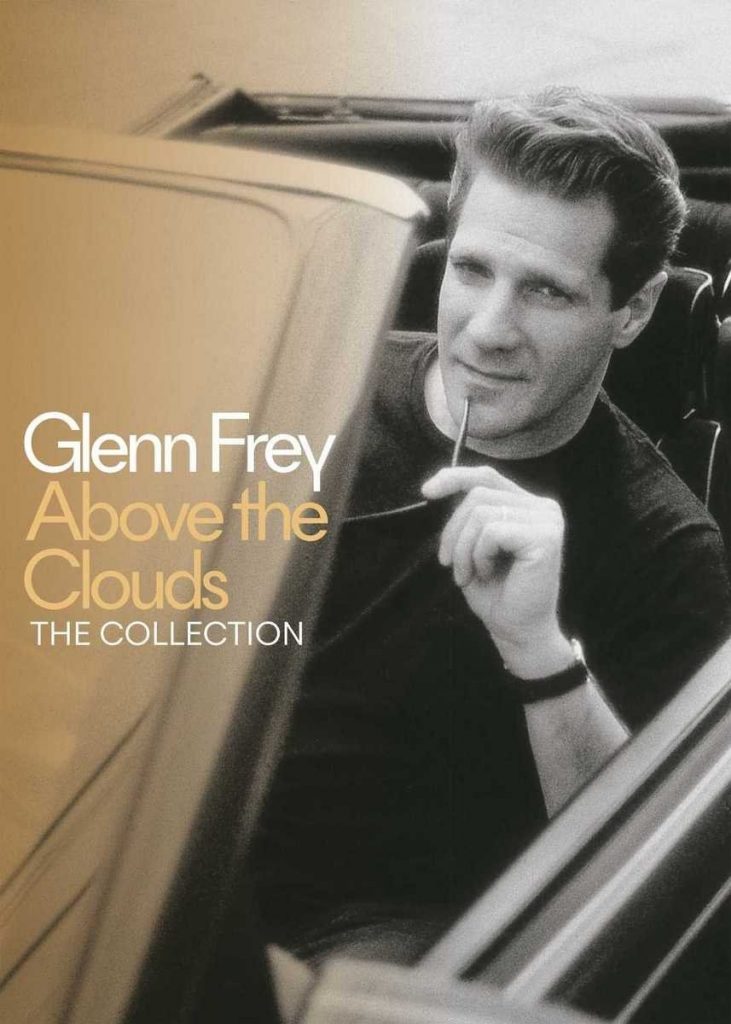Procol Harum – Still There’ll Be More: An Anthology 1967-2017 – Esoteric/Cherry Red 2CD – Box Set 5CD/3DVD
Così come in una partita di calcio su 90 minuti è già un record se di tempo reale ne vengono giocati la metà, allo stesso modo i cinquant’anni di carriera dei Procol Harum, storica band inglese formatasi nella seconda metà degli anni sessanta si ridurrebbero più o meno ad una ventina (forse anche meno) se dovessimo togliere tutto il tempo in cui sono stati inattivi o addirittura inesistenti come gruppo. Ma siccome una bella celebrazione non si nega a nessuno, tantomeno ad una formazione che ha comunque la sua importanza, ecco che dopo il loro ottimo reunion album dello scorso anno, Novum, esce questo bellissimo cofanetto di cinque CD più tre DVD, intitolato Still There’ll Be More, sicuramente l’antologia definitiva per la band guidata da Gary Brooker, che rende superfluo il precedente box del 2009 dal titolo molto simile, All This And More (esiste anche una versione doppia per chi non volesse accaparrarsi il cofanetto).
I Procol Harum sono legati da sempre al loro brano più famoso, A Whiter Shade Of Pale, una ballata strepitosa costruita attorno all’Aria Sulla Quarta Corda di Bach, uno di quei pezzi che tutti hanno sentito almeno una volta nella vita (e da noi reso ancora più popolare dalla versione in italiano Senza Luce dei Dik Dik): sarebbe però sbagliato pensare ai PH come ad un gruppo che ha vissuto di rendita su una sola canzone, dal momento che negli anni ci hanno regalato tanta altra musica di alto livello, una miscela sempre elegante e raffinata di rock, pop e qualche tentazione prog, con uno spiccato senso della melodia, frutto senz’altro della formazione classica di Brooker, cantante, pianista, autore delle musiche ed unico componente sempre presente in tutte le formazioni (insieme, tranne che nell’ultimo Novum, a Keith Reid, membro “occulto” ma importante, per quanto limitato alla scrittura dei testi come paroliere, nello stesso ruolo di Bernie Taupin con Elton John). Negli anni all’interno della band si sono alternati numerosissimi musicisti, ma è d’uopo ricordarne almeno un paio storici: Robin Trower, gran chitarrista, capace di vere e proprie scorribande elettriche specie dal vivo, e soprattutto Matthew Fisher, il cui organo è sempre stato un elemento imprescindibile nell’economia sonora del gruppo, almeno nel periodo in cui ne ha fatto parte.
Tornando a bomba, Still There’ll Be More nei primi tre CD offre una panoramica più che esaustiva attraverso tutta la discografia dei nostri, senza inediti ma con un paio di rarità: la cameristica Understandably Blue, presa da una ristampa del 2009 del disco d’esordio, e la b-side Long Gone Geek, un brano potente che avrebbe meritato maggior fortuna. Non mancano naturalmente i successi del gruppo, tutti concentrati nel primo periodo: oltre alla già citata A Whiter Shade Of Pale, la malinconica e bellissima Homburg, A Salty Dog, Shine On Brightly e la magnifica Conquistador, presente però in versione live. Ne cito alcune altre tra le mie preferite, a partire dal rock-blues Cerdes, in cui Trower inizia a dare un saggio della sua bravura, e passando per la sinuosa e splendida Repent Walpurgis (* NDB Che in Italia, patria del latino, per motivi misteriosi divenne Fortuna), uno straordinario strumentale con prestazioni maiuscole di organo e chitarra, la complessa Skip Softly (My Moonbeams), con un finale al limite della psichedelia, la fluida e diretta The Milk Of Human Kindness e la roboante Whisky Train, ancora con Trower straripante. Nel periodo “di mezzo”, che arriva fino al 1977 (anno del primo scioglimento della band) spiccano la limpida Broken Barricades, tra pop e prog, la bella Luskus Delph, melodicamente perfetta, il folk-rock di A Souvenir Of London, l’accattivante Beyond The Pale, la solida rock ballad Fool’s Gold o la maestosa In Held ‘Twas In I, mini-suite quasi operistica e presa dal live del 1972 con la Edmonton Symphony Orchestra.
Sono anche rappresentate le due reunion del 1991 e del 2003, entrambe con Trower e Fisher (che avevano lasciato il gruppo all’inizio dei seventies), con brani come l’ottima Perpetual Motion e la strepitosa An Old English Dream, una delle loro migliori canzoni degli ultimi trent’anni; non mancano neppure due pezzi da Novum: Can’t Say That, tra boogie e blues, e la raffinata ballata pianistica The Only One. Il quarto e quinto CD contengono due concerti inediti, purtroppo solo parziali (meno di un’ora l’uno, in questo si poteva fare di più) ma decisamente interessanti. Il primo dei due è uno show del 1973 al mitico Hollywood Bowl, con i PH accompagnati dalla Los Angeles Symphony Orchestra (più coro), un setting molto adatto alla musica dei nostri, anche se qua e là si notano atmosfere un po’ barocche. Da segnalare una sontuosa Broken Barricades, due A Salty Dog e Conquistador da antologia (specie quest’ultima, che si presta particolarmente ad un accompagnamento orchestrale) e qualche pezzo meno noto, come la roccata e trascinante Simple Sister ed una superba Grand Hotel, che mostra l’abilità di Brooker e compagni nel rendere fruibili anche partiture più complesse. Il quinto dischetto, stavolta senza orchestra, prende in esame una serata a Bournemouth nel 1976, che inizia con il quasi rock’n’roll di The Unquiet Zone e mette in fila altre otto canzoni, con punte come due vibranti riletture di I Keep Forgetting di Chuck Jackson e I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch), classico dei Four Tops, inframezzate dalla grandiosa The Blue Danube, arrangiamento rock del capolavoro di Strauss; come finale, la sempre grande A Whiter Shade Of Pale.
I tre DVD, che non ho ancora visto, contengono varie apparizioni televisive e spezzoni di concerti, curiosamente con una prevalenza di immagini della emittente tedesca Radio Bremen, altre 39 canzoni che però coprono solo il periodo “storico”, quindi fino al 1977, ignorando purtroppo gli anni più recenti. Ma non posso certo lamentarmi: Still There’ll Be More è un ottimo cofanetto, direi anzi definitivo, che celebra nel giusto modo uno dei gruppi più sottovalutati della storia, che ancora oggi molti pensano essere soltanto una “one hit wonder” band.
Marco Verdi