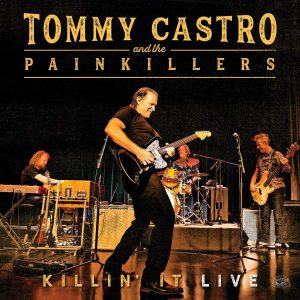Hayes Carll – What It Is – Dualtone CD
Nuovo album per il cantautore texano Hayes Carll, uno che incide con il contagocce (sei album in diciotto anni di carriera), ma potete stare certi che quando pubblica qualcosa riesce sempre a distinguersi dalla banalità. La peculiarità di Carll è che il livello dei suoi lavori è in continuo crescendo, ed ogni suo disco ha sempre qualcosa in più del precedente: Lovers And Leavers (2016) https://discoclub.myblog.it/2016/04/05/piu-countryman-songwriter-completo-hayes-carll-lovers-and-leavers/ era meglio di KMAG YOYO (2011), che a sua volta era meglio di Trouble In Mind (2008). E What It Is, il suo CD nuovo di zecca, già al primo ascolto si rivela il migliore di tutti, un album composto da una serie di canzoni splendide sempre nello stile tipico del nostro: musica country d’autore, di alto livello e decisamente coinvolgente, ma sono ben presenti anche elementi folk, rock’n’roll e perfino soul. Una cosa che contraddistingue le canzoni di Carll sono anche i testi, intelligenti e sempre sul filo di un’ironia alla John Prine, quando non sfociano nel puro sarcasmo alla Randy Newman. Infine, una spinta alla riuscita di What It Is deve averla data anche la situazione sentimentale di Hayes, che si è fidanzato con la bella e brava Allison Moorer (una delle tante ex mogli di Steve Earle), ed il mio non è solo gossip fine a sé stesso, in quanto la musicista dai capelli rossi è coinvolta anche artisticamente in questo disco, in quanto ne è la produttrice (insieme a Brad Jones), ha scritto diversi brani insieme al suo boyfriend, ed è pure presente in qualità di corista (con Bobby Bare Jr., figlio di cotanto padre).
Un gran bel disco quindi, oltre che per le canzoni anche per i musicisti coinvolti, tra i quali si segnalano il noto Fats Kaplin al violino, mandolino, banjo e steel (fondamentale il suo contributo), Will Kimbrough alle chitarre ed il bravissimo pianista e organista Gabe Dixon. Dodici canzoni, una meglio dell’altra: si parte con None’Ya, eccellente ballata countreggiante, cadenzata e diretta, con un motivo di quelli che restano in testa immediatamente ed un bellissimo violino. Irresistibile poi Times Like These, un rock’n’roll dal ritmo travolgente, elettrico quanto basta ed ancora con il violino a fungere come elemento di disturbo: impossibile tenere il piede fermo, siamo dalle parti del miglior Billy Joe Shaver (anche come timbro vocale); davvero bella anche Things You Don’t Wanna Know, un pezzo stavolta dal chiaro sapore soul (una novità per Hayes), con il nostro che dimostra di essere più che credibile usando fiati ed organo in maniera magistrale, il tutto servito da una melodia decisamente orecchiabile. Che dire di If I May Be So Bold? Una scintillante country song elettrica ancora con Shaver in testa (ma anche Johnny Cash), ritmo alto e gran godimento, mentre Jesus And Elvis è uno slow ancora dal chiaro approccio country, limpido e scorrevole, che ha il passo delle migliori composizioni di John Prine (anche nel testo, tra il poetico e lo scherzoso): splendida anche questa.
Che Carll sia in stato di grazia lo si capisce anche da brani come American Dream, apparentemente un tipo di country song già sentita prima, ma con una marcia in più data dalla brillantezza della scrittura e dall’accompagnamento delizioso da parte della band (ottimo l’intreccio tra chitarre, violino e mandolino); Be There è una ballata fluida, intensa e melodicamente impeccabile (il refrain è perfetto), con una sezione d’archi che la rende emozionante. Beautiful Thing, ancora a metà tra country e rock’n’roll, è nobilitata da un ritmo coinvolgente e dal formidabile pianoforte di Dixon; un banjo apre la squisita What It Is, che porta il disco in territori bluegrass, ed è inutile dire che sia Hayes che la band danno il loro meglio anche qui. Il CD volge (purtroppo) al termine, il tempo di ascoltare ancora Fragile Men, lenta, epica e con un arrangiamento da film western, la potente Wild Pointy Finger, tra country e southern, e con l’intima e folkie I Will Stay, solo voce, chitarra ed archi.
Dopo un inizio in sordina finalmente anche il 2019 sta cominciando a produrre dischi degni di nota, e questo nuovo tassello della carriera di Hayes Carll è al momento nella mia Top Five.
Marco Verdi