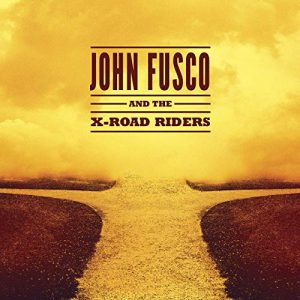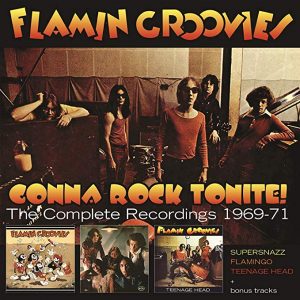Terry Allen – Pedal Steal/Four Corners – Paradise Of Bachelors 3CD/LP
Se siete abituali frequentatori di questo blog non devo dirvi io chi è Terry Allen: texano, cantautore e musicista geniale e spesso dissacrante, ma anche artista a 360 gradi, pittore, scultore e chi più ne ha più ne metta. Una figura non da poco quindi, talmente originale e bonariamente “fuori di testa” da attirare l’attenzione di David Byrne, un altro non proprio normale, che nel 1986 lo volle come collaboratore nel suo celebre progetto True Stories. Musicalmente Allen negli ultimi anni ha parecchio diradato i suoi contributi: Bottom Of The World, il suo album più recente, è del 2013, e seguiva il precedente Salivation dopo ben 14 anni; ma Terry non è mai stato molto prolifico come musicista in proprio, anche se in passato ci ha regalato almeno un capolavoro assoluto come Lubbock (On Everything) https://discoclub.myblog.it/2016/10/27/due-notevoli-ristampenel-segno-del-texas-steve-earle-guitar-townterry-allen-lubbock-on-everything/ ed altri grandi dischi come Juarez, Human Remains e lo stesso Salivation.
Nel 1985 Allen ricevette dalla Margaret Jenkins Dance Company di San Francisco l’incarico di comporre una colonna sonora per un balletto (!), e la risposta fu Pedal Steal, una suite della durata di poco più di mezz’ora idealmente basata sulla figura di Wayne Gailey, suonatore di steel guitar semisconosciuto ma molto considerato da Allen. Pedal Steal venne messo in commercio all’epoca insieme a Rollback, un album di canzoni più canoniche, e riedito in CD solo nel 2006 (senza Rollback). Oggi la Paradise Of Bachelors ristampa una versione rimasterizzata (devo dire in maniera eccelsa) di Pedal Steal, e lo fa in grande stile, in una confezione identica a quella di un doppio LP “gatefold” con il CD dell’opera, il vinile contenente lo stesso album, e soprattutto altri due CD che contengono altri quattro lavori di Allen, quattro drammi radiofonici andati in onda tra il 1986 ed il 1993 ma mai pubblicati prima né in vinile né in CD, ed anch’essi della durata di 30 minuti circa ciascuno, con l’aggiunta finale di un bel booklet formato maxi con tutti i testi e foto rare di dipinti e sculture che rivelano l’arte visionaria di Allen.
I titoli delle quattro “radio plays” sono Torso Hell (1986, all’epoca circolato brevemente in musicassetta, ma sfido chiunque a dimostrare di possederne una copia), Bleeder (1990), Reunion (Return To Juarez) (1992) e Dugout (1993), qui rinominate per brevità Four Corners, come si fossero quattro elementi della stessa suite (ma gli argomenti trattati sono diversissimi tra loro). Aspettate però a fregarvi le mani compiaciuti, in quanto qui il Terry Allen cantautore è molto poco presente, in quanto sia Pedal Steal che le quattro parti di Four Corners sono in realtà dei lunghi racconti (anche abbastanza “strani”) con la maggioranza di parti narrate, in gran parte da Terry stesso e dalla moglie Jo Harvey Allen, e di musica ce n’è davvero poca. Delle cinque opere, Pedal Steal è forse quella con più equilibrio tra narrazione e musica, ma siamo sempre su un rapporto di 75/25, anche se il gruppo che accompagna Allen (chiamato per l’occasione The Panhandle Mystery Band) presenta nomi di tutto rispetto come Lloyd Maines (che tra le varie chitarre suona anche la pedal steel, lo strumento ovviamente principale), Richard Bowden al violino e mandolino, Bobby Keys e Don Caldwell ai sassofoni e Butch Hancock come special guest.
Come ho già detto Pedal Steal è composto da un’unica traccia, una narrazione con tanto di pause, rumori ambientali e diavolerie varie, qualche parte strumentale di collegamento ma anche frammenti di canzoni, ed i pochi brani completi sono comunque interrotti dalla parte narrata, per poi riprendere. Le parti musicali sono sublimi (ma, ripeto, troppo brevi, spesso finiscono quando ci si comincia a prendere gusto), come l’introduzione in cui spicca la steel di Maines, o Billy The Boy, uno strepitoso brano dal sapore messicano, o ancora la scintillante Fort Sumner, bellissima country song per chitarre acustiche, elettriche e marimba, o ancora Lonely Road, un pezzo dal sapore western diretto e vibrante. C’è anche un lungo assolo quasi distorto di steel, alla Jimi Hendrix, e due brani non di Allen, cioè un breve accenno all’evergreen Sentimental Journey per solo sax ed il traditional Give Me The Flowers, splendidamente eseguito da Hancock, voce e chitarra.
Un’opera dunque affascinante, ma capisco che l’ascolto possa non essere facile, soprattutto se siete abituati al Terry Allen “semplice” songwriter. Torso Hell è ancora più straniante: nato da un’idea per un film horror mai realizzato (si parla della vita post-guerra di un reduce dal Vietnam senza braccia e gambe, ma miracolosamente vivo, ed il tutto è raccontato in maniera anche piuttosto cruda), è narrato al 90% e le poche parti strumentali sono prodotte da synth e tastiere, più degli effetti che musica vera e propria. Nelle altre tre mini-suite ci sono strumenti più “convenzionali” (tutti suonati da Allen, Maines e Bowden), ma anche qui le parti parlate la fanno da padrone e di musica vera ce n’è poca, per non parlare di canzoni: solo brevi accenni al traditional Auld Lang Syne, al classico gospel Rock Of Ages ed alla cover del brano di Carl Perkins Dixie Fried in Bleeder, qualche intermezzo strumentale tra Messico e musica “desertica” (alla Ry Cooder) in Reunion, e praticamente nulla in Dugout.
In conclusione, una ristampa che non manca di interesse, ma che può risultare decisamente complessa e poco digeribile per l’ascoltatore “casuale”, e che mi sento di consigliare tuttalpiù ai die-hard fans di Terry Allen.
Marco Verdi