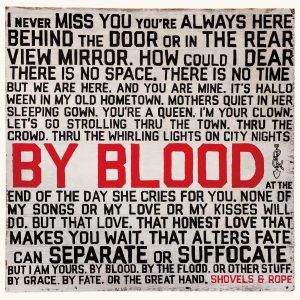Jimmie Vaughan – Baby, Please Come Home – Last Music Company CD
Essere fratello, per giunta maggiore, di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi non è facile, specie se fai il suo stesso mestiere: se poi tale fratello è scomparso ancora giovane in tragiche circostanze ed è diventato una leggenda, il rischio è quello di essere per sempre classificato come “il fratello di…”. Sto parlando di Jimmie Vaughan, grande bluesman e chitarrista texano, titolare di una lunga e rispettabilissima carriera prima con i Fabulous Thunderbirds e poi da solista, che per molti è ancora oggi solo il fratello dell’immenso Stevie Ray Vaughan, uno dei maestri assoluti di sempre dello strumento (personalmente lo metto nella mia Top 3 degli axemen dopo Jimi Hendrix – non sono mai stato un fan sfegatato dell’Hendrix musicista ma l’Hendrix chitarrista è inarrivabile ancora oggi – e Jimmy Page). Jimmie però se ne è sempre fregato dei paragoni ed è giustamente andato avanti per la sua strada, e d’altronde i due non avrebbero potuto essere più diversi: se Stevie Ray era un uragano che dal vivo rischiava di mandare metaforicamente a fuoco il palco ad ogni performance, l’approccio al blues di Jimmy è sempre stato più composto, classico ed elegante, pur non rinunciando anch’egli ad accendere la miccia negli spettacoli live, specie con i Thunderbirds.
Musicalmente il nostro era fermo addirittura dal 2011, anno della pubblicazione del secondo capitolo di Plays Blues, Ballads And Favorites (ma in mezzo c’è stato anche https://discoclub.myblog.it/2017/11/05/pochi-ma-buoni-ora-anche-dal-vivo-jimmie-vaughan-trio-featuring-mike-flanigin-live-at-c-boys/ ), e quindi è con grande piacere che ho accolto questo Baby, Please Come Home, nuovissimo capitolo di una discografia di tutto rispetto, album nel quale il chitarrista texano prosegue con la sua personale reinterpretazione di classici del blues e non, il tutto con la consueta classe e bravura. Infatti Baby, Please Come Home ci mostra un Jimmy in ottima forma, e che ci regala in 35 intensi minuti undici brani di blues ad alto livello, coadiuvato da una band che comprende musicisti che troviamo abitualmente nei suoi lavori ed anche qualche new entry: la sezione ritmica vede operare il batterista George Rains ed alternarsi due diversi bassisti (Ronnie James e Billy Horton), poi abbiamo l’eccellente Mike Flanigin all’organo e l’altrettanto bravo Jarrod Bonta al piano, Billy Pitman alla chitarra ritmica ed una corposa sezione fiati che dona calore e colore al disco, e che vede all’opera i sassofonisti Doug James, Greg Piccolo (quest’ultimo già con i Roomful Of Blues), John Mills e Kaz Kazanoff, i trombettisti Al Gomez e Jimmy Shortell e Randy Zimmerman al trombone.
Proprio i fiati sono grandi protagonisti di questo album e danno ancora più spessore a brani già ottimi di loro, a volte perfino “relegando” in secondo piano la chitarra del leader, che va detto non va mai sopra le righe ed offre sempre assoli brevi e misurati, restando quindi al servizio delle canzoni ed evitando qualsiasi atteggiamento da axeman fine a sé stesso. Si parte con una saltellante e ritmata versione della title track (brano di Lloyd Price), resa ancora più coinvolgente proprio dai fiati, mentre Jimmy rilascia un paio di assoli ficcanti ma assolutamente composti https://www.youtube.com/watch?v=h35qWP9GL70 . Just A Game (Jimmy Donley) è sempre cadenzata ma più lenta e vede ancora i fiati protagonisti con l’organo a rendere più caldo il suono: Vaughan non è forse il miglior blues vocalist sulla piazza, ma se la cava in ogni caso più che bene; No One To Talk To (But The Blues) nonostante sia di Lefty Frizzell viene “de-countryzzata” da Jimmy che la rivolta come un calzino e la trasforma in un bluesaccio sanguigno e davvero godibile, grazie anche alla solida performance della band, mentre Be My Lovey Dovey (scritta da Richard Berry ma resa nota da Etta James) è giusto a metà tra jump blues e rock’n’roll, con il classico botta e risposta voce/coro e ritmo sostenuto.
Decisamente trascinante What’s Your Name?, classico blues di Chuck Willis dal tempo veloce e che fa muovere il piedino, il tutto sempre affrontato in grande stile e con pregevoli assoli di sax e della sei corde di Jimmy; Hold It è una deliziosa rilettura di uno strumentale di Bill Doggett, in cui domina l’organo di Flanigin con una prestazione maiuscola, e con il nostro che rilascia un assolo in punta di dita, ed è seguita da I’m Still In Love With You (T-Bone Walker), puro slow blues dalle atmosfere afterhours ed un pianoforte dal sapore jazzato, altra prova di classe sopraffina. La mossa It’s Love Baby (24 Hours A Day), un classico inciso da mille artisti da Louis Brooks a Hank Ballard, passando per Ruth Brown e Jackie DeShannon, è blues nella sua accezione più classica, e per Jimmie è come bere un bicchiere d’acqua, So Glad è un omaggio del nostro a Fats Domino, un divertente pezzo in perfetto equilibrio tra blues ed un pizzico di rock’n’roll, con Vaughan che ci offre la miglior performance chitarristica del disco, mentre la strepitosa Midnight Hour (Clarence “Gatemouth” Brown), con grande lavoro del piano di Bonta, prelude alla conclusiva Baby, What’s Wrong di Jimmy Reed (registrata dal vivo), questa sì rock’n’roll al 100%, degno finale di un disco senza sbavature e suonato davvero a regola d’arte.
Marco Verdi