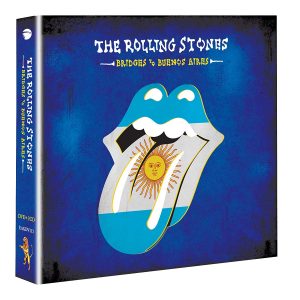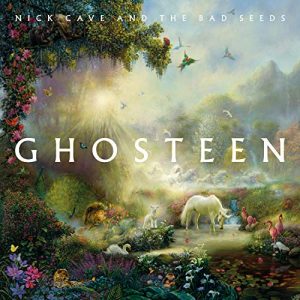Leonard Cohen – Thanks For The Dance – Columbia/Legacy– LP – CD
Sono passati poco più di tre anni dalla scomparsa di Leonard Cohen, e anche da un mio “post” sul Blog, dove ripercorrevo la sua straordinaria discografia (disco per disco). Questo Thanks For The Dance (in uscita in questi giorni), è il primo disco di inediti (postumo) del cantautore canadese, e questo lo si deve solo grazie al figlio Adam Cohen, che sette mesi dopo la morte del padre (su sua esplicita richiesta), ha recuperato degli appunti sparsi, bozzetti, e tracce musicali, finalizzando tutto il lavoro che era rimasto incompiuto del precedente e ultimo You Want It Darker.
Per fare le cose al meglio il buon Adam si è attaccato al telefono, e ha giustamente invitato alcuni amici e colleghi a contribuire anche con il loro talento alla buona riuscita del disco, a partire dal grande musicista spagnolo Javier Mas (elemento di spicco negli ultimi anni di tournée con Leonard), ammiratori e collaboratori di lunga data come Jennifer Warnes, Sharon Robinson (entrambe coriste storiche di Cohen), Leslie Feist, Damien Rice, Beck,, il compositore Dustin O’Halloran al piano, Richard Reed Parry degli Arcade Fire) al basso, Bryce Dessner il chitarrista dei National, il tutto con il supporto del coro berlinese Cantus Domus e della Congregation Shaar Hashomayim (già impiegata nel disco precedente), oltre ad altri amici di lunga data Patrick Watson alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei fiati e di Daniel Lanois chitarra e piano. Ma nel disco sono stati impiegati complessivamente più di quaranta musicisti. Data la particolarità del lavoro, mi è sembrato giusto sviluppare i brani “track by track”:
Happens To The Heart – Il brano iniziale, dopo qualche secondo come in un “fil-rouge”, riparte da dove era terminato l’ultimo meraviglioso You Want It Darker, con le note iniziali della chitarra flamenco di Mas, il piano vellutato di Lanois, e il solito canto meditativo di Cohen, che mette i brividi alla schiena di ogni ascoltatore.
Moving On – Questa canzone è l’ennesimo omaggio all’amata Marianne Ihlen, una tenue ballata declamata da Leonard e sussurrata come una preghiera, sostenuta solamente dalle note della chitarra di Javier, e dal suono lieve di uno scacciapensieri.
The Night Of Santiago – Meritevole recupero di un poema di Garcia Lorca, che era gia apparsa in Book Of Longing di Philip Glass, e che nella versione suddetta era cantata in forma corale e operistica, in questa nuova rilettura di Adam viene rivoltata come un calzino ed eseguita in una versione “spagnoleggiante”, che si dipana tra accordi di pianoforte che flirtano con il virtuosismo dell’artista spagnolo, accompagnando la voce baritonale del “maestro”.
Thanks For The Dance – Anche questo brano era stato già interpretato da Anjani Thomas in Blue Alert (06), uno dei suoi memorabili valzer che richiama immancabilmente il famoso Take This Waltz, un bellissimo commiato in musica impreziosito ai cori dalle voci sensuali di Jennifer Warnes e Leslie Feist.
It’s Torn – Un giro di basso accompagnato dal pianoforte di Lanois introduce It’s Torn, uno dei brani più oscuri del lavoro, una ballata “dark” che si avvale nella parte finale, della voce sinuosa e vellutata di una delle sue tante brave coriste, Sharon Robinson.
The Goal – Sempre dal libro di poesie e poemi Book Of Longing, viene recuperata questa brevissima lirica in musica, recitata in forma di monologo dal grande Leonard.
Puppets – Questo è certamente il brano più politico del disco (viene ricordato lo sterminio degli Ebrei vittime del genocidio nazista, conosciuto storicamente come Shoah), dove la voce quasi minacciosa dell’autore, viene accompagnata dalla chitarra di Michael Chaves, e dal coro solenne dei berlinesi Cactus Domus, e monastico dei Shaar Hashomayim Choir.
The Hills – Indubbiamente questo è il pezzo più in formato canzone dell’album, una piccola gemma che si sviluppa in modo crescente, con un arrangiamento ricco e vario dove spiccano le voci angeliche delle sconosciute (ma brave) Erika Angell, Molly Sveeney, Lilah Larson
Listen To The Hummingbird – Il testo di questo brano altro non sono che i versi recitati da Cohen nell’ultima conferenza stampa ai tempi di You Want It Darker, con il piano delicato di Larry Goldings che detta la scarna melodia, valorizzata dalle voci di Damien Rice e del figlio Adam.
Giunto alla fine dell’ascolto del CD di Leonard e Adam Cohen,(sono solo poco più di 28 minuti, ma molto intensi) ho la netta sensazione che il figlio d’arte abbia fatto un lavoro splendido e altamente meritevole, tenendo fede alla promessa fatta al padre prima di morire, confermando anche che sarà l’unico album postumo che uscirà a suo nome, perché deve essere chiaro che la discografia ufficiale di Cohen finisce con questo ultimo viaggio, senza le eventuali contaminazioni discografiche varie. La carriera di Leonard Norman Cohen è stata un lungo percorso di epitaffi, poemi e poesie , cantati e arrangiati con scrupolo, con una voce (la cosa più bella di questo Thanks For The Dance) incredibilmente bassa, baritonale, che sembra parlare al cuore e all’anima di ognuno di noi. Purtroppo, non ci sarà una prossima volta (vedremo se sarò vero), ma grazie per l’ultimo ballo Mr. Cohen.
*NDT: Se non conoscete Adam Cohen (nonostante il fardello di essere figlio di cotanto padre), ha una dignitosa carriera alle spalle, composta da quattro uscite discografiche, di cui almeno due Like A Man (11) e We Go Home (14), altamente consigliate. Cercate gente, cercate.!
Tino Montanari