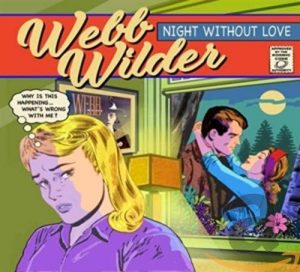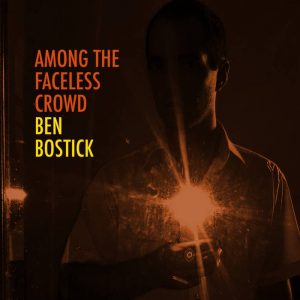Neil Young – Homegrown – Reprise/Warner CD
A volte il destino è strano: finalmente ti decidi a far uscire ufficialmente un disco che hai nei cassetti da 45 anni e che è forse il principale desiderio nascosto (ma neanche troppo) dei tuoi fans, e con tutte le date a disposizione vai a scegliere quella in cui Bob Dylan pubblica il suo primo album di canzoni nuove in otto anni, ed uno dei suoi migliori delle ultime due decadi. Ma, facezie a parte, un po’ ancora non ci credo che sono qui a parlarvi di Homegrown, album registrato da Neil Young tra il 1974 ed il 1975 che in origine doveva rappresentare una sorta di seguito di Harvest, ma che poi è stato lasciato da parte diventando uno dei maggiori oggetti del desiderio da parte degli estimatori del musicista canadese (nonché il più celebre dei suoi LP “unreleased”, un elenco che comprende titoli come Chrome Dreams, Island In The Sea, Oceanside/Countryside, la prima versione di Old Ways e Toast, mentre Hitchhiker come sapete è stato pubblicato nel 2017).
La storia è abbastanza nota: Homegrown, un disco elettroacustico tra rock, country e folk realizzato tenendo presenti le sonorità di Harvest, era bello che pronto per uscire (c’era anche la copertina, che poi è la stessa dell’edizione odierna), ma un Neil Young ancora scosso per la perdita degli amici Danny Whitten e Bruce Berry ebbe il colpo di grazia a causa del naufragare della sua relazione con l’attrice Carry Snodgress, con cui aveva una relazione dal 1971 dalla quale era nato il piccolo Zeke (affetto tra l’altro da paralisi cerebrale): la cosa fece cadere il nostro in una profonda depressione che lo convinse a cancellare l’uscita di Homegrown a favore del cupo Tonight’s The Night. Negli anni seguenti Neil ha poi pubblicato alcuni pezzi pensati per quel disco, alcuni potenziati, altri completamente rifatti, altri ancora lasciati così com’erano, ma di Homegrown più nessuna traccia nonostante la notizia di una pubblicazione imminente, poi puntualmente smentita, verrà data più volte nelle decadi a venire. Ora però è la volta buona (anche se un altro ritardo di due mesi c’è stato, ma stavolta per il coronavirus), e Homegrown è finalmente una realtà, ed esattamente con la tracklist pensata all’epoca: sono stati quindi lasciati nei cassetti diversi altri titoli, alcuni noti in quanto già presenti nella discografia younghiana (Pardon My Heart, Deep Forbidden Lake, The Old Homestead), altri più oscuri nonostante Neil negli anni li abbia occasionalmente suonati dal vivo (Love/Art Blues, Homefires, Mediterranean, Frozen Man, Daughters, Barefoot Floors).
Risentito oggi Homegrown non ha perso nulla delle sue qualità: è infatti un disco bello, intenso e tipico del Neil Young mid-seventies, con momenti di profonda malinconia alternati a potenti svisate elettriche. Non è forse il capolavoro che la leggenda narrava, in quanto sia Harvest che Zuma e forse anche On The Beach e Tonight’s The Night sono superiori, ma teniamo presente che lo standard qualitativo del Bisonte in quegli anni era incredibilmente alto. Tra i sessionmen presenti nelle varie canzoni ci sono vecchie conoscenze (Ben Keith alla steel, Tim Drummond al basso e Karl T. Himmel alla batteria) ma anche alcuni ospiti di vaglia, come il pianista Stan Szelest e soprattutto i “The Band Boys” Robbie Robertson e Levon Helm e la voce di Emmylou Harris. Tre dei dodici pezzi totali sono pubblicati nelle versioni già note (le splendide Love Is A Rose e Star Of Bethlehem, presenti sull’antologia Decade, e la discreta Little Wing che nel 1980 aprirà l’album Hawks And Doves), mentre due brani che in seguito verranno reincisi qui sono nella prima stesura: l’energica e roccata title track, bella versione con Keith alla slide e forse migliore di quella rifatta coi Crazy Horse per American Stars’n’Bars, e White Line (che Neil pubblicherà addirittura nel 1991 su Ragged Glory sempre con il Cavallo Pazzo), ottima anche in questa resa a due chitarre con Young e Robertson come soli musicisti presenti. I brani “nuovi” iniziano con Separate Ways (che comunque il nostro ha suonato diverse volte dal vivo), una notevole ballata country-rock elettroacustica caratterizzata dalla bella steel di Keith e dal tipico drumming di Helm: la parte vocale, anche se non particolarmente rifinita, è incisiva grazie anche alla solida melodia.
Try è una delicata country ballad (acustica, ma full band) sullo stile di Harvest, con pochi ma calibrati strumenti ed un bellissimo ritornello reso ancora più prezioso dalla steel e dall’intervento vocale della Harris; la malinconica Mexico vede Neil da solo al piano per un breve e tenue brano dalla musicalità quasi fragile, a differenza di Florida che non è una canzone ma una conversazione di Young con Keith e sottofondo di…bicchieri di vino (!): l’avrei lasciata volentieri in un cassetto. Bella la gentile ed intensa Kansas, solo voce, chitarra ed armonica, mentre We Don’t Smoke It No More è un blues cadenzato e pianistico con aggiunta di slide, un pezzo strepitoso e coinvolgente nonostante Neil non sia propriamente un bluesman: singolare poi che la voce entri solo dopo quasi due minuti e mezzo. L’ultimo dei brani inediti è anche uno dei migliori: Vacancy è infatti una notevole rock song elettrica e potente dal motivo diretto, un pezzo che è la quintessenza di Young e che non capisco come possa essere rimasto da parte fino ad oggi. Homegrown non sarà dunque quel masterpiece di cui si è a lungo favoleggiato, ma è di sicuro un disco che tende dal buono all’ottimo e che rappresenta alla perfezione il Neil Young della metà degli anni settanta.
E comunque dopo aver aspettato 45 anni il minimo che si possa fare è non farselo sfuggire.
Marco Verdi