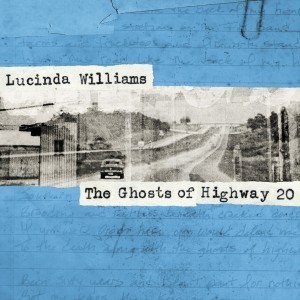Bill Frisell – Valentine – Blue Note CD
Bill Frisell, sopraffino chitarrista di orientamento jazz, durante la sua lunga carriera ha suonato di tutto. Dal suo esordio datato 1983 ad oggi ha pubblicato una miriade di lavori tra opere da solista e collaborazioni, spesso andando oltre il jazz e trascendendo i vari generi musicali, sperimentando via via con blues, country, folk e rock e realizzando dischi bellissimi come Nashville (forse il mio preferito), Gone Just Like A Train, Good Dog Happy Man, Blues Dream, The Willies, East/West, Big Sur (altro lavoro splendido), fino al recente Harmony, senza dimenticare il notevole Songs We Know, in duo con il pianista Fred Hersh, ed i due eccellenti album incisi come chitarrista del Ginger Baker Trio. Frisell è un chitarrista capace di coniugare tecnica e feeling, ed in grado di donare profondità con il suo tocco magico a tutti i brani a cui partecipa, cosa che lo ha portato negli anni ad essere rischiestissimo anche sui lavori altrui.*NDB Mi aggiungo io, ricordando un brano che secondo me contiene uno degli assoli più belli, lirici e lancinanti di Frisell, quello nella cover di Going Going Gone di Bob Dylan contenuta nel doppio CD Rubaiayt, che festeggiava i 40 anni della etichetta Elektra, cantata da Robin Holcomb, la trovate come brano n.25, a circa 1 ora e 33 minuti di questo link https://www.youtube.com/watch?v=h1sPaQVV684).
Valentine è il nuovo CD di Bill, ed è a mio parere uno dei suoi più riusciti, un lavoro che rappresenta una sorta di riepilogo di tutti gli stili provati in carriera: l’album è prodotto come d’abitudine da Lee Townsend (e mixato da Tucker Martine, noto per la sua collaborazione con i Decemberists) e vede il nostro esibirsi in trio assieme all’ottima sezione ritmica formata da Thomas Morgan al basso e Rudy Royston alla batteria, due musicisti con i quali Frisell ha un’intesa a prova di bomba in quanto lo accompagnano da anni on stage, ma che qui incidono con lui per la prima volta in studio. Valentine è un disco quasi perfetto nel suo genere, un album che si divide tra brani autografi vecchi e nuovi (la maggioranza) e qualche cover di estrazione molto eterogenea, il tutto con il comune denominatore della creatività di Bill e dei suoi compagni, che per tutti i 65 minuti del CD lasciano volare liberi i loro strumenti nell’aria. Apre il lavoro Baba Drame, un pezzo del cantautore del Mali Boubacar Traoré, brano attendista con Frisell che ricama di fino all’elettrica: c’è del rock ma non è un pezzo rock, ha la struttura tipica del trio jazz ma il jazz è solo sfiorato, e le percussioni aggiungono un sapore etnico.
Hour Glass è ipnotica, quasi psichedelica, e lascia il passo alla godibile title track, questo sì puro jazz, un brano che coniuga swing ed improvvisazione con una classe sopraffina (un applauso va anche ai due accompagnatori di Bill), mentre la notevole Levees mette insieme jazz ed influenze blues desertiche, un pezzo che piacerebbe molto ai Calexico. La rilassata e sinuosa Winter Always Turns To Spring Frisell l’aveva già incisa per l’album Ghost Town, ma qui mi sembra più ispirata; Keep Your Eyes Open è una deliziosa e quasi solare ballata accarezzata dal country e con un leggero mood anni 60: splendida. Altri episodi degni di nota sono lo standard A Flower Is A Lovesome Thing (composto da Billy Strayhorn), uno slow profondo e con un gran lavoro di basso, la western song Wagon Wheels (ma negli anni diventata anche un classico jazz), elegantissima e suonata in punta di dita, una rilettura pulsante ed assolutamente creativa di What The World Needs Now Is Love di Burt Bacharach, tra le più riuscite del CD, e l’acustica e leggiadra Where Do We Go?, in cui i nostri flirtano ancora col country; chiusura con una toccante versione della popolarissima folk song We Shall Overcome, quasi irriconoscibile ma densa di lirismo. Valentine quindi non è un disco di puro jazz, come non lo è di folk, blues, country, rock o fusion, ma è solo ed esclusivamente grande musica.
Marco Verdi