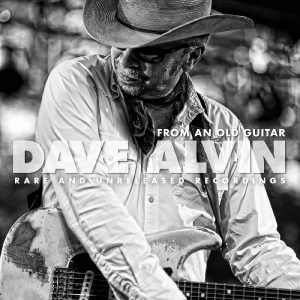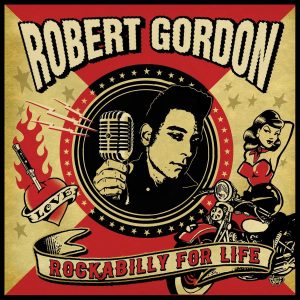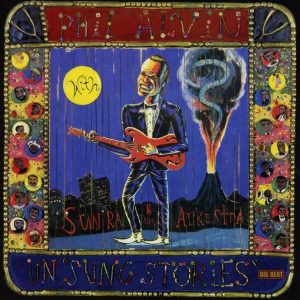Dave Alvin – From An Old Guitar: Rare And Unreleased Recordings – Yep Roc CD
Sono ormai diversi anni che Dave Alvin non ci regala un nuovo album di inediti, e per l’esattezza da Eleven Eleven del 2011, peraltro uno dei suoi lavori migliori https://discoclub.myblog.it/2011/07/04/elementare-watson-undici-album-undici-canzoni-dave-alvin-ele/ . Non è però che in questi nove anni l’ex chitarrista e principale compositore dei Blasters se ne sia stato con le mani in mano, dal momento che ha pubblicato due dischi di cover insieme al fratello Phil e, nel 2018, il riuscito Downey To Lubbock in partnership con Jimmie Dale Gilmore https://discoclub.myblog.it/2018/06/11/la-non-poi-cosi-tanto-strana-coppia-funziona-alla-grande-dave-alvin-jimmie-dale-gilmore-downey-to-lubbock/ . E quest’anno è uscito anche un altro ottimo disco https://discoclub.myblog.it/2020/03/06/un-dave-alvin-diverso-ma-sempre-notevole-the-third-mind/ . Ora il musicista californiano torna tra noi con From An Old Guitar, il cui sottotitolo Rare And Unreleased Recordings lascia capire che anche questa volta non siamo di fronte ad una proposta nuova di zecca, ma nello specifico ad una raccolta di brani pubblicati in passato ma di difficile reperibilità.
Infatti tra i sedici pezzi del disco troviamo canzoni provenienti da tribute albums da tempo fuori catalogo, brani pubblicati solo in forma “liquida” (e quindi mai in CD) ed anche due inediti assoluti. Un po’ come aveva fatto a fine 2018 John Mellencamp con Other People’s Stuff, che però era troppo breve (mentre From An Old Guitar dura 67 minuti) e raccoglieva diversi brani non così rari. Alvin è un grandissimo musicista, uno dei paladini del genere Americana, ed il bello del CD di cui mi accingo a parlare è che ha un’unitarietà ed una compattezza, oltre ad essere splendido, che lo fanno sembrare proprio un disco nuovo e non un collage di incisioni passate. From An Old Guitar è composto principalmente da cover (i brani originali sono solo tre), ed è un fantastico mix di rock’n’roll, folk, parecchio blues, country e ballate, tutti generi in cui Dave è in grado di dire la sua in maniera più che autorevole sia che si esibisca in veste acustica sia a capo di una rock band.Nelle varie canzoni troviamo qua e là membri dei Guilty Men e delle Guilty Women, l’ex sezione ritmica dei Blasters John Bazz e Bill Bateman, l’amico Chris Gaffney, scomparso ormai da diversi anni, gli abituali collaboratori Greg Leisz e Rick Shea oltre a luminari come Bill Frisell, i bassisti Dave Roe e Bob Glaub, il pianista Gene Taylor e l’ex BR5-49 Chuck Mead.
I pezzi meno rari dell’album sono due canzoni tratte dall’edizione “expanded” di Eleven Eleven (entrambe scritte da Alvin), ovvero il travolgente boogie chitarristico Beautiful City ‘Cross The River, con la fisarmonica di Skip Edwards che crea un accattivante contrasto sonoro (ma sentite che due assoli che piazza Dave) ed il sinuoso ma solido blues elettrico Signal Hill Blues, suonato in maniera molto classica con due chitarre, basso e batteria. Cinque pezzi sono presi da vari tributi, a partire da Link Of Chain di Chris Smither, sontuosa ballata in bilico tra country e blues con uno splendido interplay chitarristico tra l’acustica di Dave e la slide di Danny Ott ed un motivo di prima scelta. Amanda di Waylon Jennings (ma scritta da Bob McDill) è rifatta in perfetto stile valzerone texano, cantata alla grande e suonata anche meglio, Mobile Blue (Mickey Newbury) è puro country-rock elettrico dal ritmo spedito e melodia diretta e coinvolgente, molto Blasters, mentre la folkeggiante e cristallina On The Way Downtown di Peter Case è uno dei tanti momenti magici di un disco che è un piacere continuo: Gaffney si unisce a Dave nel ritornello ed il brano viaggia spedito che è una meraviglia.
Il quinto ed ultimo brano tratto da un tributo è il formidabile rockin’ country Dynamite Woman, un classico di Doug Sahm che Alvin fa suo con una performance decisamente contagiosa. Ed ecco una delle parti più interessanti del CD, vale a dire sette pezzi pubblicati solo sul sito web della Yep Roc e quindi mai prima di oggi in formato fisico: si parte con un’ottima rilettura del classico di Bob Dylan Highway 61 Revisited, con Dave che usa il talkin’ alla John Lee Hooker (e la sua voce baritonale aggiunge fascino), mentre la parte strumentale tra blues e boogie è una goduria. Variations On Earl Hooker’s Guitar Rumba è uno strepitoso strumentale dal ritmo latineggiante scritto dal musicista citato nel titolo, con un sublime assolo pianistico di Joe Terry subito doppiato dalla fisa di Gaffney e Dave che ci regala fraseggi che sembrano uscire da una revue degli anni 50, al punto che mi aspetto quasi l’entrata della voce di Raul Malo da un momento all’altro. Albuquerque, di Papa Link Davis, è rifatta in puro spirito rock’n’roll con il nostro che va giù dritto di wah-wah ben sostenuto da una ritmica granitica ed un’armonica bluesy.
Perdido Street Blues (antico brano dei New Orleans Wanderers scritto da Lil Hardin, seconda moglie di Louis Armstrong) è un altro strumentale godurioso e swingatissimo, con prestazioni superbe di Dave alla chitarra, Taylor al piano e Leisz alla steel, un divertimento unico sia per loro che suonano che per noi che ascoltiamo; Krazy And Ignatz, terza ed ultima canzone composta da Alvin, è uno splendido duetto blues ancora strumentale tra la national guitar del leader ed il dobro di Cindy Cashdollar. Chiudono i sette brani pubblicati per la prima volta su CD una cadenzata e sanguigna rilettura del blues di Willie Dixon Peace ed una ripresa di Man Walks Among Us di Marty Robbins in veste di moderna western ballad. Dulcis in fundo, ecco i due inediti assoluti: Inside è la toccante cover di un brano dello scomparso Bill Morrissey, un pezzo fluido e disteso che dimostra la bravura di Dave anche in veste di balladeer, mentre Who’s Been Here è un duetto tra Alvin e Christy McWilson su un vecchio blues di Bo Carter trasformato in un trascinante country’n’roll con chitarre e dobro in evidenza. E’ un peccato che From An Old Guitar non sia un vero “nuovo” album: saremmo infatti di fronte ad uno dei dischi dell’anno.
Marco Verdi