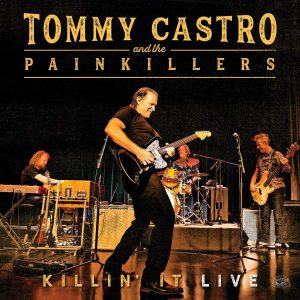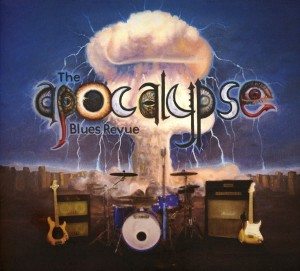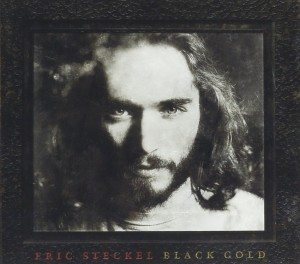Supersonic Blues Machine – Road Chronicles: Live! – Provogue/Mascot CD
Primo album dal vivo per i Supersonic Blues Machine, power trio formatosi nel 2015 a Los Angeles ma solo per un terzo americano (il ben noto e poderoso batterista Kenny Aronoff, il miglior rock drummer sulla terra insieme a Max Weinberg), in quanto gli altri due membri sono l’italianissimo bassista Fabrizio Grossi ed il chitarrista e cantante inglese Kris Barras (che ha sostituito nel Gennaio del 2018 il texano Lance Lopez). I due dischi di studio dei SBM, West Of Flushing, South Of Frisco e Californisoul https://discoclub.myblog.it/2017/11/28/anche-loro-sulle-strade-della-california-rock-supersonic-blues-machine-californisoul/ , non avevano mancato di attirare l’attenzione della critica internazionale e dei fans della musica rock-blues più sanguigna, grazie anche alla serie impressionante di ospiti che vi partecipavano (Billy Gibbons, Walter Trout, Warren Haynes, Eric Gales, Robben Ford, Chris Duarte e Steve Lukather) da loro conosciuti, oltre che per le molteplici collaborazioni di Aronoff, grazie all’amicizia di Grossi con Gibbons, che ha aiutato l’italiano ad entrare nel giro che conta.
Ora i nostri pubblicano questo Road Chronicles: Live!, resoconto dell’ultimo concerto del tour europeo dello scorso anno, tenutosi il 20 Luglio a Brugnera, in provincia di Pordenone (la hometown di Grossi). Ci troviamo di fronte ad un disco dal vivo di grande valore, che testimonia la bravura dei tre sul palco (la formazione è completata da Serge Simic alla seconda chitarra, Alex Alessandroni alle tastiere e dal supporto vocale di Andrea Grossi, moglie di Fabrizio, e Francis Benitez): rock-blues di notevole potenza, con le chitarre sempre a manetta ed una sezione ritmica schiacciasassi (e d’altronde Aronoff non lo scopriamo oggi), il tutto condito dalla voce arrochita di Barras, una via di mezzo tra Haynes e Mellencamp. Già così il disco sarebbe da consigliare, anche perché oltre alla potenza ci sono anche le canzoni che non sono affatto male, ma la ciliegina sulla torta è la presenza proprio di Gibbons nei sei pezzi finali, e senza nulla togliere a Grossi e compagni da lì in poi la temperatura sale di brutto. Dopo una breva introduzione registrata parte I Am Done Missing You, che inizia con il tipico drumming travolgente di Aronoff e poi vede entrare la chitarra di Barras ed il resto della band per un solido rock-blues di matrice sudista, con cori femminili che donano un retrogusto soul. I Ain’t Fallin’ Again è una rock song potente e granitica che dimostra la solidità dei nostri, con influenze che vanno dai Cream a Jimi Hendrix, mentre Remedy è una ballatona sempre decisamente elettrica con chitarre in tiro, una melodia fluida e distesa ed un ritornello corale ancora molto southern (facendo le debite proporzioni, siamo dalle parti della Tedeschi Trucks Band).
Can’t Take It No More è uno slow blues con organo e chitarra solista in grande spolvero e solito refrain corale: la SBS ha dei numeri e sembra americana al 100%, e non solo per un terzo; Watchagonnado è un funk-rock decisamente annerito e coinvolgente, con un refrain perfetto per il singalong, uno dei pezzi più convincenti della serata, e precede la possente Elevate, un rockaccio diretto come un macigno dai toni quasi hard, ma sempre con elementi blues nel dna (chi ha detto Gov’t Mule?). Chitarre taglienti anche in Bad Boys, ancora tra rock e funky, mentre la lunga Let It Be (i Beatles non c’entrano) è nuovamente un ficcante blues con robuste iniezioni di rock, ed ottime parti chitarristiche stavolta ispirate da un maestro come Stevie Ray Vaughan. Ed ecco iniziare il concerto nel concerto, con Billy Gibbons che sale sul palco ed entusiasma subito il pubblico con una tonante versione della leggendaria La Grange, seguita dalla travolgente Broken Heart, una rock’n’roll song dal riff assassino che ricorda gli ZZ Top più diretti (e chi se no?), ed una vorticosa rilettura del classico di Elmore James Dust My Broom, strepitosa e coinvolgente https://www.youtube.com/watch?v=KhalRIkRoFE : tre canzoni e Billy si è già preso la scena. Il barbuto axeman resta on stage anche per i tre pezzi finali, la roboante Running Whiskey, con Aronoff che picchia come un ossesso, una tostissima interpretazione dell’evergreen di Muddy Waters Got My Mojo Working, con la band che va come un treno (ed un grande assolo di piano), ed il saltellante rock-blues Going Down, degna conclusione di una serata musicalmente torrida.
I loro due album di studio erano più che buoni, ma è sul palco che i Supersonic Blues Machine danno il loro meglio: garantisce Billy F. Gibbons.
Marco Verdi