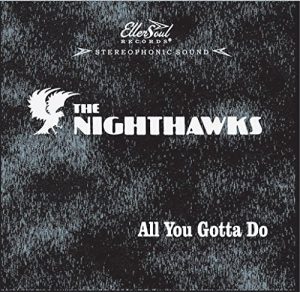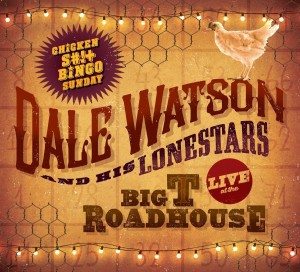Tony Joe White – Bad Mouthin’ – Yep Roc CD
Tony Joe White, noto cantautore e musicista originario della Louisiana e tra i massimi esponenti del cosiddetto swamp-rock, è uno di quelli che, se proprio non fa sempre lo stesso disco, di sicuro non abbandona mai del tutto il suo stile https://discoclub.myblog.it/2016/07/05/sempre-la-solita-zuppa-si-ottimo-saporito-gumbo-tony-joe-white-rain-crow/ . Quando però la qualità è sempre medio-alta questo fatto può essere indubbiamente positivo, dato che comunque stiamo parlando di uno che raramente tradisce. Nel corso di una lunga carriera iniziata alla fine degli anni sessanta, White ha inciso più di venti album di studio, dischi a cavallo tra rock e blues, ritagliandosi il ruolo di musicista di culto e creando uno stile “laidback” molto riconoscibile, che lo ha sempre fatto sembrare una sorta di J.J. Cale più paludoso https://discoclub.myblog.it/2010/09/20/lampi-dal-passato-tony-joe-white-that-on-the-road-look-live/ . Ho detto del blues, un genere che nella sua musica è sempre stato un elemento fondamentale, anche se fino ad oggi Tony un disco di solo blues non lo aveva mai registrato. Ebbene, con Bad Mouthin’ White ha fatto il suo primo “blues-based album”, ed alla bella età di 75 anni: un po’ come Billy Gibbons con The Big Bad Blues (di cui mi sono occupato nella prima parte di questo doppio post), ma a differenza del leader degli ZZ Top, che ha optato per sonorità vigorose e molto rock, Tony ha fatto un disco nel suo stile abituale, in maniera totalmente rilassata ed operando quasi per sottrazione.
Anche il gruppo che lo accompagna è ridotto all’osso: infatti, oltre alla chitarra ed armonica di Tony, abbiamo soltanto la sezione ritmica formata da Steve Forrest (basso) e Bryan Owings (batteria), ed anche la produzione di Jody White (suo figlio) è scarna ed essenziale. Ma Tony è questo, non cambia nemmeno se gli sparate, ma alla fine Bad Mouthin’ si lascia ascoltare tutto d’un fiato e ci consegna un musicista in ottima forma, oltre che pienamente credibile anche come bluesman. Il disco, dodici canzoni, si divide a metà tra cover e brani originali, alcuni dei quali sono stati scritti in gioventù da White e poi lasciati in un cassetto, ma suonano freschi come se fossero stati composti la settimana scorsa. Il CD inizia benissimo con la title track, un blues all’apparenza canonico che però viene nobilitato dalla performance del nostro, al solito rilassata (a volte sembra che si sia appena svegliato), ma puntuale e precisa negli spunti chitarristici e di armonica, un pezzo che ha molto in comune con il già citato J.J. Cale, altro maestro dello “scazzo” messo in musica. Baby Please Don’t Go, di Joseph Lee Williams e resa popolare dai Them, è molto diversa da quella di Van Morrison e soci, in quanto vede Tony in perfetta solitudine, solo voce, armonica e chitarra acustica, per uno stripped-down blues di notevole intensità, e lo stesso arrangiamento è riservato anche alla sua Cool Town Woman, che sembra la prosecuzione della precedente, con forse una partecipazione leggermente maggiore da parte del nostro.
Ecco due splendide cover di due classici assoluti: Boom Boom di John Lee Hooker è elettrica, cadenzata e più rallentata rispetto all’originale, ed assume un’aria quasi minacciosa (lo stile di White in questo disco è simile a quello dei primi dischi del grande Hook), e Big Boss Man di Jimmy Reed, ancora acustica ed essenziale (con questo tipo di approccio Tony potrebbe registrare un album al giorno). Poi abbiamo tre pezzi originali in fila: la strascicata Sundown Blues, elettrica ma suonata in maniera pacata e suadente, con gli ottimi fraseggi tipici del nostro, l’ironica Rich Woman Blues, di nuovo con Tony in “splendid isolation”, ed il breve strumentale Bad Dreams, che confluisce nella Awfyìul Dreams di Lightnin’ Hopkins, sempre con andatura sonnolenta e con la sezione ritmica che sembra registrata nella stanza accanto, ma in cui il feeling non è di certo estraneo. Down The Dirt Road Blues, un vecchio classico di Charley Patton, aumenta decisamente il ritmo, anche se White non è che si faccia prendere dalla frenesia (ma non sarebbe lui se lo facesse), Stockholm Blues è ancora un’oasi acustica, un blues piuttosto canonico che però Tony riesce a rendere non banale; finale sempre unplugged con Hearbreak Hotel, proprio l’evergreen di Elvis Presley (che nei primi anni settanta aveva inciso Polk Salad Annie di Tony), una canzone famosissima che il nostro reinventa da capo a piedi, trasformandola in un oscuro blues paludoso.
Bad Mouthin’ è quindi l’ennesimo disco riuscito della carriera di Tony Joe White, un omaggio al blues fatto con cuore e feeling, pur senza rinunciare al consueto approccio “rallentato”.
Marco Verdi