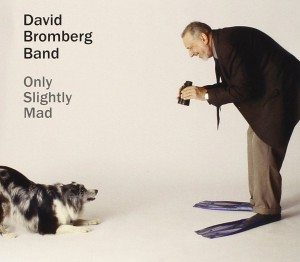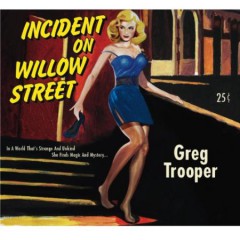Beth Hart – Better Than Home – Provogue/Mascot/Edel
Il nome di Beth Hart solitamente non si accosta al termine singer songwriter, o se preferite, in italiano, cantautrice. Quando pensiamo alla cantante di Los Angeles il suo stile viene avvicinato alle grandi interpreti del rock e del soul, da Etta James ad Aretha Franklin, passando per Janis Joplin e Grace Slick, e naturalmente anche Tina Turner, una che, soprattutto nella prima parte della sua carriera, ha saputo fondere i due generi alla perfezione. Ma Beth Hart ha sempre scritto le sue canzoni, non dimentichiamo che il suo primo successo fu la canzone LA Song (Out Of This Town) che nel lontano 1999 fu utilizzata nell’ultima stagione di Beverly Hills, 90210, anche se erano altri tempi. Poi, con il tempo, la nostra amica si è costruita una grande reputazione come interprete dal vivo, una delle rocker più intemerate in circolazione, in possesso di una voce potente ed espressiva, temprata da migliaia di concerti, ma, nella prima parte della carriera, forse, anche un po’ troppo tamarra e sopra le righe, “esagerata”, come dimostra il peraltro pregevole DVD e CD Live At Paradiso, registrato nel famoso locale di Amsterdam https://www.youtube.com/watch?v=EbwggC8tdhU , e che ha inziato la sua fortunata storia con il pubblico olandese. Però la fama (sempre limitata, non da stadi o talent vari, anche se… https://www.youtube.com/watch?v=d26gbMol7IA notare la differenza tra le due) e i riconoscimenti della critica sono venuti con gli ultimi album, soprattutto quelli registrati in coppia con Joe Bonamassa, due in studio e uno del dal vivo, fantastico, registrato sempre ad Amsterdam http://discoclub.myblog.it/2014/04/11/potrebbe-il-miglior-live-del-2014-beth-hart-joe-bonamassa-live-amsterdam/.
Se volete verificare la sua potenza di performer dal vivo non dovete fare altro che recarvi all’Alcatraz di Milano il prossimo martedì 28 aprile per l’unica data italiana del suo tour europeo (biglietti dovrebbero essercene ancora), OK, non è accompagnata da Bonamassa con la sua band, ma avendola già vista dal vivo nel suo primo passaggio in Italia, vi posso assicurare che è un evento da non perdere, Beth Hart è un vero animale da palcoscenico, degna in tutto e per tutto, vocalità, presenza scenica e repertorio, delle grandi cantanti del passato, ed in possesso anche di una genuinità e una simpatia che la rendono unica. Tornando al nuovo disco, forse proprio il repertorio potrebbe essere l’unico punto debole di questo nuovo Better Than Home https://www.youtube.com/watch?v=cWDMsvyHKQo : un disco basato su molte ballate scritte dalla stessa Beth, e pochi pezzi rock, soul & blues, come negli ultimi dischi in coppia con Bonamassa (ma tutti e due, separatamente, hanno già promesso che ci sarà un nuovo capitolo nel 2016, e se lo dicono entrambi c’è da crederci), non dimentichiamo comunque che andiamo a confrontarci con una seria di cover che vengono dal repertorio di gente come Billie Holiday, Etta James, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, ma anche Buddy Miles, Al Kooper, Melody Gardot, tra le nuove leve, e ancora Tom Waits, Ray Charles, Bill Withers, Delaney And Bonnie, quindi è quasi inevitabile che questi pezzi da novanta confrontati con le canzoni scritte dalla Hart possano risultare difficili da raffrontare https://www.youtube.com/watch?v=QgBff_8pJoQ . Ma persistendo nell’ascolto, come ha fatto chi vi scrive, questo nuovo album, alla lunga, ha un suo fascino e un suo perché.
Un brano come l’iniziale Might As Well Smile si pone nel solco di quelle ballate soul Memphis style che deliziavano le orecchie degli ascoltatori nel periodo d’oro di questa musica https://www.youtube.com/watch?v=SRpdpxRg5xs , punteggiata dal lavoro dei fiati e delle coriste la canzone è una piattaforma perfetta per ascoltare la voce della Hart, che in fondo è il suo punto di forza, tenera e vulnerabile, espressiva e potente, con un phrasing perfetto acquisito con il passare del tempo ed ora giunto alla maturità. Non guasta la bravura dei musicisti utilizzati, a partire da Larry Campbell, chitarrista che ha suonato con molti dei grandi, diciamo giusto Levon Helm e Dylan, l’ottimo Charlie Drayton alla batteria (con Madeleine Peyroux, Dar Williams e Bettye Lavette, ma anche con in passato con Keith Richards, Simon & Garfunkel, Neil Young, Johnny Cash e una miriade di altri), anche Zev Katz, il bassista, ha un CV di tutto rispetto. Le mie perplessità (e anche quelle di Beth, in alcune interviste rilasciate, dove esprimeva la sua riluttanza a lasciare un produttore come Kevin Shirley, con cui aveva lavorato benissimo negli ultimi album) risiedevano nel nome del nuovo produttore, arrangiatore e tastierista, tale Rob Mathes, uno che, partito, con Chuck Mangione, nel corso degli anni si era fatto un nome arrangiando eventi come il Pavarotti and Friends, l’insediamento di Obama alla Casa Bianca, i concerti al Lincoln Center, oltre ai dischi di George Michael, Panic At The Disco ed altre amenità del genere. Invece devo dire che l’album, pur non essendo un capolavoro, è decisamente, come dico nel titolo del Post, un “Bel disco”!
Il formato musicale preponderante è la ballata, ma se i punti di riferimento sono l’Elton John anni ’70 (una delle passioni della Hart), il blue-eyed soul, le canzoni di Laura Nyro e Carole King, fatte le dovute proporzioni, per bilanciare, aggiungiamo una Adele, nei suoi momenti migliori, e con un carico di musica nera e gospel, che la giovane cantante inglese non ha nel suo bagaglio, forse più Rumer (con cui Mathes ha collaborato), un’altra innamorata degli anni ’70 e delle belle canzoni. Prendete due brani come Tell ‘Em To Hold On, una canzone pianistica strepitosa che potrebbe ricordare nella sua costruzione in crescendo l‘Elton John “americano https://www.youtube.com/watch?v=4TgrjTPlCsY , quello di Tumbleweed Connection, con retrotoni gospel ed una interpretazione vocale da sballo con Beth che lascia andare in libertà e a piena potenza la sua voce, o come un’altra ballata melodica e malinconica come Tell Her You Belong To Me, dove l’arrangiamento di archi (e fiati) accentua il tono appassionato della canzone, ricca di pathos, pochi tocchi ben piazzati di chitarra, il dualismo piano-organo e quella voce magica che galleggia sull’ottimo arrangiamento di Mathes (chiedo venia per avere pensato male) https://www.youtube.com/watch?v=CYABiE1-FAQ . Trouble è uno dei rari momenti dove la grinta proverbiale di Beth Hart esce allo scoperto, tra riff chitarristici che mi hanno ricordato i Beatles (perché? Non so, così, un’impressione) e voce sparata alla Tina Turner, quando divideva ancora i palchi con Ike, scariche di fiati all’unisono e quel pizzico di gigioneria che dal vivo verranno, immagino, ulteriormente, amplificati (vedere, e sentire, per credere) https://www.youtube.com/watch?v=MGUA3eiNYH4. E che dire di Better Than Home, la title-track, una bellissima ballata mid-tempo melodica, quasi pop, ma di quello di altri tempi, con un giro di basso “geniale” che la percorre, e un ritornello che si memorizza con grande piacere.
Pure St. Teresa rimane in questo spirito à la Elton John, con florilegi pianistici di gran classe e la vocalità trattenuta ma perfetta per questo tipo di brano, e addirittura in We’re Still Living In The City, se possibile, il suono si fa ancora più scarno, solo voce e una chitarra acustica, con gli archi sullo sfondo, e poi in primo piano, a colorare il suono, in un modo che Paul Buckmaster avrebbe approvato, mentre in The Mood That I’m In va di groove, tra funky e swing, con una chitarrina pungente ed un eccellente lavoro d’assieme di tutti i musicisti impiegati e la voce sempre godibile di Beth, qui un poco più vivace, non ti dà la scossa di molti dei brani con Bonamassa, ma l’insieme è più mosso. Mechanical Heart è un’altra ballata struggente, quella scelta come motivo promozionale per presentare l’album prima dell’uscita https://www.youtube.com/watch?v=nM2N4BeRkFE, bellissima, ariosa, radiofonica nel senso più nobile del termine, con gli archi che la avvolgono e la nobilitano in modo deciso. As Long As I Have A Song potrebbe, come ricordavo all’inizio, avvicinarsi alle sonorità di grandi cantautrici come Laura Nyro o Carole King, anche se con la voce di Beth Hart che è uno strumento di grande fascino di per sé. Conclude la bonus track (ormai un obbligo per le case discografiche) Mama This One’s For You, dove Beth siede al piano in solitaria per un sentito omaggio alla sua amata genitrice.
Concludendo, questo Better Than Home, più lo senti più ti piace, bisogna ascoltarlo diverse volte, ma poi ti entra dentro e anche se non ha la forza dirompente delle collaborazioni con Bonamassa ( e della sua chitarra) è forse il suo miglior disco da solista, o da cantautrice, se preferite. Comunque dal vivo è imperdibile!
Bruno Conti