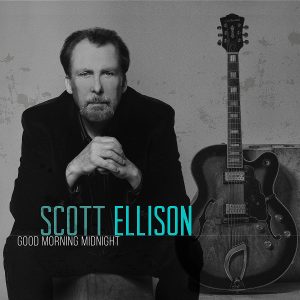Elton John – Jewel Box – 8CD Box set Universal/EMI
Di Reginald Dwight, in arte Elton John, anzi Sir Elton John, non esistono molti cofanetti, anzi a memoria ne ricordo solo uno, …To Be Continued, mentre di antologie, a parte le innumerevoli raccolte di successi, ricordo solo la doppia Rare Masters, entrambe uscite negli anni ‘90: quindi questo Jewel Box è una gradita sorpresa per i fans dell’occhialuto cantante, a parte per il prezzo, che dovrebbe essere di circa un centone di euro, benché la confezione sia lussuosa, con un bellissimo librone rilegato inserito nella confezione. Se ne parlava da tempo, ma alla fine l’uscita è stata fissata per il 13 novembre, per inserirsi nell’appetito periodo natalizio, dove le pubblicazione, soprattutto di box, si moltiplicano: negli 8 CD ci sono 148 brani, di cui 60 completamente inediti e altri comunque rari, mai usciti su compact.
Approfondiamo velocemente (anche se per ascoltare il tutto ci ho messo una decina di ore) per vedere se i contenuti valgono la spesa, anche per il fan non accanito. I primi due CD Deep Cuts, presentano una selezione di brani scelti dallo stesso Elton tra la sua sterminata produzione, 31 canzone pescate tra quelle non famosissime, più con un criterio che premia la qualità, scelte tra gli album e non inserite in ordine cronologico, ce ne sono tre estratte dall’album con Leon Russell, altre, molto belle, prese da Tumbleweed Connection, Captain Fantastic, Blue Moves, Goodbye Yellow Brickroad, il disco Duets, da cui proviene The Power con Little Richard e altri album storici, ma Too Low For Zero;, Stones Throw From Hurtin? con un falsetto irritante (anche se l’assolo di Davey Johnstone…) e altre tre o quattro, grazie ma anche no.
Dal terzo CD parte una serie definita Rarities 1965-1971, e qui c’è trippa per gatti: Come Back Baby con i Bluesology, del 1965, è la prima canzone scritta da Elton e la prima incisa in assoluto, Mr. Frantic sempre da quel periodo è del discreto pop/R&B d’epoca, Scarecrow del 1967, il primo brano in assoluto composto con Bernie Taupin, è un demo solo piano e tamburino, seguito da una lunga serie di demo per voce e pianoforte (sedici in tutto), registrati nel 1968, embrionali ma interessanti, qualità sonora buona e già con lo stile del nostro quasi formato, ad occhio, anzi orecchio, nessuno immancabile, alcuni quasi.
Più godibili invece le canzoni incise con una band, sia in forma di demo che versioni compiute, 25 o 26 in tutto (le ho contate), inframmezzate ad altre solo voce e piano: alcune sono le prime versioni alternate di futuri capolavori, come My Father’s Gun, Burn Down The Mission, Madman Across The Water, altre chicche assolute del 67-68 Nina, dedicata alla Simone, da sempre una delle preferite di Elton John, che suona l’organo, la ritmata Thank You For All Your Loving, la complessa Watching The Planes Go By, il piacevole pop di When The First Tear Shows, con uso di fiati, Tartan Coloured Lady, sullo stile di Empty Sky. Nel CD dedicato al 1968 piacevole Hourglass, 71-75 New Oxford Street dall’incedere rock, Turn To me più pop, insomma tutti brani gradevoli, ma forse nulla di indimenticabile,anche se la stoffa si vede, come dimostra il demo di Skyline Pigeon, ma il nostro è ancora acerbo. Dal terzo dischetto di rarities 1968-1971, oltre ai classici citati, Sing Me No Sad Songs, con qualche citazione di future hits.
Mentre decisamente più interessanti sono i due CD di B-Sides: in ordine cronologico, il primo dal 1976 al 1984 contiene il duetto con Kiki Dee Snow Queen, una bella ballata romantica, le due collaborazioni con la cantante francese France Gall, cantate in francese, un altro brano in francese, la bella ballata Conquer The Sun, cito alla rinfusa, perché le canzoni sono veramente tante, lo strumentale Tactics del 1980, la quasi funky Fools In fashion del 1981, e la ritmata Hey Papa Legba, lato B di Blue Eyes del 1982, con la danzerecca Take Me Down To the Ocean dallo stesso 12”, mentre molto bella in chiusura A Simple Man.
Nel CD 1984-2005 lo strumentale per synth Highlander, salterei il materiale anni ‘80, e anche sui primi anni ‘90 stenderei un velo pietoso, appena discreta I Know Why I’m Love dalla raccolta Love Songs del 1997, meglio il rock Big Man In A Little Suit del 1998, molto bella The North Star del 2001, una rara b-side da Songs From The West Coast, quando la qualità della sua musica riprende a salire, e buona anche Did Anybody Sleep With Joan Of Arc dello stesso anno, come pure la bellissima country song con pedal steel So Sad The Renegade del 2004 e sempre dai lati B di Peachtree Road l’ottimo filotto di canzoni A Little Peace, Keep It A Mystery, How’s Tomorrow, Peter’s Song e Things Only Get Better With Love, che alzano drasticamente la qualità delle rarità.
L’ultimo CD ...And This Is Me è una scusa per Elton John per scegliere altre celebri canzoni dal suo songbook, citate peraltro nel sua biografia Me, in uscita sempre in questo periodo (ah il marketing!): Empty Sky, Lady Samantha, Border Song, My Father’s Gun, Philadelphia Freedom, Son For Guy, fino ad arrivare al duetto con Taron Engerton I’m Gonna Love Me Again, dalla colonna sonora di Rocketman. Libro molto bello rilegato, come detto, con la presentazione dello stesso Elton dei brani da Deep Cuts, per cui alla fine della storia diciamo consigliato, ma con riserva, soprattutto per fan appassionati, magari proprio a Natale, come regalo e finanze permettendo, ci si potrà fare un pensierino.
Bruno Conti