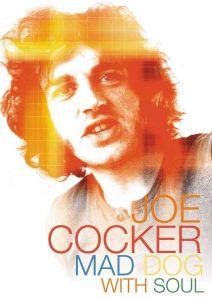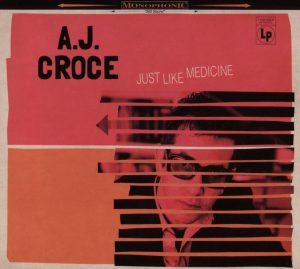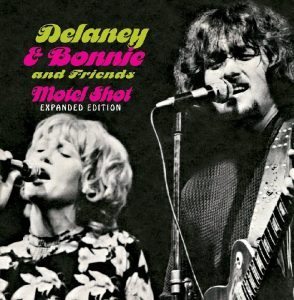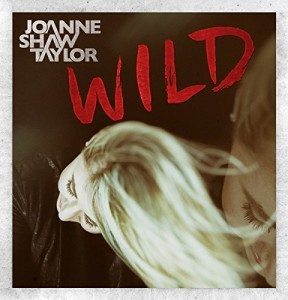Joe Cocker – Mad Dog With Soul – Eagle Rock/Universal DVD
Sono passati ormai più di 2 anni dalla scomparsa di Joe Cocker http://discoclub.myblog.it/2014/12/23/conclusione-anno-terribile-livello-decessi-nellambito-musicale-ieri-morto-anche-lacciaio-sheffield-joe-cocker-1944-2014/ , quindi pareva quasi inevitabile che prima o poi al grande cantante di Sheffield venisse dedicato un documentario che ne tracciasse il percorso umano e musicale. Di DVD dal vivo di Cocker ne esistono molti, a partire dallo splendido Mad Dog And Englishmen, quello da avere assolutamente, e poi vari concerti dal vivo registrati soprattutto nella seconda parte della sua carriera, ma nessuno si era spinto a tracciare in modo così approfondito la sua biografia, e questo Mad Dog With Soul (titolo che dice già tutto) lo fa in modo eccellente, anche se come quasi tutti i vari tipi di “rockumentary”, lo fa, purtroppo, a scapito della musica, perché di materiale dal vivo ce n’è veramente poco. Intendiamoci, il film è fatto molto bene, con familiari, amici e musicisti che lo hanno conosciuto che raccontano la storia della sua travagliata vicenda con ricchezza di particolari, in modo molto umano, a tratti persino emozionante nei continui saliscendi della sua vicenda artistica e umana, ma su 90 minuti di durata (più altri 30 minuti di materiale extra), a voler esagerare, ci saranno dieci forse quindici minuti di pezzi tratti da concerti o apparizioni televisive, sempre in brevissimi spezzoni che finiscono praticamente quasi subito.
D’accordo, la storia è appassionante e ricca di colpi di scena, però il DVD non ha neppure i sottotitoli in italiano e qualche pezzo musicale completo ci sarebbe stato molto bene. Comunque la vicenda parte nell’Inghilterra della fine anni ‘50 attraverso le voci dei vari protagonisti: lo stesso Joe Cocker con interviste d’archivio, il fratello Victor, la vedova Pam Baker Cocker che entra nella vicenda solo verso la fine degli anni ’70, e poi Chris Stainton, Jerry Moss, Rita Coolidge, Billy Joel, Jimmy Webb, Randy Newman, uno dei suoi manager Michael Lang (proprio lui, l’organizzatore del Festival di Woodstock) e altri “interpreti minori”. Il film, tra l’altro parte alla grande, con un filmato di Joe Cocker, dal vivo a New York, nel 1970, che canta una With A Little Help From My Friends tratta dal tour di Mad Dog, con Leon Russell e il suo cilindro che lo affiancano, ma in meno di un minuto è già finito. E questo già indica come sarà il contenuto del film: interviste con un giovane ed arruffato Joe, spesso trasandato, timido, ma ancora dotato del bene dell’intelletto, che racconta di quando da bambino, intorno ai dodici anni, a casa, davanti allo specchio, si esercitava con una racchetta da tennis in quella che poi sarebbe stata definita “air guitar”; Phil Crookes, uno dei suoi primi amici nella Sheffield degli anni ’50, racconta che sin da allora Joe ascoltava molto la radio e aveva già sviluppato la sua passione per quello che sarebbe stato il faro e il modello di tutta la sua carriera, Ray Charles. Insomma, il film si vede con piacere, nella sua narrazione che ci porta dal primo brano di successo, scritto con Chris Stainton, Marjorine, al primo album, prodotto da Denny Cordell, e con Jimmy Page, Steve Winwood e altri luminari dell’epoca impegnati nel disco, l’incontro con i Beatles, Harrison e McCartney che gli regalano Something e She Came In Through The Bathroom Window, per il secondo disco, e anche quello con Jerry Moss, il boss dell’A&M che lo lancerà, dopo il grandissimo successo di Woodstock (anche qui proprio un filmato da intramuscolo, con Billy Joel che ricorda di averlo visto ed essere rimasto folgorato da quella voce incredibile).
E ancora, Rita Coolidge che ricorda l’esperienza del tour di Mad Dog, guidato da Leon Russell, delegato dallo stesso Cocker, e al termine del quale gli oltre 50 protagonisti erano praticamente senza un soldo, e Joe sviluppò la sua dipendenza per qualsiasi tipo di droga, alcol e pasticche, che nel giro di un anno lo avrebbero trasformato in una sorta di relitto umano, e le foto e i filmati di un Joe Cocker simile a un barbone, ormai privo del lume della ragione sono impressionanti: fino al culmine del suo concerto di rientro, in cui c’era tutta l’industria discografica e Joe non riuscì non dico a cantare ma neppure a muoversi. Poi ci sono i tentativi di recupero con l’aiuto di Lang, alcuni momenti felici, dall’incontro con l’idolo (anzi il Dio) Ray Charles, al piano di fianco ad un adorante Cocker mentre cantano You Are So Beautiful, a quello con la futura moglie Pam che dividerà con lui gran parte della vita, il ritorno al successo con Up Where We Belong in coppia con Jennifer Warnes e You Can Leave Uour Hat On, fino agli anni ’90 e oltre, quando grazie all’incontro con il nuovo manager (mollando Lang senza un ringraziamento), lo stesso di Tina Turner, tornerà ad essere una superstar in giro per tutto il mondo, anche se, aggiungo io, i livelli qualitativi dei primi anni non verranno mai più raggiunti. Motivi quindi per guardare questo DVD ce ne sono, pur se con i limiti espressi all’inizio.
Bruno Conti