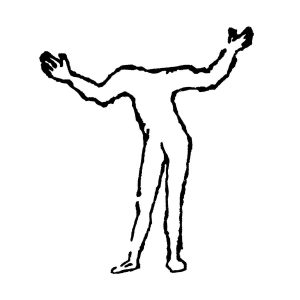Ralph McTell – Hill Of Beans – Leola Music
Toh, guarda chi si rivede e si risente! Ralph McTell, da Farmsborough, Kent, dove è nato quasi 75 anni fa, ma da sempre cittadino di Londra, anzi del sobborgo di Croydon, città alla quale ha dedicato il suo brano più celebre, Streets Of London, con 212 versioni cantate in giro per il mondo, non escluse ben sei (o forse sette) dello stesso Ralph, l’ultima delle quali, incisa nel 2017 insieme a Annie Lennox per raccogliere fondi per una associazione che si occupa dei senzatetto, per la prima volta ha raggiunto il primo posto delle classifiche inglesi (prima non c’era mai riuscito, arrivando al massimo al n°2). Ma è stato anche uno dei migliori e più prolifici rappresentanti del filone del folk britannico, con oltre 50 album pubblicati, in una carriera iniziata nel lontano 1968 con un album Eight Frames A Second, prodotto da Gus Dudgeon e arrangiato da Tony Visconti (che torna a riunirsi proprio con McTell, producendo questo Hill Of Beans). Il nostro amico diciamo che pur essendo un eccellente chitarrista (solo nell’ultima decade ha rilasciato una serie di sei album dal vivo, Songs For Six Strings), è da ascrivere più al filone dei cantautori, fatte le dovute proporzioni e diverse attitudini, quello che ha prodotto Donovan, Cat Stevens, John Martyn, Nick Drake, i Fairport Convention, insieme ai quali ha spesso partecipato al loro leggendario Festival di Cropredy, ma pure Wizz Jones, altro importante musicista folk inglese col quale ha inciso diversi dischi, due anche di recente.
Hill Of Beans (che si può tradurre come montagna di fagioli, ma non ne ho mai viste, oppure come un fico secco o cosa di poco conto) è il primo album di canzoni originali di McTell dal 2010, anno in cui uscì Somewhere Down To Road, e come detto riunisce Ralph con il suo vecchio amico Tony Visconti, che già gli produsse Not Till Tomorrow del 1972: per l’occasione Visconti si porta dietro anche la ex moglie Mary Hopkin e la figlia Jessica Lee Morgan, oltre al grande contrabbassista Danny Thompson. Il CD contiene 11 canzoni, per la maggior parte scritte negli ultimi anni, ma anche una composta nel 1978 e una nel 1988, esce per la sua etichetta personale la Leola Music, e come è consuetudine dei dischi di McTell tratta dei temi più disparati, a conferma dello stile eclettico, ricco di spunti letterari, artistici e anche musicali, delle sue canzoni: la voce, nonostante lo scorrere del tempo, è ancora profonda e risonante, immediatamente riconoscibile, come certifica subito la bella Oxbow Lakes, una canzone dove le questioni amorose si intrecciano con metafore geografiche e il fingerpickinng di Ralph si immette su un arrangiamento semplice ma amabile realizzato da Visconti, che suona anche il recorder nel brano https://www.youtube.com/watch?v=FGti92mx2qs , Brighton Belle per certi versi è una affettuosa storia della propria famiglia durante la II guerra mondiale, raccontata attraverso un brano che ha l’afflato e la profondità delle più belle canzoni di Christy Moore, con il quale il nostro ha più di una affinità sia a livello di timbro vocale che per la facilità con cui sa costruire belle melodie di grande fascino, in questo caso solo con l’acustica di McTell e il contrabbasso di Thompson a scandirne i tempi.
Clear Water era già apparsa su Myths And Heroes il disco del 2015 dei Fairport Convention, qui in una versione più intima e raccolta, anche se gli archi e il coro celestiale aggiunti da Visconti gli conferiscono un livello quasi spirituale non lontano dai fasti del passato, Gertrude And Alice, è un accorato racconto che narra dell’amore tra Alice Toklas e Gertrude Stein nella Parigi degli anni ’20, attraverso un arrangiamento incentrato sul raffinato uso di fisarmonica, cello ed archi. Gammel Dansk ha una atmosfera tra cabaret mitteleuropeo, chansonnier francesi e tocchi klezmer, cantata quasi alla Leonard Cohen, molto bella, Shed Of Song è uno dei brani dalla melodia più “splendente”, tra cello, archi, piano e il solito recorder, suono molto avvolgente e classico. Close Shave è uno dei brani più tradizionali, tra blues e ragtime acustico, mentre When They Were Young, una canzone sui fremiti del primo amore, evidenzia ancora una volta l’uso della fisarmonica e degli archi, con una melodia incantevole e Sometimes I Wish I Could Pray, a tempo di valzer, è quasi una country song con uso di organo e steel guitar, ma con un coro gospel aggiunto, con la Hopkin e la figlia, https://www.youtube.com/watch?v=urdpp0_ViBo . In chiusura Hill Of Beans che prende in prestito le atmosfere romantiche del film Casablanca, incrociate con le esperienze parigine giovanili di McTell come busker, con tanto di citazione testuale finale “You played it for her, play it for me. Play it. Play it Sam.”. E per non farsi mancare nulla c’è anche un sentito omaggio finale al giovane Bob Dylan, quello dell’amore per Suze Rotolo, tra sbuffi di armonica e chitarra arpeggiata, West 4th Street And Jones registrata dal vivo, è un delizioso tuffo nel passato, che mette il sigillo ad un album sorprendentemente bello https://www.youtube.com/watch?v=C88NrWUENoE .
Bruno Conti