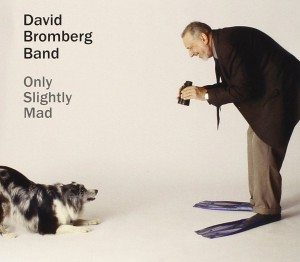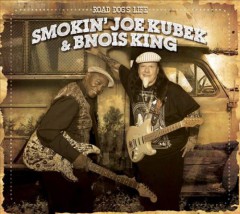David Bromberg Band – Only Slightly Mad – Appleseed/Ird CD
(NDM: nel pubblicare qualche giorno fa la mia scelta dei migliori del 2013, Bruno mi ha fatto notare che un paio di dischi molto importanti dell’elenco non erano stati recensiti sul blog al momento dell’uscita, e quindi, come si faceva a scuola con le materie insufficienti, abbiamo concordato di recuperare, prima della fine dell’anno, questi arretrati. Oggi mi dedico all’ultimo, bellissimo, album della David Bromberg Band, mentre nei prossimi giorni parlerò di Jonathan Wilson, per me disco dell’anno, ed anche dell’ultimo di Mavis Staples, primo degli “esclusi”, e di una new entry fuori tempo massimo, cioè del CD del duo Norah Jones/Billy Joe Armstrong.
Ma adesso sotto con Bromberg.)
Un po’ come con Ry Cooder, negli anni novanta e nei primi anni duemila avevo ormai perso le speranze che David Bromberg tornasse a fare dischi come negli anni settanta, ma se il musicista californiano ogni tanto la sua chitarra sui lavori di qualcuno la faceva sentire, oltre a legare il suo nome a tutta una serie di progetti collaterali (tipo il mitico Buena Vista Social Club, il disco con Ali Farka Touré o, nel 1992, l’album con John Hiatt, Nick Lowe e Jim Keltner a nome Little Village), di Bromberg pensavo si fossero perse le tracce dal 1989 (anno dell’ottimo Sideman Serenade). Il nostro infatti si era ritirato a Wilmington, nel Delaware, ad esercitare la professione di liutaio, e solo occasionalmente si ritrovava con qualche amico per deliziare pochi fortunati fans con rari concerti http://www.youtube.com/watch?v=bItEpUE9XdE
Poi, quasi in sordina, nel 2007 (quindi due anni dopo il “ritorno” di Cooder con Chavez Ravine), David pubblicò Try Me One More Time, un album completamente acustico di vecchi traditionals folk e blues (ed un brano nuovo), che però sembrava più un esercizio isolato, quasi un regalo ai propri estimatori, piuttosto che un ritorno vero e proprio. Due anni fa, invece, Bromberg fece il botto in grande stile con il sontuoso Use Me, un album stavolta elettrico con una serie di ospiti da fare invidia a chiunque (tra i tanti: John Hiatt, Los Lobos, Linda Ronstadt, Vince Gill, Levon Helm e Dr. John), un lavoro splendido che ci riconsegnava definitivamente uno dei migliori musicisti e musicologi contemporanei, tra l’altro in gran forma.
Ebbene, Only Slightly Mad, il nuovissimo CD di Bromberg, è persino meglio: intanto avrete notato come il nostro abbia aggiunto la parola Band al proprio nome, un chiaro aggancio al suo miglior periodo (gli anni settanta), ed infatti il disco può a mio parere stare tranquillamente allo stesso livello di capolavori come Demon In Disguise e Midnight On The Water, e solo un gradino sotto a Wanted Dead Or Alive, che per il sottoscritto è in assoluto il suo album migliore (ed uno dei più belli di tutta la decade). David riforma completamente la sua band (lo affiancano in questa fatica Mark Cosgrove, Nate Grower, Butch Amiot, John Kanusky, John Firmin e Peter Ecklund) e, con l’aiuto anche di qualche amico (tra cui John Sebastian, l’ex Nitty Gritty John McEuen, Amy Helm e la moglie Nancy Josephson), ci regala un disco proprio come negli anni settanta, una miscela di cover di brani altrui e vecchi traditionals, completati da tre brani nuovi.
La produzione è nelle sapienti mani di Larry Campbell (che aveva prodotto anche due brani su Use Me), ormai un esperto in questo tipo di sonorità, e l’album è una gioiosa miscela di blues, folk, country, rock e persino gospel (cosa non scontata per un ebreo), un mix perfetto che nelle mani di David e dei suoi compari fa di Only Slightly Mad uno dei più bei lavori dell’anno (con l’unico pollice verso per la ridicola copertina, abbastanza fuori contesto).
E poi suonano, cacchio se suonano!
Si inizia all’insegna del blues con la nota Nobody’s Fault But Mine http://www.youtube.com/watch?v=og49MxQbaRA di Blind Willie Johnson (ma resa celebre dai Led Zeppelin), che David personalizza con la sua particolare voce all’apparenza fragile ma capace di sfumature impreviste: una versione tosta, elettrica, chitarristica, con la slide di Bromberg e l’organo di Brian Mitchell a tirare le fila. E poi il suono, mai così pieno e rotondo in un disco del nostro: grande inizio. Ancora blues con Keep On Drinkin’ (Big Bill Broonzy), ma l’arrangiamento è più acustico http://www.youtube.com/watch?v=-dtRrrweeGQ , anche se la sezione ritmica pesta che è un piacere: grande duetto tra la slide acustica di David e l’armonica di Sebastian.
Drivin’ Wheel, il brano più famoso di David Wiffen, è il masterpiece del disco, una rilettura da urlo di una canzone già bellissima di suo, arrangiata in maniera classica, da rock ballad anni settanta, ma con gli strumenti che scorrono fluidi ed un suono spettacolare (Campbell ha fatto un lavoro egregio), oltre ad un feeling enorme, da brividi lungo la schiena. E poi David canta bene come non mai: forse la cover dell’anno!
I’ll Take You Back (un oscuro pezzo di Little Charlie & The Nightcats) è di nuovo blues, un blues elettrico afterhours, quasi jazzato, con splendidi interventi di organo e David che giganteggia per gli otto minuti di durata: che classe http://www.youtube.com/watch?v=dBc3ahM1cyM ! Con The Strongest Man Alive/Maydelle’s Reel/Jenny’s Chickens si cambia totalmente registro: è infatti un medley di tre diverse melodie tradizionali irlandesi, con David (e coro) che canta la prima parte a cappella, per poi lanciarsi insieme al gruppo in una jam irresistibile per chitarra, mandolino, violino e sezione ritmica, quasi fossero un combo di irlandesi purosangue: puro godimento. Last Date è una meravigliosa country ballad di Floyd Cramer e Conway Twitty (ricordo anche una bella versione di Emmylou Harris su un live dallo stesso titolo), e David risulta pienamente credibile anche nei panni del cowboy. Se facesse un intero disco country sarebbe sicuramente un capolavoro.
Nobody Knows The Way I Feel This Mornin’ (un brano inciso negli anni venti da Alberta Hunter, ma in seguito anche da Louis Armstrong, Dinah Washington ed Aretha Franklin) è l’ultimo tributo al blues del disco, acustica, cadenzata, piacevole e suonata in punta di dita, con i fiati sullo sfondo a dare al pezzo un sapore quasi dixieland. The Fields Have Turned Brown è un classico degli Stanley Brothers, un altro splendido country d’altri tempi, suonato alla grande e cantata anche meglio (ribadisco, non ho mai sentito Bromberg cantare bene come in questo disco). Cattle In The Cane/Forked Deer/Monroe’s Hornpipe è ancora un medley strumentale (due traditionals ed il terzo di Bill Monroe), dove il violino di Grower domina incontrastato, seguito a ruota da David e Cosgrove al mandolino: intrattenimento e cultura allo stesso tempo.
Chiudono l’album tre brani scritti da Bromberg, I’ll Rise Again, World Of Fools e You’ve Got To Mean It Too: se la seconda e la terza sono rispettivamente una rock song di buon livello (ma leggermente inferiore alla media del disco) ed un ottimo slow country romantico dedicato alla moglie Nancy, la prima è uno strepitoso gospel-rock che sembra quasi un brano tradizionale, proposto con una sicurezza ed un feeling tale che sembra che David non abbia mai fatto altro in carriera.
In definitiva, un album semplicemente imperdibile: dischi così fanno bene alla salute.
Marco Verdi