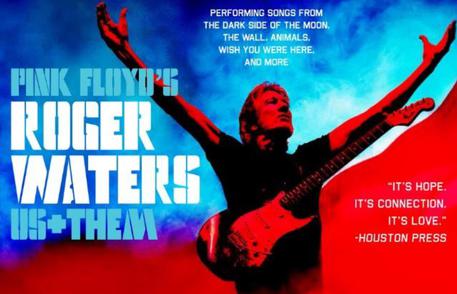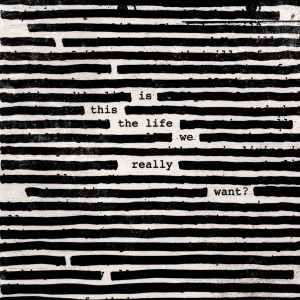Roger Waters – Us + Them – Columbia/Sony DVD – BluRay – 2CD
Di comune accordo con Bruno ho deciso di sorvolare sul nuovo album dal vivo dei Queen con Adam Lambert (una combinazione che può avere senso vedere di persona, più che altro per la storia personale di Brian May e Roger Taylor, ma che ascoltata su disco innesca un chiaro “effetto cover band”, nonostante il giovane Adam abbia comunque una gran voce), ma non potevo esimermi dal parlare di Us + Them, nuovo live di Roger Waters che, piaccia o no, è una delle figure di spicco e più carismatiche del panorama rock mondiale. Quarto disco dal vivo dell’ex leader dei Pink Floyd dopo i due The Wall (quello “collettivo” del 1990 a Berlino e quello più recente del 2015) ed il “greatest hits live” In The Flesh del 2000, Us + Them è in realtà la colonna sonora del film-concerto uscito nelle sale lo scorso anno (che non ho visto), nel quale le immagini registrate nel corso di quattro serate allo Ziggo Dome di Amsterdam (e pare anche in qualche imprecisata data inglese) durante il tour in supporto a Is This The Life We Really Want? vengono intervallate da interviste ed incontri con immigrati di varie etnie da parte dello stesso Waters, attento come sempre alle problematiche sociali.
A differenza di altre uscite, per esempio dei Rolling Stones, in cui sono disponibili i “bundle” CD/DVD o CD/BluRay, qui i due supporti video vengono venduti separatamente rispetto al doppio CD, e la cosa mi ha fatto optare per la sola parte audio dal momento che volevo evitare, come per esempio succedeva nel The Wall del 2015, di vedere un concerto interrotto più volte per sorbirmi le opinioni politiche di Waters che mi interessano il giusto (e che comunque non mancano neppure durante lo show): e poi, in ogni caso, avevo assistito nel 2018 alla prima delle due serate al Forum di Assago, quindi per questa volta ho preferito concentrarmi più sulla musica che sulle immagini. C’è da dire che il concerto è decisamente spettacolare dal punto di vista visivo, con i soliti giochi di luci, colori ed effetti speciali nonché le splendide immagini ad altissima definizione proiettate sul palco, ma non è che dal punto di vista musicale lo show sia inferiore, anzi: le canzoni che Waters ha reso celebri con i Floyd sono note a tutti, e qui non mancano di certo, ma quello che rende secondo me il doppio CD imperdibile è la qualità sonora incredibile, cosa non comune per un disco dal vivo, al punto che mi sorge qualche dubbio sul fatto che sia stato “aggiustato” in studio.
Non è neppure secondaria per la riuscita del lavoro la superband che accompagna il nostro (che tra parentesi è in buona forma vocale considerata l’età ed il fatto che non sia mai stato un grandissimo cantante), un gruppo guidato dal ben noto Jonathan Wilson alla chitarra e voce (sue le parti cantate originariamente di David Gilmour), gli altri due chitarristi Dave Kilminster e Gus Seyffert, i tastieristi Jon Carin (a lungo coi Floyd guidati proprio da Gilmour) e Bo Koster, il batterista Joey Waronker, il sassofonista Ian Ritchie ed il duo delle Lucius, ovvero Jess Wolfe e Holly Laessig, alle voci di supporto. Un live molto bello quindi (e non potrebbe essere altrimenti con certe canzoni) che, ripeto, ha un suono che raramente ho ascoltato in un album dal vivo. L’inizio è di esclusivo appannaggio di The Dark Side Of The Moon, con l’introduttivo battito cardiaco di Speak To Me seguito da Breathe, Time (con un duetto Wilson-Waters), la ripresa di Breathe e The Great Gig In The Sky (quest’ultima con le due Lucius protagoniste), una sequenza interrotta solo dalla sempre trascinante ed applauditissima One Of These Days, già sentita recentemente sul live di Nick Mason (ed il match si chiude in parità). Una splendida Welcome To The Machine, brano che ascolto sempre con grande piacere, precede un trittico di pezzi dall’ultimo studio album del nostro, e cioè la bellissima ed emozionante Déjà Vu, una ballatona che è puro Waters, la drammatica The Last Refugee e la tesa ed affilatissima Picture That.
Il primo CD si chiude con la sempre toccante Wish You Were Here, suonata da Dio e particolarmente suggestiva, e l’unico e forse un po’ scontato omaggio a The Wall con The Happiest Days Of Our Lives seguita dalla seconda e terza parte di Another Brick In The Wall. La seconda parte dello show è la più spettacolare dal punto di vista visivo, dal momento che la famosa Battersea Power Station raffigurata sulla copertina di Animals viene ricreata on stage (e presto raggiunta anche dal mitico maiale volante), ma anche la parte musicale non scherza con un uno-due tra Dogs e Pigs (Three Different Ones) davvero strepitoso, che rappresenta forse il punto più alto del concerto. Il finale è ancora riservato allo storico disco con in copertina il prisma ottico con Money, Us & Them, Brain Damage ed Eclipse suonate una dietro l’altra, mentre come aggiunta speciale sul doppio CD abbiamo due tracce esclusive registrate in studio, cioè una breve ripresa strumentale di The Last Refugee ed una cantata della sempre splendida Déjà Vu, ma con due versi inediti non presenti su Is This The Life We Really Want?
Interessante, ma forse avrei preferito l’inserimento di Mother e Comfortably Numb, spesso suonate come bis (la seconda è però presente come bonus nel DVD e BluRay, insieme a Smell The Roses). Considerando l’età di Roger Waters e soprattutto la sua “pigrizia”, questo Us + Them potrebbe anche essere la sua ultima testimonianza dal vivo: un motivo in più per non lasciarsela sfuggire.
Marco Verdi