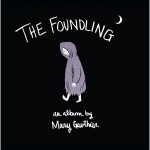Kacy & Clayton Marlon Williams – Plastic Bouquet – New West Records
Kacy & Clayton, spesso pronunciati come una unica entità, sono in effetti una coppia di cugini canadesi, originari del Saskatchewan, che agiscono come duo sin dal 2011, all’inizio a livello indipendente, poi sono stati notati dalla New West che li ha messi sotto contratto, e anche da Jeff Tweedy , che ha prodotto i due album del 2017 e 2019, The Siren’s Song e Carrying On, entrambi premiati da ottimi riscontri della critica. Per completare, Kacy (Lee) Anderson è la vocalist ed autrice delle canzoni, mentre Clayton Linthicum è il chitarrista e strumentista tuttofare (che fa parte anche del giro degli ottimi Deep Dark Woods) che è il tessitore delle rarefatte ma raffinate costruzioni sonore del duo, che comunque ha anche una sezione ritmica fissa costituita da Mike Silverman alla batteria e Andy Beisel al basso, presente negli ultimi due album, mentre nel nuovo Plastic Bouquet si è aggiunto anche Dave Khan al violino.
Ma la novità più importante, al di là della fine della collaborazione con Tweedy, è l’imprevisto arrivo di Marlon Williams, cantautore neozelandese autore di uno splendido omonimo album di debutto nel 2016 (ma già nel 2015 Down Under), poi non del tutto confermato con il pur eccellente successivo Make Way For Love del 2018, che qualcuno aveva trovato troppo ridondante: il “problema”, se così lo vogliamo chiamare, sta nelle voce, ora eterea ora possente di Marlon, che è stata paragonata di volta in volta a Nick Cave ed Elvis, Johnny Cash e Roy Orbison ( e pure l’epigono Chris Isaak) , creando grandi aspettative per questa sorta di crooner folk. L’unione delle forze del trio, in questo album registrato e concepito tra Canada, Nuova Zelanda e Nashville, magari non sempre funziona del tutto, ma confrontato con le uscite di molti nuovi “fenomeni” della canzone, spesso presentati come dei Messia, è comunque sempre un bel sentire: undici canzoni originali, a firma Anderson e Williams, che producono anche il disco, a cavallo tra languori folk-country-rock dai sapori canadesi di Kacy e Clayton e la vocalità esuberante di Marlon https://www.youtube.com/watch?v=BgHpTL5Gx3k .
Quando i due mondi si intrecciano però scatta la magia: come nel primo singolo I Wonder Why , dove tra eteree slide e atmosfere sognanti i due gorgheggiano, come novelli Gram ed Emmylou https://www.youtube.com/watch?v=gp9s-2QjRWI , oppure come nel delizioso honky tonk con pedal steel d’ordinanza e violino in sottofondo di Old Fashioned Man, cantata da Kacy Lee con Williams che novello Elvis, canta il secondo verso https://www.youtube.com/watch?v=pAbxAVTnJ0A . I’m Gonna Break It è pura country music, di quella sublime, con i due che si alternano alla guida e poi armonizzano dolcemente, delicata anche la languida Last Burning Ember affidata alla Clayton, sempre con il supporto di Marlon, più in territori folk-roots, ma sempre con richiami a certo country cosmico. Light Of Love sembra uno di quei vecchi duetti alla Nancy Sinatra/Lee Hazlewood, con lui più celestiale Orbison o Buckley che austero Lee https://www.youtube.com/watch?v=cYjk3Bb2f00 , mentre Arahura, dal nome di uno sconosciuto (ma non a lui evidentemente) fiume della Nuova Zelanda, evidenzia la perfetta intesa tra la voce fragile ma assertiva e gorgheggiante di Kacy che si appoggia su quella maschia di Williams https://www.youtube.com/watch?v=UZZya84eusU , e ottimo anche il simil bluegrass della ondeggiante title track, dove è sempre la voce femminile a guidare le danze.
Sarà pur sempre musica magari poco innovativa, ma quando è eseguita con passione come in questo album, non si può fare a meno di apprezzarla e fregarsene dei giudizi: interessante anche I’m Unfamiliar con un organetto vintage in evidenza, dove magari si sarebbe apprezzato maggiormente il timbro di Margo Timmins rispetto alla Anderson, ma non si può avere tutto https://www.youtube.com/watch?v=SCbDcNeT_tM . In chiusura Devil’s Daughter, che nonostante il titolo è più angelica che diabolica https://www.youtube.com/watch?v=Au43In2Yklw , un sommesso duetto sulle ali di due chitarre acustiche che conferma la validità di un disco che magari non entusiasma ma ti conquista lentamente.
Bruno Conti