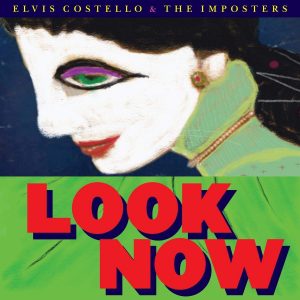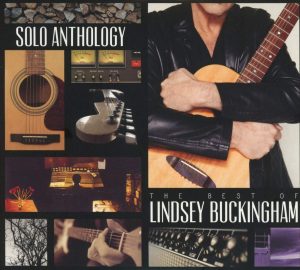Bruce Springsteen – Western Stars – Columbia/Sony CD
Raramente, almeno negli ultimi tempi, un album è stato dissezionato, criticato, esaltato o stroncato ben prima della sua uscita come Western Stars, nuovissimo lavoro di Bruce Springsteen. C’è da dire che la maggior parte dei commenti sono stati positivi, ma non sono state comunque risparmiate dure critiche, soprattutto per la veste pop delle canzoni, un suono giudicato da alcuni troppo gonfio ed appesantito da arrangiamenti orchestrali, e più in generale per il fatto che, in pratica, Bruce in questo disco “non fa Bruce” (ma che vuol dire? Allora anche The Seeger Sessions, un capolavoro, andrebbe ridiscusso…e poi per avere il classico Springsteen basta aspettare l’anno prossimo, dato che il rocker di Freehold ha già annunciato che pubblicherà un album con la E Street Band). Tra l’altro è stato Bruce stesso in un certo senso ad annunciare il cambiamento di Western Stars, affermando in sede di presentazione che aveva voluto fare un disco ispirato alla musica pop californiana a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, citando artisti come Glen Campbell e Burt Bacharach (ed io aggiungerei anche Jimmy Webb, Harry Nilsson e John Denver, anche se nessuno dei cinque è/era originario del Golden State), un tipo di influenza che nessuno pensava che il Boss avesse ma che è indubbiamente reale visto l’esito finale dell’album.
Sì, perché Western Stars a mio parere è un disco bello, in parecchi punti molto bello, e ci fa ritrovare un Bruce di nuovo in forma smagliante come autore di canzoni e come musicista in generale dopo qualche lavoro tentennante (come il raffazzonato High Hopes ed il deludente Working On A Dream). Certo, i brani sono più tendenti al pop che al rock, ma è un pop sontuoso ed arrangiato alla grande, con la produzione di Ron Aniello che evoca praterie sconfinate ed i paesaggi a cielo aperto che sono raffigurati nelle splendide foto di copertina e del booklet interno. Una musica decisamente cinematografica, con canzoni a tema western per quanto riguarda i testi ma meno per le musiche, che restano come dicevo ancorate allo stile pop che il nostro annunciava presentando il disco; i tanto vituperati arrangiamenti orchestrali sono quindi parte integrante di questo tipo di musica, ed a mio parere non sono affatto pesanti o fuori posto, ma anzi contribuiscono ad aumentare il pathos in parecchie canzoni, canzoni che il Boss esegue in maniera convinta e convincente (è chiaro e lampante che le “sente” particolarmente), usando in alcune di esse un range vocale decisamente melodico ed abbastanza inedito.
Bruce ed Aniello si occupano della maggior parte degli strumenti (chitarre, banjo, basso ed una lunga serie di tastiere come piano, celeste, mellotron ed organo e percussioni varie tra cui vibrafono e glockenspiel), e sono coadiuvati dalla moglie del Boss, Patti Scialfa, ai backing vocals insieme ad altri coristi (tra i quali “Sister” Soozie Tyrell), dall’altro E Streeter Charlie Giordano al piano e fisarmonica, dai batteristi Gunnar Olsen e Matt Chamberlain, da ben tre steel guitarists (Greg Leisz, Marty Rifkin e Marc Muller), dal noto percussionista Lenny Castro e addirittura dal pianista delle origini della E Street Band David Sancious. Oltre naturalmente alle già citate sezioni di archi e strumenti a fiato. La prima canzone, Hitch Hikin’, ha un inizio abbastanza tipico, con Bruce che canta in maniera distesa una melodia limpida, circondato da strumenti a corda: dopo circa un minuto entra l’orchestra ma con discrezione ed anzi aumentando la tensione emotiva: il brano si sviluppa tutto sulla stessa tonalità ed è tutt’altro che monotono, ma è al contrario dotato di un crescendo degno di nota. The Wayfarer è costruita un po’ sulla stessa falsariga, ma ha più soluzioni melodiche e ad un certo punto la strumentazione si arricchisce ed entra la sezione ritmica, con gli archi e i fiati che diventano protagonisti: pop di alta classe. Tucson Train vede in un certo senso il Boss che conosciamo, il brano è più rock, ci sono anche le chitarre elettriche ed il mood è trascinante: c’è l’orchestra anche qui, ma io non vedo male questo brano anche in ottica E Street Band, potrebbe diventare un classico delle future esibizioni dal vivo. Anche la title track è una ballata tipica del nostro, con atmosfere western (titolo a parte), una bella steel sullo sfondo e quell’atmosfera da colonna sonora cinematografica che Bruce aveva in mente; Sleepy Joe’s Café è solare e contraddistinta da una ritmica pimpante, con un motivo delizioso, orecchiabile e coinvolgente (e sentori di Messico), in pratica una delle più immediate del CD.
La tenue Drive Fast (The Stuntman) iniza per voce, piano e chitarra (ed orchestra, anche se più nelle retrovie), poi entrano gli altri strumenti ma il mood resta intimo e rilassato, Chasin’ Wild Horses è una slow ballad intensa e con accompagnamento scarno ma di grande impatto, con una splendida steel, un banjo ed il solito emozionante assolo orchestrale: molto bella anche questa. Sundown è stupenda, una pop song extralusso dotata di un eccellente ed arioso arrangiamento che evoca spazi aperti e cavalcate nelle praterie, uno dei pezzi in cui l’interazione tra il Boss, il gruppo e l’orchestra funziona meglio. Splendida anche Somewhere North Of Nashville, un toccante lento dalla melodia straordinaria ed accompagnato solo da chitarra, piano e steel, un pezzo breve ma con il dna dei classici springsteeniani; Stones è una rock ballad fluida e limpida dalla strumentazione ricca e coinvolgente, altra canzone che Bruce riprenderà sicuramente dal vivo in futuro, mentre There Goes My Miracle è una pop song grandiosa nell’arrangiamento e raffinata nell’interpretazione, con un’ottima prestazione vocale: se il Boss voleva evocare certa musica dei primi anni settanta, qui ci è riuscito alla perfezione. L’album volge al termine con Hello Sunshine (il primo singolo, gira già da alcuni mesi), una ballatona tra cantautorato e pop che richiama vagamente Everybody’s Talkin’, e con Moonlight Motel, un bozzetto acustico ideale per congedarci da un disco a mio parere quasi perfetto, specialmente se rapportato alle intenzioni originali del suo autore.
D’altronde se ad ascolto ultimato ho già voglia di rimetterlo da capo vorrà pur dire qualcosa.
Marco Verdi