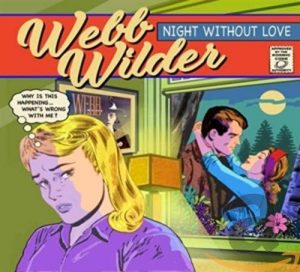Webb Wilder – Night Without Love – Landslide CD
L’ultima volta che mi sono occupato di Webb Wilder (che a dirla tutta era anche la prima) è stato quando due anni fa ho recensito il divertentissimo Powerful Stuff, che non era un album nuovo ma una collezione di outtakes registrate tra il 1985 ed il 1993 https://discoclub.myblog.it/2018/06/08/unora-di-divertimento-assicurato-webb-wilder-the-beatnecks-powerful-stuff/ . Oggi però Wilder torna davvero tra noi a cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro (Mississippi Moderne) con questo Night Without Love, che fin dal primo ascolto si afferma come uno dei dischi più godibili ed “entertaining” (termine inglese intraducibile – intrattenevole? – ma che rende benissimo l’idea) del 2020. Se non avete mai sentito nominare Wilder non preoccupatevi, in quanto è uno dei tanti “signor nessuno” del mondo della musica mondiale: esordiente nel 1986 con l’album It Came From Nashville, Webb ha sempre tirato dritto infischiandosene del fatto che i suoi lavori non vendevano una cippa, proponendo la sua miscela spesso irresistibile di rock’n’roll, country, boogie e power pop al fulmicotone, che lo faceva sembrare una via di mezzo tra Commander Cody ed i Blasters.
Night Without Love dovrebbe essere il decimo album di Wilder, e posso affermare senza tema di smentita che è uno dei suoi migliori di sempre, undici canzoni divise tra cover e brani originali che ci fanno ritrovare un rocker che ha sempre fatto musica “just for fun”, riuscendoci peraltro perfettamente. Il disco (la cui copertina è disegnata da James Flournoy Holmes, l’uomo dietro alle copertine di Eat A Peach degli Allman, Fire On The Mountain della Charlie Daniels Band e In The Right Place di Dr. John) vede Webb accompagnato dal suo abituale collaboratore George Bradfute, che suona qualsiasi tipo di strumento oltre a produrre il lavoro, ma anche da Rick Schell alla batteria, Bob Williams alla steel ed il noto chitarrista Richard Bennett in un brano. Trentasette minuti di musica, non un secondo da buttare. Si parte alla grande con Tell Me What’s Wrong, trascinante rock’n’roll dalla ritmica potente cantato dal nostro con una voce alla Johnny Cash, per proseguire sullo stesso livello con la title track (scritta da R.S. Field, produttore dei primi album del nostro), energica ballata sfiorata dal country con un mood anni sessanta e tanta grinta, e con il rockin’ country a tutto ritmo e chitarre Hit The Nail On The Head, vigorosa cover di un pezzo dei quasi dimenticati Amazing Rhythm Aces.
Holdin’ On To Myself, scritta da Chip Taylor, è uno scintillante honky-tonk dominato dalla steel, ma il capolavoro del disco secondo me arriva con il brano seguente: per il sottoscritto Be Still era già nella sua versione originale uno dei migliori brani dei Los Lobos (lo trovate su The Neighborhood, 1990), ma questa rilettura di Webb è strepitosa, in quanto fa ancora di più uscire la splendida melodia non cancellando le radici messicane ma aggiungendo una patina malinconica da vero balladeer. In poche parole, una goduria. A questo punto abbiamo cinque canzoni consecutive scritte da Wilder da solo o in compagnia: la deliziosa e coinvolgente rock song “californiana” Illusion Of You, con uno stile che ricorda parecchio gli Heartbreakers di Tom Petty, la splendida Buried Our Love, country-rock bello come se ne sentono pochi, la squisita Sweetheart Deal, ballata guidata dall’organo con un sapore blue-eyed soul e scritta nientemeno che con Dan Penn, la contagiosa Ache And Flake, tra rock’n’roll e power pop con un refrain vincente, e la fluida folk-rock ballad The Big Deal. Chiusura con una travolgente rilettura del classico jump blues di Tommy Tucker (ma inciso tra gli altri anche da Elvis e Chuck Berry) Hi Heel Sneakers, nobilitata da un farfisa dal suono decisamente vintage ed un approccio che ricorda quello dei già citati Blasters.
Se dovessi fare una scommessa, forse Night Without Love non entrerà nella Top Ten dei migliori album del 2020, ma sono quasi certo che sarà uno dei CD che ascolterò di più.
Marco Verdi