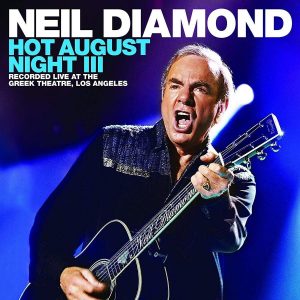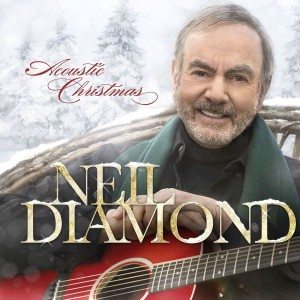Tom Petty – Wildflowers & All The Rest – Warner 2CD – 3LP – 4CD Deluxe – 7LP – 5CD Super Deluxe – 9LP
Sia prima che dopo la sua improvvisa e dolorosa scomparsa avvenuta il 2 ottobre 2017, quando si è trattato di dedicare un cofanetto alla musica di Tom Petty è sempre stato fatto un lavoro eccellente, a partire dal box set antologico Playback del 1995 (tre CD di greatest hits, uno di rarità e b-sides e due di inediti), passando per la spettacolare Live Anthology del 2009, cinque CD dal vivo completamente unreleased, per finire con il bellissimo An American Treasure del 2018, box quadruplo che, vicino a qualche pezzo già conosciuto, presentava diverse canzoni mai sentite prima, oppure altre note ma in versioni alternate https://discoclub.myblog.it/2018/10/14/recensioni-cofanetti-autunno-inverno-2-un-box-strepitoso-che-dona-gioia-e-tristezza-nello-stesso-tempo-tom-petty-an-american-treasure/ . Da qualche anno si parlava della possibile ristampa di Wildflowers, album del 1994 del biondo rocker della Florida giustamente considerato uno dei suoi più belli (è nella mia Top 3 dopo Full Moon Fever e Damn The Torpedos), ristampa che inizialmente sembrava dover ricalcare la sequenza pensata in origine, con diversi brani scartati che nelle intenzioni di Tom avrebbero dovuto formare un album doppio.
Quest’anno si è finalmente deciso di rendere pubblico il tutto con l’uscita di Wildflowers & All The Rest, ma oltre alla versione con due dischetti (o tre LP) si è scelto di fare le cose in grande ed allargare il progetto ad un box quadruplo (o con sette vinili) e, se volete spendere parecchio di più, solo sul sito di Tom è disponibile una splendida edizione Super Deluxe quintupla, o con nove LP, che è quella di cui vado a parlare tra poco (in realtà c’è anche una edizione “Ultra Deluxe” che costa 500 dollari ma non offre nulla di aggiuntivo dal punto di vista sonoro, ma solo una confezione più elegante ed una serie di gadgets abbastanza inutili). La confezione del box quintuplo è splendida, con all’interno la riproduzione dei testi originali con la calligrafia di Tom, un certificato di autenticità numerato e soprattutto un bellissimo libro con copertina dura che vede all’interno parecchie foto inedite, un saggio del “solito” David Fricke, i testi di tutte le canzoni (anche quelle inedite), tutte le indicazioni su chi ha suonato cosa e, dulcis in fundo, un esauriente commento track-by-track con le testimonianze dei protagonisti, tra cui il produttore Rick Rubin, gli storici tecnici del suono di Tom Ryan Ulyate e Jim Scott ed alcuni dei musicisti coinvolti).
Wildflowers già al momento della sua uscita aveva colpito per la sua bellezza e per la profondità delle canzoni scritte da Tom, sia musicalmente che dal punto di vista dei testi, un album da vero e maturo songwriter rock che infatti era stato pubblicato come disco solista (il secondo dopo Full Moon Fever), dal momento che molte delle canzoni avevano uno stile che non veniva ritenuto adatto al sound prettamente rock degli Heartbreakers. Comunque i componenti del gruppo storico di Petty erano presenti al completo in session, soprattutto Mike Campbell e Benmont Tench che anche qui costituivano la spina dorsale del suono, mentre Howie Epstein non suonava il basso ma si limitava alle armonie vocali ed il batterista Steve Ferrone non era ancora entrato ufficialmente nella band ma lo avrebbe fatto subito dopo; tra gli altri musicisti presenti meritano una citazione il noto percussionista Lenny Castro, lo steel guitarist Marty Rifkin, Jim Horn al sax in un brano, il famoso arrangiatore Michael Kamen, responsabile delle orchestrazioni in una manciata di pezzi, e soprattutto Ringo Starr alla batteria ed il Beach Boy Carl Wilson alla voce in una canzone ciascuno.
Ma veniamo ad una disamina dettagliata del cofanetto, il cui ascolto si è rivelato un magnifico scrigno pieno di sorprese (ma non avevo dubbi in proposito). Il primo CD è il Wildflowers originale, un disco ancora oggi bellissimo ed attuale, pieno di deliziosi esempi di cantautorato maturo ed intimo come la splendida title track, il country-rock crepuscolare di Time To Move On, il puro folk-blues Don’t Fade On Me, una voce e due chitarre acustiche, la limpida e folkeggiante To Find A Friend e la ballata pianistica Wake Up Time. Ma la presenza degli Heartbreakers fa sì che il vecchio suono non sia certo messo in soffitta: così abbiamo il potente rock’n’roll di You Wreck Me, la bluesata ed elettrica Honey Bee, la creedenciana e “swampy” Cabin Down Below ed il notevole rock-blues quasi psichedelico House In The Woods, pieno di accordi discendenti; non mancano neppure i tipici pezzi midtempo del nostro, come la popolare You Don’t Know How It Feels, pare ispirata a The Joker della Steve Miller Band, la straordinaria It’s Good To Be King, che dal vivo diventerà uno dei momenti salienti dello show, e la younghiana Hard On Me. Infine troviamo dell’ottimo folk-rock d’autore come la cristallina Only A Broken Heart, con il suo feeling alla George Harrison, la sixties-oriented A Higher Place e l’elegante Crawling Back To You.
Come ho accennato poc’anzi, il secondo dischetto presenta dieci brani esclusi dalla tracklist del 1994 (a parte Girl On LSD che era uscita come lato B di un singolo, e che qui ritroviamo nel quinto CD), quattro dei quali finiranno in versione diversa sulla colonna sonora di She’s The One nel 1996. Il bello è che non stiamo parlando di dieci pezzi di livello inferiore, ma di canzoni che avrebbero potuto benissimo uscire e fare la loro ottima figura, in alcuni casi elevando addirittura il livello già alto di Wildflowers. Something Could Happen è una suggestiva ballata elettroacustica leggermente tinta di pop, con una melodia di prima qualità ed un gran lavoro di Tench, un pezzo inciso nel 1993 ancora con Stan Lynch in formazione e che sarebbe potuto diventare un classico. Ancora più incomprensibile l’esclusione di Leave Viginia Alone, stupendo uptempo folk-rock dal mood coinvolgente ed un motivo irresistibile, una delle migliori canzoni scritte da Tom negli ultimi 25 anni: poteva essere uno dei pezzi centrali di Wildflowers (e verrà invece registrata da Rod Stewart nel 1995 e pubblicata su A Spanner In The Works).
Climb That Hill Blues vede il solo Petty alla voce e chitarra acustica, un brano bluesato come da titolo che ritroveremo tra poco in una versione diversa e full band, ma questa take “unplugged” è davvero affascinante; Confusion Wheel è una limpida ballata dal passo lento e con un bel crescendo, influenzata in parte dalle folk songs tradizionali britanniche ed in parte dai Byrds “acustici”, mentre per California vale quasi lo stesso discorso fatto per Leave Virginia Alone, in quanto ci troviamo di fronte ad una deliziosa e solare canzone pop-rock dal motivo accattivante, che fortunatamente è stata poi reincisa per She’s The One (ma qui è migliore). Harry Green vede ancora Petty da solo, ma se Climb That Hill era un blues, qui siamo dalle parti del più puro e cristallino folk di stampo tradizionale, a differenza di Hope You Never che è un incalzante ed intrigante rock song chitarristica dal passo cadenzato, con un organo molto sixties ed un suono potente: altro pezzo che poteva tranquillamente finire su Wildflowers.
Somewhere Under Heaven è una rock ballad classica, molto anni 70, con un retrogusto psichedelico e Campbell che suona tutti gli strumenti, brano che precede la versione elettrica di Climb That Hill, solida rock song contraddistinta da un riff insistente ed un drumming martellante; chiusura con Hung Up And Overdue, ballata eterea dal gusto pop simile a certe cose del “periodo Jeff Lynne” di Tom, ancora con il pianoforte protagonista e la presenza simultanea di Ringo e Carl Wilson. Molto interessante il terzo CD, che si occupa degli “home recordings” precedenti alle sessions dell’album, registrati da Tom nel suo studio casalingo: non ci troviamo però davanti ai soliti demo per voce e chitarra acustica (e qualche volta armonica), ma a vere e proprie canzoni quasi complete, con sovraincisioni di chitarra elettrica, basso, piano, organo e percussioni. Ci sono anche tre inediti assoluti: There Goes Angela (Dream Away), una soave e delicata ballata impreziosita da una squisita melodia, A Feeling Of Peace, che se sviluppata maggiormente avrebbe potuto diventare una rock ballad di spessore (e parte delle liriche verranno utilizzate su It’s Good To Be King), e There’s A Break In The Rain, uno slow lento ed intenso che rispunterà con qualche modifica su The Last DJ con il titolo Have Love, Will Travel.
Le altre canzoni, alcune delle quali con qualche differenza testuale e strumentale, sono già bellissime così, in particolare You Don’t Know How It Feels, California, Leave Virginia Alone, Crawling Back To You, A Higher Place, To Find A Friend, Only A Broken Heart e Wildflowers. Quindi non la solita collezione di demo, magari un po’ noiosa, ma un disco che sta in piedi con le sue gambe. Il quarto dischetto è una delle ragioni per cui questo box era da me tanto atteso, dato che presenta 11 dei 15 brani di Wildflowers (più tre “aggiunte”) in versioni inedite dal vivo registrate da Tom ed i suoi Spezzacuori tra il 1995 ed il 2017, un CD strepitoso dal momento che stiamo parlando di una delle migliori rock’n’roll band di sempre, in grado di fornire la rilettura definitiva di qualsiasi brano suonato live (e se, per fare un esempio, nel 2003 con Live At The Olympic i nostri erano riusciti a trasformare un album deludente come The Last DJ in un disco da quattro stelle vi lascio immaginare cosa potessero fare con un lavoro del calibro di Wildflowers).
Tanto per cominciare abbiamo una monumentale It’s Good To Be King che da sola vale il CD, undici minuti di rock sublime con una prestazione monstre da parte di Campbell ed un crescendo irresistibile a cui partecipa attivamente anche Tench. Poi vanno segnalate una strepitosa You Don’t Know How It Feels, con Petty che arringa la folla da consumato showman, un trio di rock’n’roll songs formato da Honey Bee, Cabin Down Below e You Wreck Me, che dal vivo sono letteralmente esplosive, una limpida e countreggiante To Find A Friend acustica eseguita allo School Bridge Benefit di Neil Young nel 2000, la sempre bella Crawling Back To You, registrata a fine luglio 2017 (e quindi una delle ultime testimonianze dal vivo di Tom), puro vintage Heartbreakers, una versione molto più rock e diretta di House In The Woods ed una decisamente intima di Time To Move On, per chiudere con la sempre magnifica Wildflowers, qui in versione full band comprensiva di sezione ritmica.
Dicevo dei tre pezzi non appartenenti al disco originale, che iniziano con una deliziosa rilettura stripped-down di Walls (singolo portante di She’s The One), la vigorosa jam chitarristica Drivin’ Down To Georgia, brano che i nostri suonavano dal vivo già dal 1992 (ma questa è del 2010) e che abbiamo già sentito in un’altra versione su The Live Anthology, per chiudere con una rara Girl On LSD, un pezzo folle e divertente, musicalmente molto Johnny Cash, con Tom che mentre la canta fa fatica a rimanere serio. E veniamo al quinto dischetto, quello esclusivo dell’edizione Super Deluxe: sottointitolato Finding Wildflowers, presenta sedici versioni alternate prese dalle sessions dell’album, alcune simili ai brani ufficiali ed altre abbastanza diverse. Non tutto è inedito, ma piuttosto raro sì: ci sono due takes differenti di Don’t Fade On Me e Wake Up Time già pubblicate su An American Treasure, una rilettura semi-acustica di Cabin Down Below ed una versione alternativa di Only A Broken Heart (molto Jeff Lynne) uscite su B-sides, e poi la Girl On LSD originale, sempre spassosa e dall’arrangiamento più rockabilly di quella live.
Troviamo poi finalmente una studio version di Drivin’ Down To Georgia (che però funziona meglio dal vivo) e, tra le altre, segnalerei una A Higher Place più elettrica e Heartbreaker-sounding (con Kenny Aronoff alla batteria), Hard On Me leggermente più lenta dell’originale e con Campbell alla slide, a differenza di Crawling Back To You che è molto più veloce e ritmata di quella nota (e non so quale delle due preferire), You Wreck Me sempre energica ma con le chitarre acustiche, House In The Woods con un’inedita parte strumentale centrale dal sapore jazz, ed una Wildflowers delicatamente country, ancora con Ringo ai tamburi. Anche qui c’è spazio per un inedito assoluto intitolato You Saw Me Comin’, pop song gradevole dal ritmo incalzante, un brano abbastanza sconosciuto che mette la parola fine ad un cofanetto che definire splendido è poco, e che si batterà certamente per il titolo di ristampa dell’anno.
Tom Petty ci manca maledettamente, ogni anno di più.
Marco Verdi