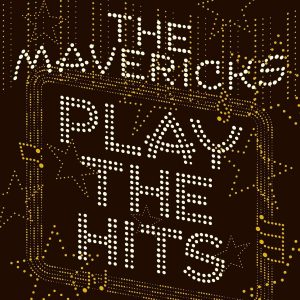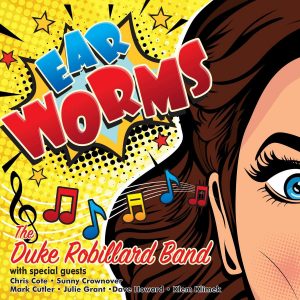Mike Zito & Friends – Rock ‘n’ Roll – A Tribute To Chuck Berry – Ruf Records
Per motivi assolutamente ignoti ed incomprensibili, visto che non ricorre nessuna particolare evenienza o anniversario, a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro, sono usciti ben due Tributi a Chuck Berry. Uno, Mad Lad, è l ‘ottimo concerto dal vivo di Ronnie Wood con la sua band i Wild Five e la presenza di Imelda May https://discoclub.myblog.it/2019/12/08/se-elvis-era-il-re-del-rocknroll-chuck-era-il-rocknroll-un-sentito-omaggio-da-uno-stone-in-libera-uscita-ronnie-wood-his-wild-five-mad-lad-a-l/ , l’altro, a mio parere veramente strepitoso, è questo Rock ‘n’ Roll – A Tribute To Chuck Berry, dove il texano adottivo Mike Zito ha radunato una pattuglia veramente cospicua, eterogenea, ma vicina alla perfezione nelle scelte, di 21 chitarristi, per reinterpretare 20 classici del musicista di St. Louis (come Zito peraltro, anche lui nativo come Berry della città del Missouri). I risultati, oltre che godibilissimi, sono decisamente coinvolgenti: aiuta sicuramente che le canzoni su cui lavorare siano tra i capisaldi del R&R e del rock tout court, una lunga serie di capolavori assoluti (forse con l’eccezione dell’ultima canzone e di un’altra non celeberrima), ma la passione, il brio, l’impegno con cui sono stati realizzati ,ne fanno un album speciale.
Registrate le basi ai Marz Studios di proprietà di Zito, situati a Nederland (?!?) la piccola cittadina del Texas dove ora vive Mike, con l’aiuto dell’ingegnere del suono David Farrell, ha poi provveduto ad inoltrarli ai 21 chitarristi (e cantanti), dicasi ventuno, che hanno provveduto ad aggiungere le proprie parti (come si usa quando non ci sono i soldi per trovarsi tutti insieme a registrare nella stessa sala) e rispedirle a Zito, che ha poi proceduto ad assemblarle, con le basi fornite da Terry Dry al basso, Matthew Johnson alla batteria e Lewis Stephens a piano, organo e Wurlitzer (perché non si può prescindere dal contributo che il piano di Johnnie Johnson diede alla riuscita delle canzoni di Chuck), nonché l’uso saltuario dei fiati, ed il risultato finale è quello che ora vi descrivo. E’ quasi inevitabile che ad aprire le danze (è il caso di dirlo) sia il nipote di Berry, Chuck III detto Charlie, che dà una mano anche a livello vocale a Zito (che si disimpegna da par suo in tutto l’album), sembra di ascoltare gli Stones dei primi anni ’70 (ops) in questa pimpante St. Louis Blues, tutta riff ed assoli e ci mancherebbe; in Rock And Roll Music, una delle più divertenti del canone di Chuck, Joanna Connor aggiunge la sua slide, mentre i fiati pompano alla grande, versione caldissima.
E Johnny B. Goode? Una vera bomba, con Walter Trout che abbandona il suo amato blues per darci dentro alla grande in una versione potentissima, con lui e Zito che si scambiano vagonate di colpi di chitarra, e duettano anche a livello vocale, mentre la ritmica picchia come se non ci fosse un futuro e il pianino titilla. Ma Chuck Berry amava anche il blues e la versione dello slow Wee Wee Hours, con Joe Bonamassa ingrifatissimo alla chitarra, con un assolo colossale e ripetuto, è da manuale delle 12 battute. Memphis, con Anders Osborne altra voce solista e impegnato alla slide, è una delle più fedeli all’originale, leggiadra e deliziosa; Ryan Perry non è uno dei più conosciuti tra i presenti e quindi non è un caso che anche il brano scelto, una I Want To Be Your Driver composta a metà anni ’60, sia poco nota, ma la versione che ne viene fuori, grazie anche ad un inconsueto organo, sia a metà tra il garage rock e il Bob Seger più impetuoso, grazie anche alle similitudini tra la due voci, e Perry suona, cazzarola se suona. You Never Can Tell è un brano raffinato e cool di suo (qualcuno ha detto Pulp Fiction?) e quindi ideale per lo stile finissimo di Robben Ford, mentre in Back In the Usa Eric Gales porta un impeto e un gusto hendrixiano, non dimenticando che Jimi amava la musica del colored di Saint Louis, con i fiati che tornano a farsi sentire.
Jeremiah Johnson, uno dei protetti di Zito, porta il suo approccio sudista ad una robusta versione di No Particular Place To Go, e in Too Much Monkey Business Luther Dickinson, uno dei pezzi da 90 di queste sessions, duetta sia alle voce che alle chitarre per una canzone tra le più vicine allo spirito degli originali di Chuck Berry, grintosa ma rispettosa il giusto. A proposito di impeccabilità e approccio cool un altro che ne ha fatto un’arte è Sonny Landreth, che munito di bottleneck imbastisce una versione impeccabile della sofisticata Havana Moon, e niente male, per usare un eufemismo, una versione “fumante” e a tutto fiati e chitarre di Promised Land, con Tinsley Ellis e Mike che se le “suonano” a colpi di riff, per lasciare poi spazio ad una sorprendente Down Bound Train (ovviamente non quella di Bruce Springsteen) dove Alex Skolnick dei metallari Testament, si reinventa jazzista, ma cita all’inizio del brano anche gli Zeppelin di Dazed And Confused. Sempre a proposito di trucidoni anche Richard Fortus dei nuovi Guns N’ Roses non se la cava affatto male in una pimpante e canonica Maybellene, dimostrando che Berry negli anni ha influenzato quelle decine di migliaia di musicisti, anche quelli “esagerati”; l’altra recente scoperta di Zito, la texana Ally Venable duetta con il suo mentore in una potente School Days, e anche se la voce non è il massimo, la chitarra viaggia alla grande, insieme a Joanna Connor una delle poche signore presenti.
Kirk Fletcher e Josh Smith fanno coppia in una Brown Eyed Handsome Man che sembra provenire da una qualche perduta sessione dei Rockpile, e a proposito di R&R ad alta gradazione di ottani, un altro che conosce a menadito la materia è Tommy Castro alle prese con una Reelin’ and Rockin dove lui e Zito sembrano due gemelli separati alla nascita. Altro veterano che si trova alla grande in questa materia, direi come un pisello nel suo baccello, è Jimmy Vivino, che si spara giù una versione di Let It Rock da arresto per superati limiti di velocità, con la sezione fiati che imperversa ancora una volta, come pure il piano. Mancano solo Thirty Days con un arrapatissimo Albert Castiglia a cantarcele e suonarcele ancora una volta a tempo di R&R, sparando riff a destra e manca, e per chiudere, una “strana” My Ding A Ling, la famosa eulogia di Berry al suo pisello (non il vegetale di cui sopra), che gli americani chiamano una novelty song, ovvero doppi sensi a iosa, in ogni caso Kid Andersen (e Zito) l’hanno trasformata in una party song con qualche elemento doo-wop, con divertimento assicurato, che era poi la missione, riuscitissima, di questo album, un piccolo, ma neanche troppo, gioiellino. Se amate il R&R e le chitarre, qui c’è molta trippa per gatti, tutta di prima qualità.
Bruno Conti