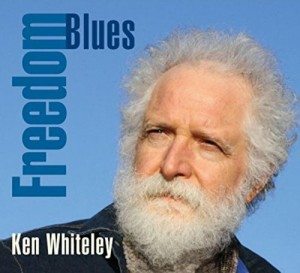Dolly Parton/Emmylou Harris/Linda Ronstadt – The Complete Trio Collection – Rhino/Warner 3CD
Nel 1987 uscì un po’ in sordina (ma non dimentichiamo che gli anni ottanta furono il nadir di un certo tipo di country tradizionale) un disco accreditato a due regine del country americano (Dolly Parton ed Emmylou Harris) ed una del country-rock (Linda Ronstadt): intitolato semplicemente Trio, quell’album fu un successo strepitoso ed inatteso, e si piazzò al numero uno della classifica di Billboard, vincendo anche un Grammy e vendendo ben quattro milioni di copie. Ed il successo fu pienamente meritato, in quanto Trio era un grande disco di country purissimo, con le tre cantanti in forma eccellente, una scelta di canzoni notevole ed una lista di musicisti in session impressionante (c’è da leccarsi i baffi solo a leggere i nomi: Ry Cooder, David Lindley, Herb Pedersen, Albert Lee, Russ Kunkel, Leland Sklar, Bill Payne, Mark O’Connor). Per il seguito, Trio II, si dovettero attendere ben dodici anni: l’album inizialmente era previsto per il 1994, ma problemi della Harris e della Parton con le loro case discografiche fecero slittare il tutto (e la Ronstadt pubblicò cinque di quelle canzoni, remixate e senza le voci delle due amiche, nel suo album del 1995, Feels Like Home); Trio II, alla fine uscì nel ’99, prodotto come il primo volume da George Massenburg, non fu un successo come il suo predecessore, né era a quel livello artistico, ma comunque un ottimo album di country d’autore, anche se meno spontaneo del primo e con qualche leggera concessione al mainstream: anche qui la lista dei musicisti era degna di nota, con gente come Alison Krauss, David Grisman, Dean Parks, Ben Keith, Jim Keltner ed ancora Lindley. (Piccolo inciso: sempre nel 1999, solo qualche mese dopo, usci uno splendido album in duo di Emmylou e Linda, intitolato Western Wall: The Tucson Sessions, superiore anche al secondo Trio).
Era da tempo che si parlava di una ristampa con inediti dei due album, ed oggi finalmente la Rhino ci consegna questo stupendo triplo, che comprende i due Trio album nei primi due dischetti, ed un terzo con venti brani, dei quali solo due erano già noti, tre remix di pezzi dei due dischi, ma ben quindici outtakes mai sentite prima d’ora, una serie di canzoni fatte e finite che sembrano un album nuovo a tutti gli effetti. Intanto fa un immenso piacere risentire i primi due lavori: del primo, per lo più acustico, suonato alla grande e cantato splendidamente, vorrei ricordare la stupenda apertura di The Pain Of Loving You, un brano della Parton ma cantato da Emmylou, country cristallino e purissimo, l’honky-tonk lento di Making Plans, la strepitosa e toccante ripresa di To Know Him Is To Love Him di Phil Spector, con uno splendido assolo “hawaiano” di Lindley e con Cooder che ricama da par suo, o ancora il capolavoro di Dolly Wildflowers, tra le più belle del disco, o con Linda che si destreggia alla grande con Hobo’s Meditation di Jimmie Rodgers (e che classe), senza dimenticare le scintillanti riletture di Telling Me Lies di Linda Thompson (meravigliosa) o dei traditionals Rosewood Casket e la celeberrima Farther Along. Trio II è, come già detto, un gradino più sotto, ma avercene di dischi così: la purissima Lover’s Return della Carter Family apre l’album, seguita dalla struggente High Sierra, dove le armonizzazioni delle tre cantanti raggiungono vette paradisiache, la soave Do I Ever Cross Your Mind (di Dolly ma cantata dalla Harris), e dal superclassico di Neil Young After The Gold Rush, dove invece domina la Parton.
Per finire con la grandissima Feels Like Home, forse la più bella canzone scritta da Randy Newman negli ultimi trent’anni, alla quale viene riservato un trattamento sontuoso. Il terzo dischetto, intitolato Unreleased & Alternate Takes, Etc., oltre a presentare tre remix inediti (I’ve Had Enough, Lover’s Return e Farther Along) e due pezzi già presenti in due album del 1979 e del 1981 della Harris (la splendida Even Cowgirl Get The Blues di Rodney Crowell e Mr. Sandman, entrambe incluse in quanto Dolly e Linda erano presenti in qualità di ospiti), contiene come ho già detto ben quindici tra versioni alternate ed inediti assoluti: non è il caso di citarle tutte, lascio a voi il piacere di scoprirle (tanto non ce n’è mezza da buttare), ma mi limito a citare quelle a mio parere indispensabili, a cominciare da una versione a tre voci e maggiormente strumentata di Wildflowers, forse ancora più bella di quella del primo Trio, seguita a ruota dalla deliziosa Waltz Across Texas Tonight (scritta da Emmylou con Crowell), in una strepitosa versione del 1994 mai sentita, la delicata Softly And Tenderly, per sole voci, chitarra, mandolino e cello, la squisita Pleasant As May della Parton, che non avrebbe sfigurato sul primo album delle tre, una versione alternata di My Dear Companion forse superiore anche a quella pubblicata nel 1987, il trascinante country-gospel di Pops Staples You Don’t Knock (mi chiedo come abbia fatto a rimanere inedita fino ad oggi), il country purissimo di Are You Tired Of Me e l’intensissima In A Deep Sleep della cantautrice irlandese Triona Ni Dhomhnaill della Bothy Band, con una prestazione vocale superlativa della Ronstadt.
Per completezza devo segnalare che è uscita anche una versione singola, ma secondo me con poca ragione di esistere in quanto racchiude il meglio dei primi due album ed aggiunge la miseria di quattro inediti dal terzo dischetto. Difficilmente potremo avere in futuro un Trio III, date le gravi condizioni di salute di Linda, affetta dal morbo di Parkinson: ragione in più per accaparrarsi The Complete Trio Collection senza indugi. Ancora oggi dischi country di questo livello se ne sentono pochi.
Marco Verdi