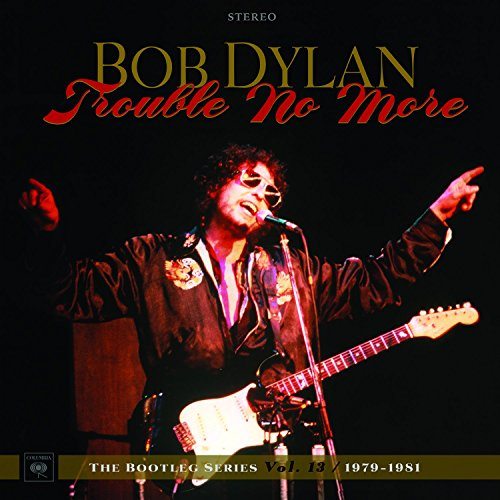J.J. Cale – Stay Around – Because Music/Universal CD
Quest’anno nella mia personale classifica dei dieci dischi migliori usciti nel corso degli ultimi dodici mesi ho inserito ben due album postumi, l’emozionante Thanks For The Dance di Leonard Cohen ed il lavoro di cui mi accingo a parlare: Stay Around di J.J. Cale (che all’epoca della sua uscita, fine Aprile, non è stato recensito sul blog come mi ha ricordato Bruno, probabilmente per un classico caso di “lo faccio io-lo fai tu-non lo fa nessuno”). A differenza però del disco finale di Cohen, che è stato creato dal figlio Adam partendo da tracce vocali del padre al quale sono state poi aggiunte musiche registrate per l’occasione, l’album di Cale si compone di brani incisi dal musicista dell’Oklahoma nel corso degli anni e da lui prodotti e mixati ma poi lasciati in un cassetto. Il periodo indicativo delle varie registrazioni di Stay Around va dalla fine degli anni ottanta all’inizio dell’attuale secolo, ed i 15 brani sono stati selezionati dalla moglie di Cale, Christine Lakeland (musicista a sua volta) e masterizzati dal grande Greg Calbi: la Lakeland non ha dovuto aggiungere nulla, le canzoni erano già belle che pronte, ma la selezione è stata fatta con tale cura ed amore che Stay Around non sembra per nulla una collezione di outtakes, ma un disco pensato per essere pubblicato così com’è.
Già avere un nuovo lavoro ascritto a Cale a dieci anni da Roll On è una bella notizia (dalla sua morte improvvisa nel 2013 per infarto non era ancora stato pubblicato nulla), ma che fosse possibile ascoltare un album di questa qualità era aldilà di ogni più ottimistica previsione, in quanto (almeno a mio parere) siamo di fronte ad un disco che si pone tranquillamente nella Top Five del barbuto songwriter e chitarrista (*NDB A questo link trovate la Top 8 che gli avevo dedicato poco prima dell’uscita dell’album sia sul Buscadero che sul Blog https://discoclub.myblog.it/2019/04/19/in-attesa-del-nuovo-album-stay-around-in-uscita-il-26-aprile-ecco-8-dischi-da-avere-se-amate-la-musica-di-jj-cale-parte-i/ e in una rarissima circostanza, nel banner pubblicitario della etichetta Because Music, a fianco di Mojo e Uncut, era stato citato appunto anche il Buscadero) . Stay Around vede infatti il nostro cimentarsi con una serie di canzoni di primissima scelta (tutte scritte da lui tranne My Baby Blues che è della Lakeland) nel suo tipico stile “laidback” tra rock, country e blues, un suono che Cale avrebbe potuto sostenere di avere praticamente inventato se non fosse stato una persona di una modestia rara.
In più, nel disco troviamo una serie di sessionmen formidabili, nomi di primissimo piano che chi legge queste pagine virtuali conosce alla perfezione: David Briggs, Kenny Buttrey, Bobby Emmons, Tim Drummond, Spooner Oldham, Jim Keltner e Reggie Young. Lights Down Low fa iniziare il CD in modo eccellente con un saltellante country-blues suonato in punta di dita, in cui il mix elettroacustico delle chitarre con il piano elettrico è goduria pura; Chasing You è una canzone mossa ed allegra, quasi rock’n’roll, con Cale che canta in modo diretto una melodia vincente (forse il nostro non aveva una voce straordinaria, ma era perfettamente adeguata al suo concetto di laidback music), ed è seguita da Winter Snow, blues elettroacustico di stampo rurale nel tipico stile di J.J. La title track è un mezzo capolavoro, una slow ballad che profuma di country, suonata in maniera fantastica e cantata in maniera quasi sussurrata (con la voce che doppia sé stessa): grandissima classe.
Tell You ‘Bout Her ha una ritmica insinuante ed uno sviluppo a metà tra rock e jazz (per non parlare della solita performance chitarristica di grande finezza, ma dovrei dirlo ad ogni brano), uno dei pezzi più immediati del CD; splendida la folkeggiante Oh My My, eseguita in totale solitudine da J.J., voce e chitarra acustica, ma con un feeling enorme ed una mastria unica nel far scorrere le dita sul manico, mentre My Baby Blues è un rock-blues elettrico e decisamente trascinante, anche se come al solito Cale non perde il suo aplomb. Girl Of Mine è un godurioso blues acustico che ci porta idealmente sulle rive del Mississippi, Go Downtown è una suggestiva ballatona d’atmosfera nella quale si capisce da dove ha preso spunto Mark Knopfler per dare un suono ai suoi Dire Straits, If We Try è ancora uno slow acustico che sa di country e blues, puro e cristallino. La jazzata e cadenzata Tell Daddy, in cui il pianoforte ha un ruolo importante, è un brano di classe sopraffina che precede la bucolica Wish You Were Here, dall’ennesimo magistrale lavoro chitarristico, e la ritmata e coinvolgente Long About Sundown, puro Cale (un pezzo che Eric Clapton potrebbe far suo senza problemi). Il CD si chiude con la melodia orecchiabile di Maria, dal sapore vagamente latineggiante, e con la rilassata e suadente Don’t Call Me Joe.
Stay Around è quindi il miglior testamento musicale possibile per l’esimio J.J. Cale, un lavoro ispiratissimo e di grande livello artistico: se ve lo siete perso non è mai troppo tardi per rimediare.
Marco Verdi