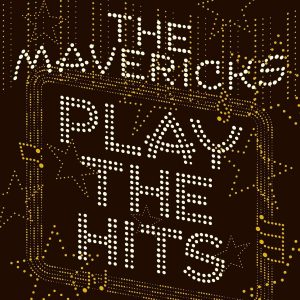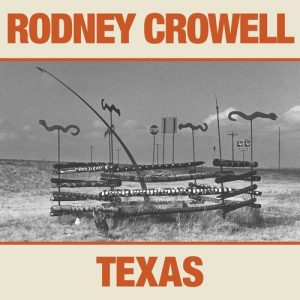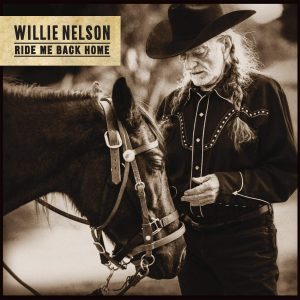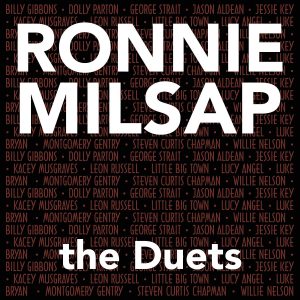Brantley Gilbert – Fire & Brimstone – Valory/Universal CD
Brantley Gilbert, musicista nativo della Georgia, dopo aver esordito nel 2009 con un album dalle vendite incerte (Modern Day Prodigal Son), ha capito in fretta come funziona il giochino a Nashville ed in breve tempo è diventato uno degli artisti country più popolari d’America, con ben tre album di fila andati al numero uno della classifica, compreso quello di cui mi accingo a scrivere. Il nostro ha infatti smesso molto presto di fare musica di qualità preferendo la via più facile: ha saputo entrare nel giro giusto circondandosi così di produttori di grido, sessionmen che vanno a lavorare timbrando il cartellino e mettendo a punto degli album di pop radiofonico travestito da country, che però è il genere che dalle parti della capitale del Tennessee ti fa volare alto nelle classifiche.
Fire & Brimstone, il nuovo CD di Gilbert, non si distacca dalla mediocrità congenita che è ormai la sua carriera, e dal suo punto di vista Brantley ha anche ragione: ho trovato il filone d’oro, perché mai dovrei cambiare? Musica anonima dunque, canzoni fatte con lo stampo con una strumentazione infarcita di suoni finti, all’insegna di synth, loop vari e drum programming a go-go. Anche l’approccio del titolare del disco è piuttosto molle, senza grinta, come se già sapesse che basta il minimo sindacale di impegno per avere successo: il risultato finale è un lavoro che ha ben poco di interessante per chi ama il vero country, con l’aggravante di essere anche piuttosto lungo. L’inizio è appannaggio di Fire’t Up, un rockin’ country elettrico che ad un ascolto distratto potrebbe sembrare aggressivo e grintoso, ma qualcosa non quadra: i suoni sono infatti finti, poco spontanei e pieni di effetti, ed il tutto va a scapito dell’immediatezza. Not Like Us, ancora dura e chitarristica, è un po’ meglio dal punto di vista del suono anche se non sono del tutto convinto: l’assolo è decisamente hard e poi comunque la canzone è deficitaria dal punto di vista dello script.
Anche Welcome To Hazeville, una ballata qualsiasi e per di più con un drumming che sa di sintetico, non è niente di speciale, e dispiace che in una tale pochezza siano stati coinvolti il bravo Lukas Nelson e soprattutto il leggendario padre Willie (che però si limita a cantare una breve frase alla fine), per di più insieme al rapper Colt Ford: in poche parole, un pasticcio brutto e musicalmente criminale. What Happens In A Small Town sembra la continuazione del brano precedente, e devo guardare il lettore per capire che la traccia è cambiata (ed il refrain è puro pop commerciale), She Ain’t Home prosegue con banalità un tanto al chilo, una ballata buona per chi non sa neanche cosa sia il vero country, Lost Soul’s Prayer è bruttina e ha un arrangiamento finto-rock che non va da nessuna parte. Il disco come ho già detto è pure lungo, 15 canzoni, ed in certi punti è una sofferenza: fra i pezzi rimanenti salvo solo Tough Town, che se non altro ha un buon tiro rock ed i suoni abbastanza sotto controllo, la title track, ballata elettroacustica nobilitata dalla presenza di Jamey Johnson ed Alison Krauss (ed anche la canzone non è malaccio, forse la migliore del CD), l’orecchiabile Bad Boy e la discreta Man Of Steel, dalle (molto) vaghe atmosfere western.
Il resto però è da mani nei capelli, almeno per chi li ha ancora.
Marco Verdi